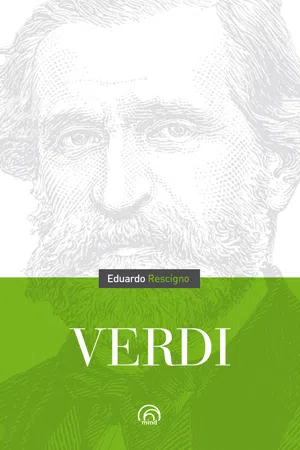eBook - ePub
Verdi
Informazioni su questo libro
La vita di un uomo che ha svariati motivi d'interesse per noi: qualcosa di più o per lo meno di diverso di un semplice musicista. In qualche momento della sua vita ci appare come un abile imprenditore, che utilizza il talento di operista per metterne a frutto i guadagni nell'ambito dell'attività di proprietario terriero, attento a scovare i più aggiornati sistemi di coltivazione per riuscire a dar lavoro al maggior numero di contadini e operai. E poi, ancora, un uomo attento a non disperdere il patrimonio e, in vista del congedo dalla vita, capace di metterlo a frutto realizzando importanti opere di utilità sociale, come la Casa di riposo per musicisti e l'Ospedale di Villanova, entrambi attivi tuttora. Ne possiamo seguire la vita attraverso stralci dalle sue moltissime lettere, la cui lettura ci mostra un'insolita eleganza di stile e una straordinaria capacità di sintesi: potremmo pensare a lui come a uno fra i maggiori scrittori del secondo Ottocento. Ma sappiamo, nel contempo, che è stato il creatore di personaggi che fanno ormai parte della nostra esistenza e non solo di noi italiani.
Tools to learn more effectively

Saving Books

Keyword Search

Annotating Text

Listen to it instead
Informazioni
Categoria
Biografie in ambito musicaleUna risoluzione irremovibile
Da qualche tempo Verdi era proprietario della casa di campagna che si trovava nella tenuta di Sant’Agata, non lontana da Busseto, dove però continuava ad abitare nel confortevole, anche elegante palazzo Dordoni; almeno per il momento non era il caso di trasferirsi in mezzo ai polli e a tutti gli attrezzi contadini. Per Sant’Agata bisognava pensare a degli adattamenti, o addirittura a delle trasformazioni, prima di poterci abitare. Nel frattempo, in attesa di iniziare i lavori di restauro, Verdi aveva mandato a Sant’Agata i genitori, e il padre mandava avanti in qualche modo i più essenziali lavori della campagna. Ma questa sistemazione, certamente considerata provvisoria, divenne ben presto fonte di discussioni e dissapori.
Nei primi mesi del 1851, cioè mentre stava per andare in scena il Rigoletto a Venezia, uno scambio di corrispondenza fra Verdi e il notaio Balestra ci mette al corrente di questa piccola bega, che ci svela un aspetto tipico del carattere verdiano; l’esigenza, «costi quel che costi», di mettere tutto in chiaro, di non lasciarsi andare al sentimentalismo, ma di codificare ogni rapporto umano in base a precise regole di comportamento. Da notare anche che lo scambio di corrispondenza col notaio non avveniva fra due città diverse, ma nella stessa Busseto: evidentemente Verdi, nei rapporti col notaio, preferiva mettere su carta quello che invece, detto a voce, poteva essere frainteso.
La prima lettera di Verdi è del 21 gennaio (fra 50 giorni va in scena Rigoletto), e chiarisce subito gli estremi del problema: «Da fonte sicura ho saputo che mio padre va spacciando essere state accomodate le cose col di Lei mezzo in uno dei seguenti modi, cioè: che io avrei accordato al detto mio padre l’amministrazione de’ miei fondi, oppure glieli darei in affitto. Non credo siavi stata fra me e Lei Sig. Dottore mala-intelligenza, né credo ch’Ella abbia proposto alcuna di queste cose, nonostante amo ripeterle per maggior mia quiete, che io non accondiscenderò mai a questi due progetti. Io intendo di essere diviso da mio padre e di casa e di affari: infine non posso che ripetere quanto le dissi ieri a voce: presso il mondo Carlo Verdi deve essere una cosa, e Giuseppe Verdi un’altra».
Un figlio, quindi, duro e severo, non affatto disposto a dare qualcosa al padre: ma aveva le sue buone ragioni, anche se erano buone ragioni di natura strettamente economica. Infatti, in un’altra lettera al notaio, vediamo affiorare quello che era qualcosa di più che un segreto timore. Il 31 gennaio (fra 40 giorni va in scena Rigoletto) Verdi scrive: «Uno delle Roncole soprannominato Piga mi ha fatto parlare per un credito di circa 22 franchi che ha verso mio padre. Io gli feci rispondere di rivolgersi a Lei, che, riconosciuto il debito, sarà pagato. La prego dunque Sig. Dottore di esaminare questa piccola faccenda. La pregherò altresì di pagare a mio padre la somma che crederà conveniente pel mese di febbraio. Desidero che questi si risolva ad accettare uno dei partiti offertigli, perché se al mio ritorno da Venezia le cose non saranno accomodate definitivamente io ne prenderò uno dei partiti che non sarà forse sì vantaggioso per Lui. Vorrei bene che mio padre si persuadesse che la risoluzione di dividermi da Lui di casa e di affari è irremovibile, perché presa dopo serie e mature riflessioni».
Siamo solo nella prima fase, nell’introduzione; la gran scena, il tragico e drammatico quartetto – Verdi, il notaio, il padre e anche la madre – deve ancora iniziare; ed inizia proprio con un riferimento alla madre, per una questione di polli e di uova. È il 5 febbraio (fra 38 giorni va in scena Rigoletto): «Spiacemi questa malintelligenza! A mia madre lasciai il diritto pel pollaio quando eravamo uniti, ora che siamo divisi è ben naturale che questo diritto ritorni a me. Circa 15 giorni fa la Brunelli mi domandò a chi doveva per l’avvenire portare il prodotto del pollaio, io risposi: qui nella casa di Busseto. Ecco tutto! Non diedi quest’ordine per spilorceria, ma perché non voglio lasciare ai miei alcun diritto né piccolo né grande». È un atteggiamento duro, severo, ma controllato; ma quando entra in scena il padre, Verdi sembra perdere il controllo dei nervi: «Dica pure francamente a mio padre che io sono stanco di tutte le scene che va facendo, e tutte le sue violenze non condurranno che a farmi prendere un partito ruinoso e per me e per lui. Io venderò tutto a qualunque siasi prezzo, ed abbandonerò per sempre questi paesi!». Sembra Silva nell’Ernani, il quale non potendo aver per sé Elvira, decide la morte di Ernani, il giorno stesso del matrimonio fra i due.
Verdi non prenderà il partito «ruinoso» di vender tutto, ma farà stilare dal notaio un compromesso, in data 8 febbraio (fra 35 giorni va in scena Rigoletto), nel quale si stabilisce la divisione fra Verdi e i genitori; egli poi si impegna a versar loro una pensione annua di lire milleottocento, oltre a un cavallo, a condizione però che essi lascino libera la casa di campagna entro l’11 marzo, o eccezionalmente entro l’11 maggio. Se questa clausola non verrà rispettata, anche le altre verranno a cadere.
Ai genitori, chissà in quale stato d’animo, non resta che fare fagotto e lasciare Sant’Agata; e mentre a Venezia Felice Varesi canta il proprio strazio di padre, gobbo e buffone, laggiù, a Sant’Agata, due vecchi lasciano spazio al figlio glorioso che intende essere l’unico padrone di quanto aveva comprato con il proprio lavoro e con il proprio denaro.
Il giardino della Peppina
Nel maggio 1851 Verdi, insieme alla Strepponi, si trasferì nella casa di Sant’Agata quando questa non era ancora sistemata, ma era appena stata lasciata libera dai genitori. I lavori di restauro durarono alcuni anni, e dopo neppure un mese ci fu anche la visita dei ladri. «Oltre il danno del furto – scrisse a Piave – c’è la noia delle visite di pretori, marescialli, gendarmi ecc. ecc. e ti puoi immaginare la mia bile. Che io non abbia mai ad avere un po’ di quiete?! Io t’aspetto a Busseto ma vorrei ritardassi un poco. Da un mese circa i muratori, falegnami e cose simili ecc. ecc. lavorano per mia disgrazia nella mia casa, non hanno ancora finito e tu non sapresti dove annicchiarti intanto. Aspetta addunque un poco e porta teco il tuo buon umore, perché qui in questa solitudine spaventosa ne avrai molto bisogno».
Verdi era di umor nero, anche perché stava attraversando un periodo di difficoltà economiche, per le molte spese affrontate, e perché non aveva ancora chiaro quale sarebbe stata l’opera nuova dopo il Rigoletto. Ma già nasceva in lui il gusto, il piacere della campagna, il dolce senso del possesso; e ce ne facciamo un’idea leggendo una lettera di Giuseppina, di molto posteriore (1867), in cui quei primi anni di vita in campagna rivivono con affettuosa ironia: «Comperò il latifondo di S. Agata… – scrive a Clarina Maffei. – Si cominciò con infinito nostro piacere a piantare un giardino, che in principio fu detto il giardino della Peppina. Poi si allargò e fu chiamato il suo giardino; e ti posso dire che in questo suo giardino vi zareggia or tanto ch’io sono ridotta a pochi palmi di terreno, sui quali egli non ha per condizioni stabilite il diritto di ficcar il naso. […] Questo giardino, che s’andava allargando ed abbellendo, domandava una casa un po’ meno colonica; Verdi si trasformò in architetto, e non ti posso dire, durante la fabbrica, le passeggiate, i balli dei letti, dei comò e di tutti i mobili. Ti basti che, eccettuato in cucina, in cantina e nella stalla, noi abbiam dormito e mangiato in tutti i buchi della casa».
Alla ricerca di un teatro
Colono, architetto; ma ancora operista, naturalmente, alle prese con un nuovo argomento da affidare al librettista Cammarano, per il quale Verdi aveva grande considerazione. Napoletano, era nato nel 1801; suo nonno Vincenzo, di origine siciliana, era attore, e col soprannome di Giancola fu per trent’anni un acclamato Pulcinella al Teatro San Carlino di Napoli; due zie, Domenica e Caterina, erano attrici e cantanti, lo zio Michele era tenore, e lo zio Antonio pittore paesaggista. Un altro zio, Filippo, era attore, apprezzato commediografo, librettista e compositore, ed ebbe tre figlie, tutte attrici; una di queste, Rosalinda, fu madre della nota attrice Adelaide Negri, a sua volta madre dell’attore Armando Falconi. Il padre di Salvadore, Giuseppe, fu uno dei maggiori esponenti della pittura neoclassica napoletana, e fra le sue molte opere si ricorda la decorazione della volta del Teatro San Carlo eseguita nel 1816 che raffigura Apollo che presenta a Minerva i maggiori poeti, da Omero ad Alfieri. Tra i fratelli di Salvadore si ricordano Vincenzo e Giovanni, entrambi miniaturisti, e soprattutto Luigi, compositore, autore di opere alcune delle quali su libretto del fratello. Salvadore studiò pittura, e fu allievo della Scuola di scenografia istituita nel 1816 al Teatro San Carlo dall’architetto Antonio Niccolini. In questo stesso periodo fu allievo del poeta e improvvisatore Gabriele Rossetti e dell’abate Quattromani; malgrado gli inizi promettenti, l’attività di pittore venne messa in secondo piano per l’interesse sempre più vivo per la poesia e il teatro. Intorno al 1825 Cammarano comincia a lavorare per il Teatro San Carlo come scenografo, e nel 1831 diventa direttore di palcoscenico; nel 1832, alla morte del poeta del Teatro San Carlo Domenico Gilardoni, pensa di potergli succedere, e scrive il suo primo libretto, Belisario, che tuttavia non piace all’impresario Barbaia e quindi non viene musicato. L’ostilità del grande impresario rende difficile l’attività di Cammarano, il quale deve attendere il 1834 per vedere musicato un proprio libretto, La sposa, da un musicista di secondo piano come Enrico Vignozzi. Intanto collabora con Felice Romani nella stesura di un libretto per Saverio Mercadante, Francesca Donato, rappresentata al Teatro Regio di Torino il 10 febbraio 1835. Pochi giorni dopo, il 23 febbraio, gli nasce il figlio Michele, che diventerà un notevole pittore di scene di vita popolare caratterizzate da vigorosa impronta drammatica.
Intanto, in quello stesso anno 1835, Barbaia lascia l’impresa del San Carlo – gli succede una «Società di industria e belle arti» – e Cammarano coglie il suo primo successo, complice Maria Malibran, con la Ines de Castro, scritta in collaborazione con Giovanni Emmanuele Bidera, musica di Giuseppe Persiani, accolta trionfalmente al San Carlo il 27 gennaio 1835. Sul finire dello stesso 1835, il 26 settembre, il successo viene ampiamente confermato dalla Lucia di Lammermoor donizettiana.
Ormai riconosciuto come il miglior librettista attivo a Napoli, Cammarano scrive altri sette libretti per Donizetti, cinque per Giovanni Pacini, dieci per Saverio Mercadante, e molti altri per compositori minori. Nel 1845 aveva scritto il primo libretto per Verdi, Alzira, cui seguirono nel 1849 La battaglia di Legnano e Luisa Miller.
Sfumata la possibilità di collaborare con lui per il dramma di Victor Hugo Le Roi s’amuse (sarebbe diventato il Rigoletto, verseggiato da Piave e destinato alla Fenice di Venezia), Verdi mantenne con lui frequenti contatti epistolari, che il 2 gennaio 1851 si concretizzarono nel primo accenno al soggetto del Trovatore: «L’argomento che desidererei e che vi propongo si è El Trovador dramma spagnuolo di Guttierez. A me sembra bellissimo; immaginoso e con situazioni potenti. Io vorrei due donne: la principale la Gitana carattere singolare, e di cui ne trarrei il titolo dell’opera: l’altra ne farei una comprimaria. Fate voi che siete quell’ometto che siete... ma fate presto». Per la prima volta nell’attività di Verdi un’opera nuova viene scelta, decisa e progettata con il librettista prima ancora che esista un contratto con un teatro o con un editore; è quello che stava accadendo anche con il Re Lear, con la differenza che l’opera shakespeariana rimase allo stato di progetto, mentre il dramma di Gutierrez giunse regolarmente alle scene.
Dopo l’impegno preso con Cammarano, il primo pensiero di Verdi fu dunque di trovare un teatro per la nuova opera. Ne parlò con l’impresario Alessandro Lanari per Bologna, ne parlò nuovamente con l’impresa del San Carlo, poi con Antonio Gallo per la Fenice di Venezia, infine con Vincenzo Jacovacci per il Teatro Apollo di Roma, senza giungere ad alcun accordo. Intanto procedeva il lavoro di stesura del «programma», che giunse a Verdi all’inizio di aprile. Subito dopo Cammarano cominciò a inviare a Verdi, a più riprese, le varie parti del libretto verseggiato via via che le completava. In agosto Cammarano si ammalò, ma proseguì il lavoro assistito dal giovane Bardare, e lo concluse in novembre. Pressappoco negli stessi giorni in cui Verdi riceveva le ultime parti del libretto, le trattative con il Teatro Apollo si interruppero, e nel marzo seguente (1852) pareva ormai certo che la nuova opera sarebbe andata in scena al San Carlo. Ma nel giugno di quello stesso 1852 Verdi raggiunse finalmente un accordo con Jacovacci per mettere in scena la nuova opera al Teatro Apollo di Roma intorno alla metà di gennaio del 1853, con la condizione «se la Censura approverà il libretto di Cammarano Il Trovatore». C’erano poi altre condizioni che riguardavano i cantanti, e quindi la trattativa si protrasse per molti altri mesi. Intanto Verdi aveva cominciato ad abbozzare la musica, suggerendo varie modifiche al libretto, ma il 17 luglio 1852 Cammarano morì, e queste vennero realizzate da Bardare.
Spagna, 1409. Il conte di Luna (baritono) ama non riamato Leonora (soprano), la quale ama riamata Manrico (tenore), giovane trovatore e uomo d’arme, supposto figlio di Azucena (mezzosoprano), zingara. I due uomini appartengono a due fazioni contrapposte, e si combattono aspramente. In una breve pausa degli eventi bellici Manrico sposa Leonora, mentre Azucena è arrestata dal Conte e condannata al rogo perché accusata di aver ucciso in culla un fratello del Conte. Alla vista delle fiamme, Manrico accorre in soccorso di Azucena, viene a sua volta arrestato, mentre Leonora si offre al Conte in cambio della vita dell’amato Manrico. Ma quando il Conte si accorge che Leonora si è avvelenata, fa decapitare Manrico, mentre Azucena gli rivela: egli era tuo fratello.
Intorno al mese di agosto 1852 il libretto finito venne consegnato per l’approvazione alla censura pontificia, che richiese una serie di interventi: l’eliminazione di ogni riferimento alla religione (Leonora non cercherà di farsi monaca, ma semplicemente andare in un ritiro, e devono essere mutate le parole del Miserere); la soppressione del suicidio di Leonora (il soprano morirà di dolore); infine l’eliminazione o l’attenuazione dei riferimenti alla guerra civile fra seguaci di Urgel e sostenitori del re di Aragona. Modifiche che vennero accolte nel libretto stampato per la prima romana, ma non vennero riportate né sulla partitura né sul libretto definitivo che nello stesso periodo stava stampando l’editore Ricordi.
La compagnia di canto venne definita e approvata nel novembre, e solo a questo punto il compositore firmò il contratto. Lasciando Sant’Agata diretto a Roma, Verdi scrisse all’amico Luccardi: «il Trovatore è completamente finito: non manca nemmeno una nota, e, (inter nos), ne sono contento». Verdi, che di solito usava terminare la strumentazione nel corso delle prove, questa volta, quando giunse a Roma intorno al primo gennaio 1853, portava con sé una partitura completa, per una ragione molto precisa, che vedremo fra poco.
L’opera, andata in scena il 19 gennaio 1853, ebbe un’ottima accoglienza, malgrado qualche riserva sulla condizione del mezzosoprano e del baritono, che peraltro si ripresero nelle successive esecuzioni. Unico appunto che venne mosso a Verdi fu l’eccessiva tetraggine del finale che, «urtando la sensibilità nervosa dei cuori troppo delicati», come scrisse il recensore della Gazzetta musicale di Milano, lasciò un po’ fredda una parte del pubblico. Ma Verdi era perfettamente consapevole del colore cupo dell’opera, e scrivendo alla contessa Maffei, dopo aver minimizzato il successo aggiunse: «dicono che quest’opera sia troppo triste e che vi siano troppe morti. Ma infine nella vita tutto è morte! Cosa esiste?...».
La Dame aux camélias
Un altro momento di umor nero, forse; oppure di stanchezza. Quelle parole vennero scritte a Clarina il 29 gennaio, cioè dieci giorni dopo la prima del Trovatore, ma anche soltanto trentatré giorni prima dell’andata in scena dell’opera successiva, La traviata. Ecco spiegato il motivo per cui la partitura del Trovatore era del tutto finita nel momento in cui Verdi giunse a Roma; infatti, nella lettera già ricordata a Luccardi, si leggono anche queste altre parole: «va da Jacovacci che ti darà un pianoforte e fallo mettere nella mia stanza da studio, onde, appena arrivato, possa scrivere l’opera per Venezia senza perdere un minuto di tempo». E, per la storia di quest’opera, bisogna fare un passo indietro.
La sera del 2 febbraio 1852, al parigino Théâtre du Vaudeville, si rappresenta il nuovo dramma che Alexandre Dumas figlio ha tratto dal suo fortunato romanzo pubblicato nel 1848, La Dame aux camélias: una commedia che, malgrado la notorietà del romanzo e il fascino straordinario della protagonista, Charlotte-Marie de Plunkett, in arte Madame Doche, venne accolta con un successo contrastato, determinato soprattutto dalla scabrosità del tema, che infatti diede luogo a una serie di spettacoli parodistici in cui si sconsigliava ai giovani parigini di frequentare ragazze di piccola virtù, e soprattutto di innamorarsene. Anche un popoloso deserto come Parigi ha le sue vanità moralistiche, e sulle scene non accetta facilmente l’amore e la redenzione di una cortigiana, anche se riscattata dalla morte.
Verdi e la Strepponi erano in quei giorni a Parigi, e tutto fa credere che la donna, appassionata di teatro e di avvenimenti mondani, abbia convinto Verdi ad assistere a quello spettacolo; uno spettacolo che, oltre tutto, stabiliva un sia pur labile rapporto fra il dramma d’amore che si vedeva sulle scene e la particolare situazione personale di Verdi, alle prese con i molti pettegolezzi che nell’ambiente di Busseto aveva provocato il suo soggiorno, nel Palazzo Dordoni, con la Strepponi, non ancora sua moglie. Tuttavia, anche se tre anni dopo l’editore francese di Verdi, Léon Escudier, testimoniò la presenza del musicista a quello spettacolo, non abbiamo alcuna prova di una presenza di Verdi al Théâtre du Vaudeville; e anzi, verificando quello che accadde nei mesi successivi, si deve pensare che Verdi non vide quella commedia, e forse non ne ebbe alcuna notizia.
Infatti, in quegli stessi giorni, e per la precisione il 24 gennaio, il Presidente agli Spettacoli del Teatro La Fenice, Carlo Marzari, scrive a Verdi per incaricarlo di comporre un’opera nuova per il teatro veneziano nella Stagione 1852-53; e Verdi il 4 febbraio, sempre da Parigi, gli risponde con una generica accettazione, senza alcun riferimento al soggetto, accettazione subordinata alla definizione della compagnia di canto. Un argomento, questo, che sarà oggetto di un estenuante dibattito che si protrarrà fino alla vigilia dell’andata in scena della Traviata. Verdi e la Strepponi tornano a Busseto il 18 marzo, e si stabiliscono nella ormai sistemata «casa di campagna» di Sant’Agata; e qui giunge il segretario del teatro veneziano, Guglielmo Brenna, per definire il compenso per Verdi, stabilito in ottomila lire austriache a titolo di noleggio di poesia e musica (la proprietà resta a Verdi), e fissare la data dell’andata in scena, il 26 febbraio 1853. Si discute anche della compagnia di canto, senza giungere ad accordi definitivi, ma ancora non si fa alcun cenno all’argomento dell’opera. La trattativa continua, e il 4 maggio si giunge alla stesura del contratto, che ...
Indice dei contenuti
- Copertina
- Frontespizio
- Colophon
- Sommario
- Da l’umil casa a la conquista di un mondo
- Una risoluzione irremovibile
- Un certo non so che di naturale
- Cronologia
- Opere teatrali
- Bibliografia
Domande frequenti
Sì, puoi annullare l'abbonamento in qualsiasi momento dalla sezione Abbonamento nelle impostazioni del tuo account sul sito web di Perlego. L'abbonamento rimarrà attivo fino alla fine del periodo di fatturazione in corso. Scopri come annullare l'abbonamento
No, i libri non possono essere scaricati come file esterni, ad esempio in formato PDF, per essere utilizzati al di fuori di Perlego. Tuttavia, puoi scaricarli nell'app Perlego per leggerli offline su smartphone o tablet. Scopri come scaricare libri offline
Perlego offre due piani: Essential e Complete
- Essential è l'ideale per studenti e professionisti che amano esplorare un'ampia gamma di argomenti. Accedi alla libreria Essential, che include oltre 800.000 titoli di comprovata qualità e bestseller in vari settori, tra cui business, crescita personale e discipline umanistiche. Include tempo di lettura illimitato e voce standard per la sintesi vocale.
- Complete: perfetto per studenti e ricercatori esperti che necessitano di un accesso completo e illimitato. Accedi a oltre 1,4 milioni di libri su centinaia di argomenti, inclusi titoli accademici e specialistici. Il piano Complete include anche funzionalità avanzate come la sintesi vocale premium e l'assistente di ricerca.
Perlego è un servizio di abbonamento a testi accademici, che ti permette di accedere a un'intera libreria online a un prezzo inferiore rispetto a quello che pagheresti per acquistare un singolo libro al mese. Con oltre 1 milione di testi suddivisi in più di 990 categorie, troverai sicuramente ciò che fa per te! Scopri la nostra missione
Cerca l'icona Sintesi vocale nel prossimo libro che leggerai per verificare se è possibile riprodurre l'audio. Questo strumento permette di leggere il testo a voce alta, evidenziandolo man mano che la lettura procede. Puoi aumentare o diminuire la velocità della sintesi vocale, oppure sospendere la riproduzione. Scopri di più sulla funzione di sintesi vocale
Sì! Puoi utilizzare l'app di Perlego su dispositivi iOS e Android per leggere quando e dove vuoi, anche offline. È perfetta per gli spostamenti quotidiani o quando sei in viaggio.
I dispositivi con iOS 13 e Android 7 o versioni precedenti non sono supportati. Scopri di più su come utilizzare l'app
I dispositivi con iOS 13 e Android 7 o versioni precedenti non sono supportati. Scopri di più su come utilizzare l'app
Sì, puoi accedere a Verdi di Eduardo Rescigno in formato PDF e/o ePub, così come ad altri libri molto apprezzati nelle sezioni relative a Mezzi di comunicazione e arti performative e Biografie in ambito musicale. Scopri oltre 1 milione di libri disponibili nel nostro catalogo.