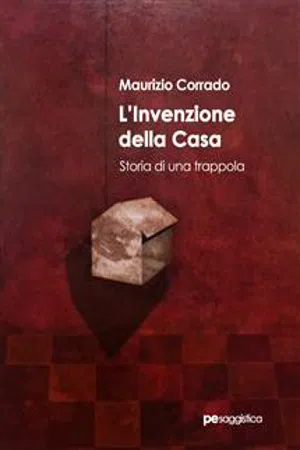
- Italian
- ePUB (disponibile su mobile)
- Disponibile su iOS e Android
eBook - ePub
Informazioni su questo libro
La casa, trecentomila anni senza averne bisogno, poi abbiamo cominciato a coltivare e abbiamo inventato confini, proprietà, capitale e ai larghi orizzonti aperti abbiamo preferito piccoli spazi chiusi. Perché? E sarà per sempre?
Domande frequenti
Sì, puoi annullare l'abbonamento in qualsiasi momento dalla sezione Abbonamento nelle impostazioni del tuo account sul sito web di Perlego. L'abbonamento rimarrà attivo fino alla fine del periodo di fatturazione in corso. Scopri come annullare l'abbonamento.
No, i libri non possono essere scaricati come file esterni, ad esempio in formato PDF, per essere utilizzati al di fuori di Perlego. Tuttavia, puoi scaricarli nell'app Perlego per leggerli offline su smartphone o tablet. Per maggiori informazioni, clicca qui.
Perlego offre due piani: Essential e Complete
- Essential è l'ideale per studenti e professionisti che amano esplorare un'ampia gamma di argomenti. Accedi alla libreria Essential, che include oltre 800.000 titoli di comprovata qualità e bestseller in vari settori, tra cui business, crescita personale e discipline umanistiche. Include tempo di lettura illimitato e voce standard per la sintesi vocale.
- Complete: perfetto per studenti e ricercatori esperti che necessitano di un accesso completo e illimitato. Accedi a oltre 1,4 milioni di libri su centinaia di argomenti, inclusi titoli accademici e specialistici. Il piano Complete include anche funzionalità avanzate come la sintesi vocale premium e l'assistente di ricerca.
Perlego è un servizio di abbonamento a testi accademici, che ti permette di accedere a un'intera libreria online a un prezzo inferiore rispetto a quello che pagheresti per acquistare un singolo libro al mese. Con oltre 1 milione di testi suddivisi in più di 1.000 categorie, troverai sicuramente ciò che fa per te! Per maggiori informazioni, clicca qui.
Cerca l'icona Sintesi vocale nel prossimo libro che leggerai per verificare se è possibile riprodurre l'audio. Questo strumento permette di leggere il testo a voce alta, evidenziandolo man mano che la lettura procede. Puoi aumentare o diminuire la velocità della sintesi vocale, oppure sospendere la riproduzione. Per maggiori informazioni, clicca qui.
Sì! Puoi utilizzare l'app di Perlego su dispositivi iOS o Android per leggere quando e dove vuoi, anche offline. È perfetta per gli spostamenti quotidiani o quando sei in viaggio.
I dispositivi con iOS 13 e Android 7 o versioni precedenti non sono supportati. Scopri di più su come utilizzare l'app.
I dispositivi con iOS 13 e Android 7 o versioni precedenti non sono supportati. Scopri di più su come utilizzare l'app.
Sì, puoi accedere a L'invenzione della casa di Maurizio Corrado in formato PDF e/o ePub, così come ad altri libri molto apprezzati nelle sezioni relative a Architecture e Architecture General. Scopri oltre 1 milione di libri disponibili nel nostro catalogo.
Informazioni
Diecimila anni in casa
Quando è successo che qualcuno, rompendo una tradizione di centinaia di migliaia di anni, ha deciso di costruire uno spazio per sé e il suo gruppo delimitandolo con muri per non lasciarlo più? Quando quello che era sempre stato un riparo stagionale e leggero si è appesantito, ha messo radici e non si è più mosso? Nel lungo processo di trasformazione durato millenni e iniziato intorno al 10.000 a.C. la prima costruzione fissa necessaria alla coltivazione, il granaio, ha fatto da modello per la nascita di un nuovo spazio e per la sua realizzazione fisica. Qualcosa di solido in cui conservare me e i miei averi. La casa.
Cosa la differenzia da ciò che usavo prima? Perché è un’idea nuova? È la prima volta che realizzo confini solidi per contenere il mio spazio e lo chiudo. È la prima volta che separo completamente l’interno dall’esterno. È la prima volta che uso questo spazio continuamente, non solo durante tutto l’anno, ma per lungo tempo, senza mai abbandonarlo. E soprattutto, è la prima volta che carico questo singolo spazio di valori e funzioni che prima avevano vita propria. Quella che nasce è l’idea di casa come sinonimo di famiglia, gruppo, riparo, intimità, protezione, spazio privato, inviolabile, sacro, inattaccabile, segreto.
L’idea che propongono queste pagine è che la ricerca della prima casa, così spesso identificata con la capanna, idea mirabilmente esplorata da Rykwert (1), sia affascinante, ricca di risvolti, feconda, ma sostanzialmente errata. Potrebbe essere sbagliata la domanda. Se la prima casa si identifica con il primo riparo costruito, probabilmente sarà un paravento, una protezione da sole, vento e pioggia. Ma siamo sempre fra le costruzioni mobili, momentanee, provvisorie, smontabili, trasportabili. Lo scatto verso qualcosa d’altro, la vera nascita di ciò che intendiamo come casa si ha quando la costruzione è fissa perché lo sono i suoi utilizzatori. Prima, non si ha casa.
Bruno Zevi, uno dei più importanti storici dell’architettura, ritiene il tema della storia della casa “pressoché ignorato” dalla storia dell’architettura, ribadendo la necessità di rivolgersi ad altre discipline come antropologia, etnologia o storia della famiglia per trovare cenni su come abbiamo vissuto quotidianamente. Basta aprire un qualsiasi testo di storia dell’architettura per rendersi conto che il tema della casa appare quasi sempre solo a metà Ottocento, quando l’arrivo delle masse nelle città diventa un problema. Nello stesso periodo l’ascesa della borghesia diventa un’opportunità, c’è una nuova richiesta di abitazioni confortevoli, adeguate al capitale posseduto ed espressione simbolica di potere. È solo da quel periodo che gli architetti se ne occupano, prima l’architetto lavora quasi esclusivamente su monumenti, chiese e palazzi dei signori. Quello che risulta evidente, guardando all’evoluzione della casa da quando appare nel Neolitico, è che si tratta della modulazione di una stessa tipologia di spazio che, con materiali e forme diverse, arriva indenne fino alla fine dell’Ottocento, si scontra con le esigenze dell’industria che, con la complicità del Movimento Moderno, lo dissolve.
Il fuoco ha generato il nostro spazio sociale. Da quando lo usiamo è lui che crea un confine impalpabile ma reale, generando un’isola protetta in qualsiasi punto dello spazio scegliamo di accenderlo. Quando ci fermiamo, il fuoco continua a generare il nostro spazio che, sul modello del granaio, gli si chiude intorno con mura solide e fisse, si carica di altri significati e comincia a chiamarsi casa. Da allora, la casa è lo spazio interno intorno al fuoco. La sua storia è quella dell’evoluzione di questo spazio, la stanza dove c’è il camino, nucleo generatore degli altri spazi che gli vengono annessi. Il fuoco è il centro della casa, l’elemento fondante, senza di lui non c’è mai stata casa in nessun luogo e tempo del pianeta.
La storia della casa s’intreccia indissolubilmente con quella del villaggio e della città. È molto probabile che i primi insediamenti stabili siano stati quelli dei pescatori. Coste marine e rive dei fiumi offrivano una buona possibilità di prendere pesci e uccelli con costanza, probabilmente già quarantamila anni fa sulle coste dell’Indonesia abbiamo costruito villaggi fatti di ripari usati durante tutto l’anno, complice un clima dalle temperature costanti. Ma le prime case in senso moderno nascono a sostegno della nuova attività agricola in Mesopotamia e nelle zone limitrofe, e sono fatte del materiale più reperibile, più economico e più efficace che si trovava in quelle zone: la terra. Allo stato attuale delle conoscenze, uno dei primi agglomerati urbani è considerato quello di Çatal Hüyük nell’Anatolia, risalente al VIII millennio a.C., che può contare tra i 5 e i 10.000 abitanti. Le case, in terra cruda con spesso una struttura in legno, sono addossate le une alle altre, hanno due stanze, nella principale c’è il focolare, l’altra è un magazzino, l’unica apertura è sul tetto, è lì che si svolge la vita, si scende in casa solo per riposare.
Nelle città della Mesopotamia i muri delle case sono in terra cruda, si usano mattoni in terracotta solo negli edifici importanti, e vengono impermeabilizzati con bitume impastato con calce o marna. I babilonesi già allora usano il petrolio, Plinio lo chiama nafta, il greco naphta deriva dal babilonese naptu, verbo che significa fiammeggiare: i babilonesi infatti non usavano il petrolio grezzo perché infiammabile, ma il bitume era ampiamente usato anche per impermeabilizzare navi, canali di irrigazione e recipienti. Un testo accenna a cinque navi cariche di bitume, vere petroliere dell’antichità. Greci e romani sostituirono il bitume con catrame di legna e pece. Anche qui come a Çatal Hüyük la casa non è pensata per passarci molto tempo dentro, serve esclusivamente come riparo dalla pioggia e per dormirci, quindi garantire l’impermeabilità e proteggere dal freddo della notte era importante, la vita si svolgeva tutta all’aperto. A Ur e Lagash, come a Mohenjo-Daro, nell’attuale Pakistan, le case hanno anche stanze da bagno e latrine con tubazioni in terracotta. Lungo le strade ci sono canali in muratura per la raccolta dei liquami e condotti per l’acqua piovana. L’acqua di scarico entra nelle fognature dopo essere stata raccolta in pozzi ermetici rivestiti di mattoni. Escrementi e rifiuti, allora solo organici, vengono scaricati in contenitori di raccolta in strada e usati come concime negli orti urbani o periurbani (2). La struttura urbana è regolare, pensata anche per permettere la raccolta e il riutilizzo dei rifiuti organici. Nelle case troviamo pochi mobili: un tavolo, una panca, sgabelli, a volte cassapanche. Fino al Medioevo inoltrato le case del popolo non contengono altro, oltre agli attrezzi per cucinare.
Quasi tutte queste città sono circondate da mura o da fossati, per la prima volta si pone un confine fra l’ambiente aperto e quello costruito dall’uomo. Lo scenario fisico è una porzione limitata di terra, lo spazio si concentra, si abbreviano i percorsi, si avvicinano i luoghi, si velocizzano gli avvenimenti, si dimentica la precedente confidenza con l’ambiente naturale illimitato, ci abituiamo a vivere in uno spazio chiuso e costruito a nostro esclusivo uso e consumo. Nella città ci sono un di qua e un di là dalle mura, come nella casa ci sono un dentro e un fuori. Gerico ha mura larghe tre metri alla base, alte quattro, con una circonferenza di 640 metri, circondate da un fossato largo 9 metri e profondo 3. Oltre che come protezione per le scorte agricole, potrebbero essere state costruite anche per proteggere la città dalle alluvioni divenute pericolose dopo l’abbattimento degli alberi per la realizzazione dei campi. La divisione dello spazio, i confini che abbiamo iniziato a tracciare per limitare i campi sono entrati definitivamente nelle abitudini di vita. A Lagash il terreno della città è diviso in proprietà private fra i cittadini, la campagna è amministrata in comune per conto degli dei. Il dio Bau possiede 3.250 ettari, nel suo tempio lavorano 21 fornai assistiti da 27 schiave, 25 birrai con 6 schiavi, 40 donne addette alla preparazione della lana, filatrici, tessitrici, un fabbro e numerosi funzionari, scribi e sacerdoti (3). Babilonia, pianificata intorno al 2000 a.C., è un grande rettangolo di 2500 metri per 1000 diviso dall’Eufrate, la superficie nelle mura è di 400 ettari, poi c’è una cinta esterna con un’area di 800 metri. La città appare formata da una serie di recinti, i più esterni aperti a tutti, i più interni riservati ai re e ai sacerdoti.
Costruiamo coi materiali che sono a nostra disposizione in quel luogo, così mentre intorno alla Mesopotamia il materiale più abbondante ed efficace è la terra, nell’Europa coperta di foreste è il legno. Qui la tipologia è la medesima, troviamo sempre il fuoco nella sala principale, ma la forma viene determinata dalla dimensione e dalle caratteristiche dei tronchi, vengono usate soprattutto le querce, che nei boschi fitti riescono ad arrivare a una lunghezza di trenta metri mantenendo un tronco dritto, usato per la trave di testa, il colmo e le travi maestre del tetto. Ne risulta una casa lunga e stretta, chiamata casalunga, una tipologia di cui si hanno resti sin dall’inizio del Neolitico e usata fino a tutto il Medioevo e oltre. Ci sono resti di caselunghe per esempio in Russia nel sito di Cucuteni-Tripol’ye, lo spazio interno è diviso in scomparti non comunicanti, con focolare e ripostiglio, pavimento scavato e tetto in paglia. Si parte col cercare un bosco con alberi adatti, da lì inizia il disboscamento per ricavare il terreno su cui coltivare e le travi per le case. Ogni casalunga dura in media non più di trent’anni. Dopo questo periodo è necessario costruirne una nuova, ma avendo abbattuto il bosco per far largo ai campi, diventa più conveniente abbandonarla, spostarsi fino a un altro bosco e fondare un nuovo villaggio. Gli insediamenti di quel periodo vengono costantemente ricostruiti in luoghi limitrofi ogni venti o trent’anni. Lo spostamento delle caselunghe comporta anche quello delle coltivazioni e sui campi abbandonati crescono nuovi boschi con piante differenti da quelle originali, arrivano le piante tipiche dei terreni ricchi di azoto come il faggio, che iniziò la sua diffusione in Europa grazie soprattutto a questi spostamenti, o come i sambuchi neri, la cui presenza è segno certo della precedente esistenza di una casalunga. La pratica di fondare i villaggi e abbandonarli dopo un paio di decenni modifica profondamente l’aspetto della natura, tanto che in Europa già nel 4.000 a.C. non esiste più la natura vergine, abbiamo già modificato completamente l’aspetto del paesaggio (4).
Fra i Greci troviamo il culto di Hestia, simbolo della casa da cui si proviene, centro focale dello spazio interno, in contrapposizione a quello esterno di Hermes, protettore dei viandanti e delle strade. La casa e l’amministrazione dell’ oikos, o famiglia, è considerata il banco di prova del buon cittadino. Negli scritti di Senofonte, del V secolo a.C., il concetto di economia implica ruoli separati e complementari: all’uomo la cura dei campi, alla donna la sfera domestica. Il termine economia conserva fino al XVI secolo nei trattati spagnoli qualcosa del significato greco: l’adeguata conduzione della casa basata sulla cooperazione tra capofamiglia, moglie e servi, affine alla gestione della proprietà sul piano più generale della comunità. Il termine è legato a un altro introdotto dagli antichi Romani: il vocabolo familia che non indicava la famiglia come la intendiamo noi ma il gruppo domestico nel suo complesso ed era connesso all’idea del patrimonio. Sia la familia che l’ oikos implicavano la cooperazione fra uomo e donna, l’impresa comune veniva designata come economia e tale rimane fino al XVIII secolo (5).
Il ruolo centrale del fuoco fra i Romani è testimoniato dal culto di Vesta, dea del focolare, sia quello della città che quello domestico di ogni singola casa. Il suo fuoco è quello che nutre, una potenza benefica e fecondante. Vesta è connessa alla terra, il suo culto fissava la famiglia alla casa e il popolo alla città. Secondo alcuni autori era stato lo stesso Romolo a istituirne il culto a Roma, accendendo il primo altare durante la fondazione. Il focolare di una città rappresenta l’origine della propria identità, la fonte stessa della vita. Durante questo periodo, la forma di casa più diffusa nelle campagne è composta da un grande locale con all’interno il focolare e i protettori sacri della casa che si affaccia su di una corte delimitata da mura e da un portale. Al centro dello spazio aperto c’è solitamente uno stagno. Questa la cellula base alla quale possono aggiungersi altre costruzioni. Nelle città, a Roma in particolare, la maggior parte della gente abitava in grandi costruzioni a più piani chiamate insule, dove il pianoterra era riservato alle botteghe.
L’uso della casa come strumento di lavoro è una costante che continua fino allo sviluppo dell’industria a metà Ottocento. Artigianato e commercio si esercitano dove abita il proprietario. Durante il Medioevo le attività artigianali, i commerci e gli scambi, sono esercitati per la maggior parte in una zona della casa descritta come una sala che di giorno è bottega o laboratorio e di notte può diventare una camera comune dove dormire. Maniscalchi, fabbri, panettieri, vasai, macellai e altri hanno di solito bisogno di altri locali destinati esclusivamente al lavoro, ma il grande locale al livello della strada con funzioni diverse nel tempo è considerato un classico dell’abitare quotidiano. La maggior parte delle case sono di terra cruda impastata con paglia e di legno e pietra. Case che si costruivano rapidamente con l’aiuto della comunità. Nell’Europa del nord e dell’ovest continua la tradizione delle caselunghe, un ambiente di circa dieci metri per sei con un focolare e dei pali centrali a sostenere il tetto. Il potere religioso cattolico in Europa è forte e vuole intervenire anche nello spazio quotidiano, nel 743 il Concilio di Leptines proibisce l’uso dei “solchi tracciati intorno alle case” definendolo pagano, a testimonianza di come nelle campagne resistano più a lungo che nelle città usi e costumi millenari. Nel XII secolo, un’invenzione che riguarda l’agricoltura permette l’espansione dei villaggi e il rafforzamento delle città, con conseguente modifica di tutto il paesaggio. La messa a punto del collare rigido per il cavallo ne aumentò notevolmente la forza di trazione, fino a rimpiazzare nell’aratura il molto più lento bue. L’aumento di efficienza e velocità portò a un fatto: i campi potevano trovarsi anche molto più lontani dalla casa, i coltivatori potevano vivere insieme in villaggi e cittadelle e raggiungere ugualmente i propri campi (6).
Durante il Medioevo chierici e laici, maschi, costruiscono il modello della buona moglie. Su un punto sono indiscutibilmente d’accordo: la casa rappresenta lo spazio femminile per eccellenza. Lo spazio interno, chiuso, custodito, in cui si colloca la donna, si contrappone a quello esterno in cui si muove liberamente l’uomo, specchio di un modello economico in cui l’uomo produce e la donna conserva. Lo spazio della casa è prima di tutto uno spazio morale, “coi suoi muri e le sue porte incarna e rappresenta fisicamente la custodia, circoscrive e isola l’interno preservandolo dai contatti e dai rischi che possono venire dall’esterno, è luogo e simbolo di stabilità che esorcizza il fantasma della vagatio e dei pericoli che essa comporta” (7). Si conferma il senso che la casa ha sin dalla sua comparsa: custodire ed essere il simbolo della lotta alla vagatio, al movimento.
Il 17 febbraio del 1600 Giordano Bruno viene bruciato in Campo de’ Fiori a Roma. Si apre così un secolo che vede la chiesa cattolica entrare a gamba tesa nella quotidianità. L’onda lunga della svolta moralizzatrice della Controriforma arriva a modificare gli spazi di vita, soprattutto delle classi superiori, quelle considerate inferiori non meritano la medesima pruriginosa attenzione. Fino ad allora, le stanze delle abitazioni europee dell’alta società non avevano funzioni fisse, non c’erano spazi dedicati o consacrati a una speciale attività, tavoli e letti venivano presi e spostati secondo il bisogno e l’umore degli occupanti. Accadeva ad esempio che le dame dell’alta società ricevessero gli ospiti nella stanza che conteneva il letto, mobile monumentale e unico a non venire spostato, come accadeva con gli altri, nelle peregrinazioni fra case di città e quelle di campagna dei nobili proprietari terrieri come si usava durante il Medioevo (8). Ciò non poteva più essere tollerato, era necessaria una chiara separazione fra la zona della casa in cui potevano introdursi gli estranei e quella riservata ai soli abitanti. In quel periodo si mettono i semi di quella che nella cultura architettonica di oggi è diventata la separazione fra zona giorno e zona notte. Verso la fine del secolo la casa nobiliare inizia a trasformarsi, le stanze si sistemano intorno al corridoio o all’atrio, come case ai lati di una strada o di una piazza, in modo che non si possa più passare direttamente da una camera all’altra. Si definisce l’idea di appartamento come lo concepiamo oggi, lo spazio domestico delle classi più alte e della borghesia si stabilizza in spazi con funzioni identificate e separate: corridoio, camera da letto, sala di ricevimento, salotto, cucina e le altre camere alle quali siamo abituati, la sala da pranzo la si costruisce per “farsi onore”, ha una funzione di rappresentanza sociale, mentre tutta la famiglia mangia in cucina. Le case del popolo continuano imperterrite a gravitare intorno allo spazio generato dal fuoco.
Si può scegliere il 1728 come data d’inizio dell’istituzionalizzazione dello spazio in Occidente (9). In quell’anno a Parigi viene redatto dalla Municipalità il “Piano dei limiti” con l’intento di addomesticare quelle parti di città che sfuggono al controllo proprio in virtù della loro forma. Gli esattori delle tasse devono sapere con precisione chi abita, dove e perché. Ogni cittadino deve avere una residenza, ogni casa un numero, ogni strada un nome che può essere riportato in un nuovo strumento di orientamento: la mappa. A Firenze i nomi alle strade vennero dati nel 1785, i numeri sistemati nel 1808. Il nuovo spazio omogeneo, a partire dall’Ottocento, è pronto. Da allora chiunque, con l’aiuto di una mappa redatta da specialisti, può trovare il luogo che cerca. La mappa inoltre è uno strumento fondamentale per l’organismo centrale che ha bisogno di sapere chi sono i suoi cittadini e soprattutto dove trovarli. Si intensificano i censimenti, ma le città sono troppo intricate, vanno riorganizzate, rese percorribili e chiare, ogni abitante deve avere una residenza registrata che deve essere accessibile e controllabile. Diventano necessarie leggi che diano il controllo del costruito all’amministrazione centrale. Vengono stabiliti dei criteri per le nuove costruzioni, in cui la variante principale è costituita dalla necessità del controllo di un tecnico dell’amministrazione. È questo il momento in cui la costruzione dell’abitare quotidiano smette di essere nelle mani di chi la usa per passare in quelle di tecnici nati da necessità amministrative, sconosciuti a chi abiterà, con il compito preciso di far rispettare le regole. La gente, per la prima volta nella storia, non può più costruirsi il proprio spazio da sola. Prima lo spazio nasceva dalle necessità delle persone che lo abitavano. Dopo, viene modellato sulle necessità di un’amministrazione.
Questo è l’interruttore segreto che ha dato il via al desolante fenomeno dell’abbrutimento del nostro ambiente artificiale. Senza questo piccolo scatto le strade non avrebbero potuto ampliarsi per accogliere le nuove padrone automobili, le case non sarebbero diventate tutte uguali, con gli stessi benefici e gli stessi errori e orrori, i veri luoghi di vita non sarebbero stati cancellati volontariamente o involontariamente da tecnici benintenzionati o da burocrati pedanti. Lo spazio costruito nasce come una lingua dall’apporto di ogni parlante. Nel momento in cui arrivano i grammatici a codificarla, la lingua si blocca in una serie di regole e termini fissi necessariamente legati a un determinato tempo e spazio. Ma mentre nelle lingue l’uso determina comunque cambiamenti che verranno a loro volta istituzionalizzati, nel caso dello spazio il passaggio a una “grammatica” usabile solo da tecnici ha ucciso la parola del singolo, imbalsamato lingue, dialetti e parlate spaziali nella cornice della storia e del pittoresco.
Nell’Ottocento le città europee si trasformano per diventare permeabili ai controlli e alla erogazione dei servizi pubblici, vengono ridisegnate con lo scopo di dare un’arma in più a guardie, ufficiali giudiziari e ispettori sanitari. Ogni spazio irregolare, cioè i luoghi reali di vita degli abitanti, viene cancellato e rimodellato con ordine. Inizia un irrigidimento del senso comune dello spazio: da luogo manipolabile, accessibile, modificabile si trasforma in un’idea più astratta, impersonale e statica non controllata direttamente da chi lo usa. L’attività di creazione di luoghi da metà Ottocento non è più consentita, ma quello che più influenza la creazione dello spazio da allora è che la sua memoria viene lentamente cancellata con l’abbattimento fisico e il reinserimento degli abitanti in uno spazio definito da esperti e burocrati. Fino alla fine del Settecento era impensabile per un architetto l’idea di occuparsi delle case della gente comune. Nessuno trovava necessario guardare a come il popolino usava e costruiva i propri luoghi e l’interesse non andava oltre la curiosità, simile a quella dei viaggiatori del tempo a contatto con tribù indigene, primitive ed esotiche. Il compito dell’architettura era rivolto a tracciare i grandi assi, attrezzare l’ambiente con gli opportuni monumenti e fermarsi alla divisione dei lotti. Il resto, cioè la città, era lasciata all’organizzazione dei singoli che, insieme a mastri carpentieri e muratori, la costruivano quotidianamente. È solo dopo la Rivoluzione francese che il comportamento del popolo diventa d’interesse pubblico. Nascono le inchieste sulle condizioni delle abitazioni, igienisti e amministrazioni esigono la ricostruzione dell’abitato quotidiano: per la prima volta si chiede ad architetti e ingegneri di occuparsi delle case. L’origine del senso moderno della professione dell’architetto nasce da una necessità burocratica al servizio dell’amministrazione. Dolorosa, liberatoria o indifferente che sia, può essere utile per gli architetti la coscienza di essere nati nella modernità come strumento delle amministrazioni per il controllo del popolo attraverso la riorganizzazione dello spazio.
Fino al XIX secolo non esiste una normativa di distribuzione spaziale dei luoghi di residenza. Ognuno abita e trasforma il proprio spazio. Quando in Europa lo stato comincia a occuparsi col piccone dell’abitare dei cittadini, specialmente se appartengono alle classi “laboriose e pericolose”, vengono stabiliti i criteri del sano abitare. L’igiene è la bandiera più usata dai riformatori. Secondo il Benevolo, l’urbanistica moderna non nasce negli studi degli architetti, ma in quelli dei medici e degli igienisti. Tutto il complesso sistema delle leggi urbanistiche contemporanee si basa su leggi sanitarie messe a punto a metà Ottocento. Le commissioni sanitarie e i riformatori sociali affiancano le municipalità nell’opera di igienizzazione dello spazio. Le cause di malattie contagios...
Indice dei contenuti
- Copertina
- L'invenzione della casa
- Indice
- Citazione
- Ouverture
- Primo movimento - Largo
- Saturno sulla spiaggia
- Cronache dal mondo prima
- Arrivano i Sapiens
- Come viviamo?
- Abitiamo?
- Cosa mangiamo?
- Cosa usiamo?
- Come ci organizziamo?
- Secondo movimento - Andante
- Premessa
- Addio ai ghiacci
- Scatta la trappola
- Rien ne va plus
- L’invenzione della casa
- Terzo movimento - Vivace
- Diecimila anni in casa
- Quarto movimento - Presto
- Costruire esterni
- Design e attrezzatura
- Caccia
- Note
- Sulle fonti
- Bibliografia