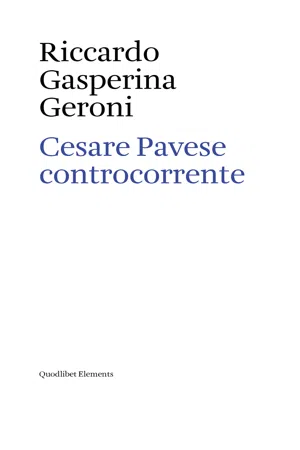L’ASSASSINIO DI GISELLA: 1941
La critica ha sempre sottolineato e avvalorato l’ipotesi che con gli scritti di Feria d’agosto si assista a un cambio di paradigma nell’orizzonte teorico-poetico di Pavese dalla campagna, in cui domina la dimensione del selvaggio (la wildness), alla campagna come luogo di esperienze simboliche, tesori – precisa Pavese nel racconto Il tempo – da riconoscere e da cogliere «sotto il labile istante». A questa idea ha contribuito notevolmente lo stesso autore, parlando di una “conversione” di Crea avvenuta negli anni della Resistenza e sottolineando reiteratamente come gli scritti precedenti a quegli anni, in sostanza, da Paesi tuoi (1941) à rebours, siano «sciocche cose, tracciate secondo schemi allotrî, che non hanno nessun sapore dell’albero, della casa, della vite, del sentiero, ecc. come li conosco». In realtà, le cose non sono così lineari: come cercherò di spiegare in queste pagine, già nelle prime opere affiora un interesse per il problema del mito e del suo rapporto con il mondo originario. Più che da una conversione ricostruita a posteriori, questa propensione sembrerebbe confermare una attitudine psicologica allo scavo del reale, alla ricerca di un “dietro le quinte” che possa sostanziare e illuminare il qui e ora.
È, senz’altro, l’affermarsi della psicoanalisi a contribuire all’idea per la quale dietro la percezione del mondo si nasconda qualcosa che ci parla e che è necessario scoprire e riportare alla luce. È il principio dell’inconscio su cui si fonda la pratica clinica di Freud la quale prevedeva, a fronte della remissione dei sintomi, la necessità di portare a risoluzione, attraverso un viaggio a ritroso spesso con il supporto dell’ipnosi, il trauma psichico che aveva ingenerato la nevrosi. A suo pari Jung, pur distanziandosi dall’ipotesi “pansessualista” del maestro, ipotizzava per un corretto processo di individuazione della personalità il ricorso al mundus imaginalis, a quelle immagini universali di natura archetipica di cui è necessario valutare il grado di conformità con l’esperienza del singolo individuo: più il singolo si discosta dai propri archetipi e più si acuisce il dissidio interiore. A questo proposito James Hillman, interprete davvero originale del pensiero di Jung, riconducendo a Eraclito l’unione di anima e profondo, scriveva che «la dimensione dell’anima è la profondità (non l’ampiezza o l’altezza) e la dimensione in cui procede il nostro viaggio d’anima è verso il basso». In questo senso, la psicologia del profondo interessa Pavese perché la sua spinta gnoseologica ha, come vettore, un movimento retrospettivo che dal presente riconduce all’infanzia, sia del mondo che del singolo individuo. Non stupisce, dunque, da una parte, il fitto ricorso nella sua opera a un lessico legato alla profondità della terra: scavo, giacimenti, filoni, miniere descrivono il mondo ctonio dei ricordi e della memoria dell’universo pavesiano; né tantomeno stupisce l’interesse per l’opera di Vico che proprio Hillman, in relazione a questa ricerca a ritroso, aveva accostato al pensiero di Jung. Nella Scienza nuova, Pavese difatti scorge una potente e immaginifica narrazione delle origini dell’uomo, di quando i giganti nella foresta, colpiti dal rombo del tuono, alzano gli occhi e osservano per la prima volta il cielo, trascendendo la propria dimensione ferina e acquisendo una prima forma di autocoscienza, dettata dalla comprensione dell’esistenza di un’entità a loro superiore alla quale è tributato il nome nato dall’urlo selvaggio di spavento: «Ious» (Giove). Un’entità inventata su cui vengono proiettate la paura provata e, al contempo, la grazia di essere stati risparmiati.
È proprio questo il cuore del problema della lettura dell’opera vichiana da parte di certo Novecento con cui Benedetto Croce mai sarebbe sceso a patti, proprio lui che nel 1911 era stato il fautore della rifioritura in Europa, seppur da una prospettiva idealistica, del pensiero di Vico, di cui nondimeno avvertiva una certa «oscurità». Da parte sua, Pavese che ha contribuito, insieme con altri intellettuali, ad approfondire in opposizione a Croce il versante oscuro della Scienza nuova affronta in un testo molto chiaro la concezione degli universali fantastici, riconnettendoli all’esperienza religiosa avvenuta nel ricordato santuario di Crea.
Nel testo Il mito, composto nella primavera del 1950, ma che condensa riflessioni rintracciabili nel Mestiere di vivere sin dai primi anni Quaranta, sconfessa l’autonomia dell’arte predicata da Croce e rivendica, come «scoperta appassionata» della Scienza nuova, l’idea che la poesia, posta da Vico a embrione delle umane genti, scaturisca da una «ispirazione», da un’«intuizione nucleare» che non tarda a definire «mitica»; e di conseguenza e in modo molto coerente, suggerisce di leggere il testo vichiano sostituendo tutte le occorrenze del termine «poetico» con la parola «mitico». Postulare l’esistenza di uno stato aurorale, precedente alla coscienza e quindi fuori dalla storia, a cui la poesia, come la pratica psicoanalitica, possano accostarsi, significa spingere il pensiero vichiano verso l’orizzonte vischioso del vitalismo e dell’autentico, spostamento questo che allora suonava connivente alla cultura di destra, al cui fascino peraltro anche Pavese sembra aver ceduto. Al di là dell’aspetto politico, questa tensione porta in primo piano il problema della memoria, perché solo nella sua «materna penombra» si può fare esperienza di quella visione originaria che non sta nella storia e che quindi può essere solo pensata o immaginata. Nella memoria, che Croce non riteneva dispensabile all’espressione artistica, sono dunque racchiusi, come un tesoro, gli strati profondi della psiche umana e, secondo questa prospettiva, che trova nel fenomenologo Enzo Paci uno dei suoi interpreti più acuti, i miti in Vico sono immagini che hanno la funzione di mediare tra la trascendenza e l’immanenza, tra il mondo delle origini e il mondo della storia: sono il frutto di una vivida immaginazione radicata nella corporeità e nelle passioni attraverso le quali l’uomo primitivo inizia a conoscere ed esplorare il mondo e, di conseguenza, ad animarlo combinando memoria e fantasia. Nell’immagine e grazie all’immagine si fondono il senso, le pulsioni e i primi bagliore della ragione. Vico può così essere considerato non solo il precursore del «mondo dell’inconscio con i suoi territori e i suoi complessi», ma in particolare dell’idea junghiana di inconscio collettivo: «ciò che domina – scrive Paci – nell’uomo bestia è la “libidine bestiale” e la civiltà nasce soltanto con la coscienza di tale libidine, con la sua espressione in un ordine, dettato dalla paura, dal timore della divinità». In un appunto dedicato alla morte dell’amico, anche l’antropologo Ernesto De Martino sottolineerà il suo interesse per l’«esperienza zero», per quel momento di passaggio che non può essere rivissuto, se non nel racconto e nell’evocazione rituale. Pavese aderisce qui a una visione del mito propria della fenomenologia della religione secondo la quale il racconto è l’involucro di un’esperienza vissuta prima di essere elaborata. L’azione rituale e il racconto mitico sono portatori di un’esperienza archetipica, di cui sono la ripetizione, l’imitazione gestuale. La fenomenologia ha, dunque, identificato all’interno della forma del racconto mitico l’espressione rivissuta di un atto originale o matrice che accorda il culto alla pienezza originaria dell’essere. Mircea Eliade scriverà nel Trattato di storia delle religioni che «bisogna abituarsi a dissociare la nozione di mito da quella di parola, di favola, per accostarla alle nozioni di azione sacra, di gesto significativo». Questa idea è già sviluppata in Pavese all’altezza del saggio Del mito, del simbolo e d’altro, nel quale egli appunta che «il mito è insomma una norma, lo schema di un fatto avvenuto una volta per tutte, e trae il suo valore da questa unicità assoluta che lo solleva fuori del tempo e lo consacra rivelazione. Per questo esso avviene sempre alle origini, come nell’infanzia: è fuori del tempo». Fare arte significa dunque rappresentare, per la «seconda volta», quell’evento, riportarlo nell’alveo della storia, far incontrare l’uomo-bestia e l’uomo civile. Si legga questa lunga citazion...