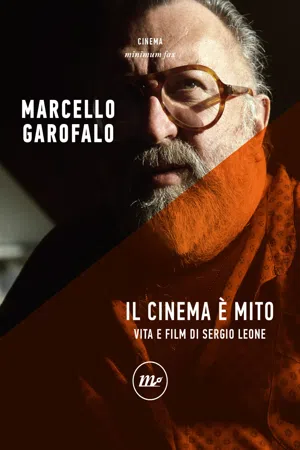![]()
1
IN OMAGGIO A MIO PADRE MI SONO RIBATTEZZATO BOB ROBERTSON
Sergio Leone nasce a Roma il 3 gennaio 1929. Il padre, Vincenzo, lo stesso anno conclude la propria attività di direttore artistico nel cinema muto, rifacendo negli stabilimenti della Quirinus, uno dei classici della filmografia di Francesca Bertini, Assunta Spina, dal dramma di Salvatore Di Giacomo, con Rina De Liguoro e Febo Mari nei ruoli che erano stati della diva Bertini e di Gustavo Serena, celebre Petronio nel Quo vadis (1913) di Enrico Guazzoni.
Il giorno successivo alla prima romana, tenutasi il 12 marzo 1930, la critica non è affatto benevola: «Rimpiangiamo di non avere l’eloquenza di un Demostene che cadrebbe in acconcio parlare dei veri nemici della nostra cinematografia, di quelli che la fanno diventare una “cosa” senza nome, profondamente immorale, bassa, inestetica, volgarissima. La stiratrice Assunta Spina in costume da bagno all’americana – maillot Jantzen a striscioni – tra i giocatori di water polo! Assunta Spina con le gonne corte alla garçonne!»;1 «Queste riduzioni bisognerebbe affidarle a persone competenti provviste di una buona dose di cultura, che sappiano, con senso d’arte, alleggerire la trama e renderla più confacente allo spirito della moltitudine, la quale preferisce lavori a fine lieta, non appesantita da troppi intrighi, con spunti nuovi e originali che non raccontino, specialmente quando hanno per sfondo Napoli, la solita storia: assassini, arresti, pentimenti ecc. [...] Assunta Spina è purtroppo uno di questi lavori che, pur magnifici per interpretazione, per tecnica, per fotografia, lasciano il pubblico insoddisfatto per la trama spesso inumana, sempre delittuosa [...]».2
Il 1929 è l’anno in cui le distinzioni tra cinema e teatro filmato cominciano ad apparire finalmente marcate, è l’anno in cui i sistemi denominati «movietone» e «vitaphone» si impongono anche in Italia grazie al Cantante di jazz, è l’anno in cui i critici discutono sul «danno» che l’elemento fonico introduce nell’arte muta,3 in cui al Supercinema di Roma si proiettano Il vento di SjÖstrÖm con Lillian Gish, I mari scarlatti di John Francis Dillon e Follie del giorno di David Butler, varietà gigantesco della Twentieth Century Fox.
Vincenzo Leone, in arte Roberto Roberti, metteur-en-scène, fino ad allora apprezzatissimo, di ben cinquantuno film (di cui quindici con Francesca Bertini), evidentemente sensibile al moderno e al fascino della «contaminazione» americana, pensa bene di rinfrescare il frusto personaggio della stiratrice sfregiata proponendole costumi da sophisticated comedy, vezzi alla Claudette Colbert e maniere da romanzi rosa in stile Pitigrilli; per tutta risposta il riduttore del testo di Di Giacomo, Gaetano Campanile Mancini, vista la pellicola, vuole il suo nome stralciato dall’opera e la Commissione di censura boccia in prima istanza il film per l’articolo V, riguardante non l’immoralità, ma il basso livello artistico (in realtà la condizione richiesta dalla commissione di censura per il nulla osta alle pubbliche proiezioni fu di «sopprimere l’epilogo»)! Inizia da questo momento per Vincenzo Leone un lungo periodo di inattività, al quale contribuiscono diversi fattori, ragioni personali, artistiche e anche politiche.
L’avvento del fascismo coincide con un periodo di crisi per la produzione dei film in Italia. Diversi fattori la determinano: alti costi industriali – il 1929 è proprio l’anno della grande crisi cui segue la recessione – concorrenza dei film americani, compensi troppo alti dei divi, incapacità di tenere il passo con l’evoluzione tecnologica, chiusura dei mercati esteri, mancanza di aiuti statali. Dal 1925 al 1929 si producono cento film, tanti quanti se ne allestiranno tra il 1930 e il 1934, ma la maggioranza di essi non oltrepassa i confini di una diffusione a carattere regionale e nasce spesso all’insegna di iniziative artigianali, se non addirittura avventurose. Proprio nel 1929 viene istituito l’Ente nazionale per la cinematografia (ENAC), un organismo che, sorto per tutelare la diffusione dei film italiani nel mondo, ritenuto improduttivo, verrà sciolto nel 1931. Gruppi di cineasti iniziano a chiedere un coinvolgimento impegnativo dello stato fascista e sorgono due inconciliabili tendenze: c’è chi vagheggia una macchina-cinema al servizio esclusivo di obiettivi pedagogico-politici e chi si augura che il cinema diventi un veicolo di italianità nell’arena internazionale, uno specchio della cultura e degli umori nazionali, piuttosto che un amplificatore propagandistico. La rivista di Alessandro Blasetti, Cinematografo, intorno alla quale si radunano intellettuali e professionisti, tra cui Aldo Vergano, Libero Solaroli, Umberto Barbaro, Mario Serandrei, non tutti con la tessera di partito in tasca, cerca in tutti i modi di sostenere la seconda tendenza.
Ma la crisi schiaccia anche gli sforzi dei volenterosi. Certamente per Vincenzo Leone e sua moglie Bice la nascita del figlio Sergio, dopo sedici anni di matrimonio, è un avvenimento molto importante, ma non può essere questa la causa di un allontanamento di Vincenzo dal lavoro.
Evidentemente nel caso del direttore artistico Roberti si aggiungono, alle difficoltà di ordine generale comuni a tutti i cineasti, ragioni politiche, cattivi rapporti con il regime.
Sergio racconta: «Mio padre si era iscritto molto presto al partito fascista, perché ci credeva. Ma dopo tre settimane gli dissero che doveva rifare l’iscrizione, perché il segretario della sua sezione era scappato con la cassa. Egli allora rifiutò di ripetere l’operazione e, a poco a poco, si cominciò a dire che fosse comunista: aveva proposto a Bottai la costituzione di cooperative e si salvò dal confino solo perché garantì per lui Roberto Forges Davanzati. Era però anche diventato il segretario generale della corporazione dei registi e non si azzardavano a toccarlo.
Un episodio che ebbe molta importanza nella sua carriera fu quello legato al progetto dell’UCI di ridurre per lo schermo Claudia Particella, l’amante del cardinale, un romanzetto scritto in gioventù da Benito Mussolini. «Mio padre venne chiamato direttamente da Mussolini, che gli offrì il lavoro; ma letto il libro, mio padre gli disse chiaramente che si trattava di una porcheria e rifiutò di occuparsene. Bottai lo perseguitava e mio padre non riuscì più a trovare lavoro».4
In effetti, dopo la marcia su Roma, il fascismo rivolge subito le sue attenzioni al mezzo-cinema, considerandone le enormi possibilità di eccellente supporto propagandistico alle idee del regime. Innanzitutto mette le mani sull’Istituto Luce (L’Unione cinematografica educativa) e trasforma questa innocua istituzione di documentari scientifici in una casa editrice di cinegiornali bisettimanali; quindi affida ad alcuni cineasti – primo fra tutti Silvio Laurenti Rosa – la realizzazione di opere che esaltano la rivoluzione fascista, inizialmente a carattere documentario, poi a soggetto. Vincenzo Leone, raffinato e romantico metteur en scène di impetuosi drammi d’amore e avventure galanti, non si trova certo a suo agio nel clima che si è diffuso, ma, secondo quanto ha potuto accertare Gian Piero Brunetta5 il film che Roberti avrebbe dovuto trarre dal romanzo di Mussolini non si sarebbe realizzato soprattutto perché il duce, divenuto capo del governo, avrebbe ritirato la sua approvazione, trovando incompatibile con la sua nuova immagine e funzione un progetto del genere. Esiste comunque una fotografia del frontespizio6 della sceneggiatura originale del film, dove si legge chiaramente, aggiunta a penna dallo stesso Mussolini, la scritta «a cura di Leone Roberto Roberti». È anche possibile che il regista in un primo momento avesse accettato la proposta (in fondo, era pur sempre una storia di torbide passioni, ambientata nel secolo XVII in una «villa sontuosa dell’Alto Adige ove una fanciulla di nome Claudia viveva una vita gioconda fra la spensieratezza dei suoi primi anni e l’amore del Conte di Castelnuovo, per poi infiammare segretamente il cuore del sagrestano della Chiesa»...), scritto il copione e, poi, declinato l’incarico.
Oltretutto Mussolini amava poco il cinematografo, non poteva soffrire le dive e si divertiva solo alle facezie di Laurel e Hardy, o di Topolino, o alle rodomontate di Maciste, di cui – volontariamente o inconsciamente – amava ripetere gli atteggiamenti gradassi.
Certo è che Roberti deve attendere il 1939 per tornare al lavoro grazie anche a un intervento, a detta del figlio Sergio, del presidente dell’UCI, Giuseppe Barattolo. Ma fatalità vuole che Roberti perda anche un’altra occasione di rilancio.
«Alla fine degli anni Venti, ci furono molti registi e attori tedeschi che partirono per Hollywood: Lubitsch, per esempio. Dinanzi a questa fuga, Berlino chiama alcuni registi italiani. Fu allora che Pola Negri propose a mio padre di lavorare con lei, ma proprio allora mia madre era incinta di me. Dopo più di dieci anni di matrimonio appariva quasi come un fatto miracoloso... Mio padre quindi aveva due alternative: andare all’estero a lavorare con Pola Negri, oppure restare a Roma. E mia madre non desiderava affatto lasciare l’Italia. E così mio padre non firmò con Pola Negri e io sono nato a Roma».7
La madre di Sergio, Edvige Valcarenghi, nata a Roma (suo padre dirigeva un grand hotel, oggi scomparso, l’Hotel di Russia, in Piazza di Spagna), ma proveniente da una famiglia milanese di origine austriaca, è attrice col nome d’arte di Bice Waleran (il nome deriva dal principe Valerian, primo fidanzato) e conosce Vincenzo su un set della Aquila Film di Torino, la casa di produzioni cinematografiche per la quale Roberti lavora come attore e realizzatore di punta accanto ad Achille Consalvi.
In realtà Vincenzo Leone inizia la sua carriera artistica proprio come attore di teatro. E Sergio racconta: «Ma i suoi genitori non volevano assolutamente sentirne parlare. Si era all’inizio del secolo. Mio padre era nato nel 1879... E all’epoca fare il “teatrante” era considerato un’onta in una famiglia come la mia, di ricchi possidenti dell’Irpinia, significava essere considerati dei “Pulcinella”. Compiuti gli studi presso un collegio di salesiani – molto più aperti mentalmente rispetto ai gesuiti – a Cava de’ Tirreni, iniziò a frequentare l’università e contemporaneamente a recitare in una compagnia filodrammatica. A Napoli conobbe Edoardo Scarfoglio che lo introdusse negli ambienti bene della città, facendogli conoscere Roberto Bracco, Matilde Serao e Salvatore Di Giacomo. Fu Ermete Novelli a facilitargli l’avvio della carriera teatrale, facendolo entrare nella compagnia Talli-Gramatica-Calabresi, con il nome d’arte di Roberto Roberti, scelto a imitazione di quello già famoso, di Ruggero Ruggeri. Per questo, in omaggio a lui, quando ho firmato Per un pugno di dollari, che necessitava di uno pseudonimo anglofono, mi sono ribattezzato Bob Robertson, “il figlio di Roberti”... Essendosi laureato, la famiglia pensava che lui lavorasse come avvocato a Torino e invece calcava le tavole del palcoscenico. Lavorò anche nella compagnia della mitica Eleonora Duse. Poi, mentre si trovava a Torino conobbe l’avvocato Lino Pugliese, che era l’amministratore e il principale collaboratore di Camillo Ottolenghi, fondatore di una modesta – ma già allora impegnata in tutti i generi in voga – casa di produzione cinematografica, l’Aquila Film. E fu proprio Pugliese a convincere mio padre a interpretare un film, il solito feuilleton a forti tinte, dal titolo La bufera. Le critiche furono positive8 e il film raggiunse anche il mercato inglese. Ma mio padre era attratto soprattutto dal teatro e continuò a lavorare come “attor giovane” nella compagnia di uno dei più apprezzati attori e capocomici dell’epoca: Ferruccio Garavaglia. Fu per la morte improvvisa di Garavaglia, che l’anno successivo (1912) ripensò alle opportunità del cinema, dicendo all’avvocato Pugliese di essere disponibile a trasferirsi a Torino e a lavorare stabilmente per l’Aquila Film e così iniziò la sua carriera di direttore artistico, avendo spesso come attrice mia madre».
Il film si intitola La contessa Lara e la messa in scena di Roberti viene lodata da molti recensori;9 dal 1913 Vincenzo Leone inizia a realizzare una lunga serie di medio e lungometraggi, talvolta anche prestandosi come attore; si tratta perlopiù di melodrammi sentimentali arricchiti da violenti colpi di scena. Fu lo scoppio della guerra a suggerire probabilmente un cambiamento di indirizzo nella produzione: alla fase del grand guignol, che aveva trovato i suoi momenti più felici in film come La regina dell’oro (1913), nel protowestern La vampira indiana (1914) in cui Bice Waleran interpreta una poco probabile squaw, con relativo copricapo di piume, nel Barcaiolo del Danubio (1914) considerato uno dei capolavori dell’Aquila Film, subentra una tendenza meno tragica, una predilezione per vicende d’amore più lievi e più consone a un periodo in cui il conflitto mondiale offriva nella realtà drammi ben più angosciosi.
Ma il dramma moderno, il genere per il quale Roberti è considerato maestro, inizia a essere condizionato da un fenomeno nuovo: il divismo. Così l’avventura dell’Aquila Film finisce nel 1917 con il fallimento della casa, nonostante il ritorno come prima attrice di Antonietta Calderari, già star al fianco di Roberti e Waleran in tante opere precedenti. Ormai la fama di Roberti, grande direttore di attori, si è diffusa e nello stesso 1917 viene chiamato a Roma a collaborare con una delle più importanti case di produzione italiane, la Caesar Film, fondata nel ’14 dal napoletano Giuseppe Barattolo. La diva della Caesar Film è Francesca Bertini, già nota a livello internazionale, e il suo contratto, per otto film in un anno, prevede quattro milioni di lire, una cifra spropositata per l’epoca.
«Alla fine della guerra Barattolo creò addirittura la Bertini Film, facendo venire un cineasta tedesco a dirigerla, ma questo realizzò fiaschi tremendi, mentre Carmine Gallone metteva in scena con successo le concorrenti di Bertini: Lyda Borelli, Soava Gallone. Così mio padre fu il successore del tedesco e diresse il suo primo film, tratto da un dramma di Roberto Bracco, La piccola fonte, un intreccio lan...