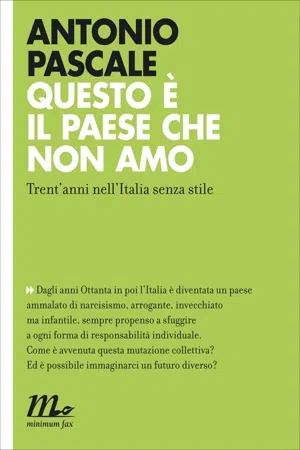IL PUNGOLO DEL DOLORE?
Durante la giornata di sabato 13 luglio 1985 ebbi il mio primo serio e conflittuale impatto con la rappresentazione del dolore. Intendo dire che da allora, in maniera sommessa ma perturbante, si fece strada in me l’idea che la rappresentazione del dolore contenga in sé qualcosa d’ambiguo, tanto utile quanto pericoloso.
Ma questa sensazione non maturò allora. Si mantenne a un livello troppo basso perché io stesso trovassi le parole o le teorie per dare corpo a quello che provai quel giorno.
Stavo guardando il concerto Live Aid. Per non essere disturbato, avevo trasportato in camera mia un vecchio televisore. Un Grundig. 16 pollici. Senza telecomando. Il concerto era stato organizzato da Bob Geldof e voleva sensibilizzare il mondo sul problema della fame in Etiopia, colpita l’anno precedente da una grave carestia.
Va detto subito: io volevo vedere solo il concerto. Non mi importava (non mi importava in quella calda giornata di luglio) del problema della fame in Etiopia. Un po’ perché per la prima volta avrei visto band storiche riunite per l’occasione, un po’ perché la musica è un’arte superiore in quanto ti consente di essere immediatamente altrove e altro da te.
Ero, musicalmente, cresciuto ascoltando band inglesi, come gli Stones e gli Who. Di questi ultimi apprezzavo, oltre la musica, alcuni curiosi aspetti del carattere, come l’irascibilità, le movenze disarticolate e la balbuzie (musicale) che ne conseguiva, l’esibizione plateale della violenza e, soprattutto, quel che di barbarico che durante il concerto a Woodstock spinse Pete Townshend ad aggredire Abbie Hoffman, che aveva osato interrompere l’esibizione del gruppo per leggere un proclama pacifista.
Sta di fatto che durante il Live Aid furono mostrate molte foto di bambini malnutriti. Credo che fosse la prima volta che veniva esposto un tale catalogo di sofferenza a una platea così vasta. Sicuramente era la prima volta che io ci facevo i conti.
Se non avessi avuto diciannove anni e se non avessi creduto allora (adesso meno) alla necessità di raggiungere il paradiso e l’equilibrio attraverso la cruda e brutale rappresentazione dell’inferno, di sicuro mi sarei posto una domanda: come è possibile, dopo aver visto immagini di morte, carestia, apocalisse, canticchiare poi amabilmente, appresso a Mick Jagger e Tina Turner, il motivetto di «It’s Only Rock’n’Roll (But I Like It)»?
Potevo commuovermi per un minuto appena e subito dopo tornare alla spensieratezza che la musica porta con sé?
Una pagina del libretto del dvd celebrativo del Live Aid mostra a sinistra (a colori) gli spettatori del concerto bagnati dall’acqua degli irrigatori; a destra (in bianco e nero e con un leggero effetto sgranatura) dei profughi etiopi, seduti, distrutti dalla fatica. Più avanti, il catalogo sottolinea sia il momento finale del concerto sia la preparazione degli aiuti, con la nave verde Band Aid I. Nell’ultima foto del catalogo (spalla destra della pagina) compaiono dei bambini sorridenti (si suppone abbiano potuto usufruire degli aiuti). La narrazione di questo catalogo, un po’ come quella del Live Aid, rispecchia la capacità degli occidentali di creare eroi umili che riescono a comporre sulla stessa pagina colori e bianco e nero: una sorta di cromoterapia che placa le nostre ansie, perché alla fine qualcuno sorride.
Quel giorno, costretto a cambiamenti di umore repentini, sballottato tra le crude immagini della carestia e gli stadi di Wembley e JFK Philadelphia, mi sentivo ansioso.
Avrei scoperto, a breve, che ci sono vari modi per combattere l’ansia. C’è un ampio ventaglio di possibilità che spazia dagli ansiolitici alla masturbazione. Ma, a parte questo, forse la maniera più elementare per combattere l’ansia consiste nel pagare, per così dire, il conto. Versare soldi alla causa.
Durante il Live Aid, dopo le immagini crude, di soldi ne furono raccolti in abbondanza: 300 milioni di dollari, pressappoco.
Ricordo ancora la faccia di mio padre quando entrò nella mia stanza e guardando le immagini disse con un po’ di strafottenza: Ma che cos’è questa speculazione? E ricordo anche l’espressione stupita di mia madre mentre mi confessava, qualche giorno dopo, che mio padre era andato in banca a fare un versamento sul conto del Live Aid.
In realtà dopo qualche tempo cominciarono le polemiche su come fossero stati spesi i soldi e soprattutto dove fossero finiti. Il filosofo francese André Glucksmann denunciò che gran parte dei dollari erano andati a rimpinguare il conto di Mengistu, uno dei tanti militari sanguinari che all’epoca comandava un governo dittatoriale. Comunque, per risolvere la questione furono diffuse alcune foto che raffiguravano nuove scuole, nuovi ospedali, nuovi pozzi in costruzione in qualche villaggio dell’Etiopia. Queste immagini, sempre le stesse, apparvero su molti giornali e per un periodo ci divennero così familiari, consuete, intime, che la nostra ansia ancora una volta si placò.
Poi venne agosto. Sulla battigia, sdraiati sugli asciugamani a goderci il tramonto, a osservare i primi windsurf che cominciavano a solcare il mare oltre le boe, si continuò fra noi che non avevamo ancora vent’anni a parlare del Live Aid.
Sì è vero, si commentava, c’era qualcosa di stonato nella rappresentazione del dolore, però quello che contava, in fondo, era aver raggiunto il risultato. Dare da mangiare agli affamati. Non era solo un comandamento evangelico ma un sentimento dettato anche dal buon senso. Forse, alla fine, quello che era importante era la sincerità dei cantanti.
Ora, tra tutte le esibizioni una in particolare aveva colpito (quasi con certezza statistica) l’immaginazione di noi ragazzi: quella degli U2. Soprattutto quando Bono Vox aveva cantato la canzone «Bad». Con i capelli striati di biondo, tagliati corti davanti e lunghi dietro (così come si portavano in quegli anni in periferia), con una brutta giacca alla russa, i pantaloni di pelle infilati in un paio di stivali fino al ginocchio, neri con i tacchi alti, il cantante, sudato e contratto, aveva intonato un’ottima, anzi fenomenale, versione di «Bad». A rifletterci, l’emozione nasceva dall’assenza di una coreografia studiata: tutto, dal modo di vestirsi a quello di tenere l’asta del microfono, era istintivo e spesso impacciato e sembrava voler dire: non guardate me, ma ascoltate il mio canto, perché è qualcosa che mi trascende.
Il momento più bello fu quando Bono invitò qualcuno del pubblico a raggiungerlo. E siccome il servizio d’ordine faceva fatica a prelevare le ragazze dalla folla, Bono scese dal palco e ne abbracciò una, ballando stretto con lei.
Che ne so. Sarà perché alle cinque e mezzo ora locale (pressappoco il momento dell’esibizione della band al Wembley Stadium) il cielo stava per scurirsi facendoci sentire la tipica malinconia che precede il vespro, sarà il gesto di Bono, inaspettato, sarà anche la faccia pulita, impubere, del cantante (allora così somigliante alla nostra), ma quel momento ci sembrò, per così dire, un nuovo grado zero del rock. Dimostrava a tutti la forza e la sincerità della musica e con essa la possibilità di occuparci spontaneamente del mondo che ci circondava, di accogliere l’altro, scendendo dal palco. (Tempo dopo, Raj Patel, l’autore di I padroni del cibo, avrebbe definito Bono Vox come l’uomo del quale nessuno ha mai visto gli occhi, definizione in parte sbagliata: nel 1985 gli occhi di Bono erano ben visibili e seducenti e lo sarebbero rimasti per diversi anni; solo dal 1991 – dal video di «Zoo Station» – avrebbe cominciato a portare gli occhialoni neri.)
Insomma, noi ventenni avremmo seguito l’esempio.
In quel periodo, sulle spiagge italiane, o almeno su quelle che io frequentavo (il litorale tirrenico che da Baia Domizia si spinge fino a Serapo), cominciarono a vedersi i primi immigrati senegalesi. L’Africa che avevo conosciuto attraverso le foto aveva ora un volto più concreto.
In verità, i ragazzi che vendevano la merce apparivano spesso sorridenti e in carne, ma quando alla fine della loro giornata lavorativa tornavano a casa, carichi di roba invenduta, allora la nostra mente li ricollegava a quelle immagini di fame e solitudine. Ancora qualche mese e quegli stessi immigrati – in fondo, sulle spiagge, una presenza non inquietante – sarebbero giunti fino alle nostre città.
Caserta, per esempio, avrebbe visto crescere in maniera esponenziale (e ora sì, inquietante) le file davanti alla questura. Un nuovo ceto sociale povero reclamava cittadinanza. Toccava a noi giovani, cresciuti sposando di volta in volta cause giuste, occuparci di loro. La nostra prima volta in politica fu all’insegna di una nuova domanda: siccome questa causa è la più giusta fra le cause, come rappresentare gli immigrati senegalesi che arrivavano via mare fin da noi? Che immagini della loro cultura produrre?