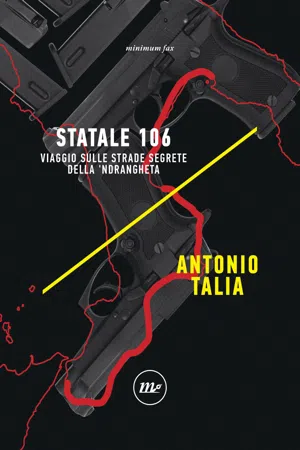![]()
1
KM 15, BOCALE
Per imboccare la SS 106 bisogna lasciarsi Reggio alle spalle, abbandonare le strade squadrate del centro affacciate sullo Stretto di Messina, le vecchie guerre e i nuovi equilibri delle periferie, una certa decadenza diffusa.
La città tuttavia mantiene un campo magnetico così potente che le sue influenze riaffioreranno anche lungo la costa, tanto che al termine di questo viaggio saremo costretti a tornarci per una resa dei conti finale.
Dopo una zona industriale semiabbandonata e l’aeroporto in declino da anni, lo svincolo che immette sulla Statale 106 spalanca un paesaggio costante per i successivi 104 chilometri: l’asfalto al centro, le colline a sinistra, la ferrovia e il mare a destra, un taglio che allude alla separazione tra calabresi di montagna e calabresi di marina, tipi antropologici diversi ormai intersecati attraverso generazioni di scambi e spostamenti.
Siamo partiti in un pomeriggio di primavera e il vento spira a grecale o a libeccio invece che a scirocco, quindi l’aria è limpida, le nuvole scorrono veloci e la luce taglia l’orizzonte senza accecare. In questo primo tratto la strada è ancora soffocata da scheletri di costruzioni incompiute, il sole si riflette su lamiere e moncherini di pilastri, ma superato il semaforo di Pellaro la catena di sfregi si interrompe per un po’ e il panorama inizia ad aprirsi.
È stato proprio lo scirocco a forgiare Bocale, tra gli anni Sessanta e gli anni Settanta. La classe dirigente reggina dell’epoca – amministratori, professionisti, avvocati, tutti coinvolti nel settore pubblico – fece costruire villette a ridosso del mare per fuggire dall’afa che paralizza la città quando il vento soffia da sudest per giorni.
Bocale sorge oltre Punta Pellaro, dove il vento di solito cambia, e allo stesso tempo dista solo dieci chilometri da Reggio, nel caso in cui il tuo rivale d’affari fosse riuscito a piazzare una gara d’appalto a tradimento in un tardo venerdì di fine luglio, costringendoti a correre in città per riempire qualche decina di documenti giusto cinque minuti prima della chiusura del bando.
Sono certo che molte delle residenze estive di Bocale siano state costruite soprattutto per tenere d’occhio i vicini. In queste ville si organizzavano cene, feste, ricevimenti, incontri riservati. Se qualcuno inventasse un’app capace di misurare quanti finanziamenti di opere pubbliche e quanti voti sono stati influenzati in un certo perimetro basterebbe puntarla qui intorno per fare schizzare l’ago.
Una stradina sulla destra conduce alla provinciale e dopo neanche un chilometro si avvista uno spiazzo circondato dagli eucalipti. Imboccando a piedi un sottopassaggio che scorre sotto la ferrovia si arriva finalmente alla spiaggia e al complesso di villette più riservate. Niente di sontuoso, perlomeno dall’esterno: sono edifici a due piani stuccati di bianco con portici e ampi cortili circondati da muri di cinta alti due o tre metri, il cui unico lusso evidente – strappato con chissà quale condono – consiste nell’affaccio diretto sulla spiaggia e in un magnifico panorama sullo Stretto.
La prima villa a sinistra ha i muri un po’ scrostati. Non è raro notare qualche movimento, forse un giardiniere che si prende cura delle bouganville, o qualcuno che arma una barca per andare a pescare, ma tutte le volte in cui sono stato qui i vicini mi hanno sempre raccontato che la famiglia non frequenta più la casa, alludendo alle cattive memorie di cui è ancora carica trent’anni dopo.
La villa apparteneva a Lodovico Ligato, ex giornalista, ex consigliere comunale, ex parlamentare, presidente dimissionario delle Ferrovie dello Stato – all’epoca la prima azienda d’Italia per numero di dipendenti – costretto a lasciare l’incarico dopo lo scandalo delle «Lenzuola d’Oro», una storia di appalti e mazzette che aveva azzerato i vertici dell’azienda.
Ligato viene assassinato qui nell’estate del 1989: il suo è allo stesso tempo la balena bianca degli omicidi di ’ndrangheta e un gigantesco rimosso collettivo. Non ci sono commemorazioni del delitto Ligato. Non esistono speciali tv girati con il materiale di repertorio Rai o documentari true crime per rievocare l’uccisione di uno dei boiardi di stato più potenti degli anni Ottanta, men che meno esistono premi o targhe alla memoria o vie a lui dedicate.
Lodovico Ligato non è il tipo di vittima che la politica vuole ricordare, anzi è proprio il genere di morto ammazzato da cancellare dall’album di famiglia il più presto possibile, quindi bisognerà basarsi sulle parole rese dai testimoni durante i tre gradi del processo e su qualche altra testimonianza raccolta direttamente, nella speranza di riuscire a ricostruire un contesto che si snoda su più piani e a renderlo in tutte le sue ambivalenze.
Nelle ore piccole tra il 26 e il 27 agosto 1989, Lodovico Ligato esce dalla villa per accompagnare due ospiti fino allo spiazzo degli eucalipti, dove la coppia ha parcheggiato l’auto. Si salutano, Ligato attraversa il sottopassaggio per rientrare a casa, e nel momento preciso in cui Giovanni Gentile inserisce le chiavi nella portiera lui e la moglie Maria Grazia Bottari avvertono una lunga sequenza di esplosioni provenienti dalla spiaggia, seguite da urla e lamenti. I due si rifugiano in auto, e qualche secondo dopo una moto con due persone a bordo sbuca ad alta velocità dal tunnel per poi sparire sulla strada provinciale.
Il cadavere del presidente dimissionario delle Ferrovie dello Stato giace sui gradini di casa sua a pochi passi dalla spiaggia e dai binari. Gli investigatori concludono che in totale sono stati sparati 35 proiettili e Lodovico Ligato è stato raggiunto da 26 colpi esplosi da tre armi diverse, due delle quali – una semiautomatica Glock calibro 9 parabellum e una Browning calibro 7,65 – erano già state impiegate in altri agguati.
La ricostruzione della dinamica mostra che Ligato, appena uscito dal tunnel, viene colpito da una prima raffica alla schiena. Cade, si rialza, cerca di fuggire verso casa. I sicari lo inseguono, continuano a sparare, e lo finiscono con quattro proiettili alla testa quando la vittima è già accasciata sugli scalini. Un’ultima pallottola viene esplosa verso la moglie, Eugenia Mammana, che è riuscita ad aprire il portoncino d’ingresso mormorando un disperato «Non ammazzate mio marito», per poi richiuderlo di scatto quando si è vista puntare una pistola addosso. Il colpo non va a segno, il figlio Enrico ritroverà il bossolo nel salotto della villa la mattina successiva.
Il delitto Ligato mette in ginocchio una provincia che è zona di guerra già da quattro anni e provoca onde telluriche che si propagano fino a Roma.
Il processo di rimozione inizia immediatamente.
Il Consiglio comunale di Reggio – in panne da giugno, dopo elezioni finite senza una vera maggioranza – riesce a nominare sindaco il democristiano Pietro Battaglia in una seduta da stato di emergenza, ma solo uno dei consiglieri, Agatino Licandro, si alza in piedi per commemorare Ligato.
La direzione provinciale della Democrazia cristiana elimina il suo nome da tutti i documenti successivi con una mossa da Unione Sovietica, mentre la DC reggina suggerisce sommessamente di andare a cercare i mandanti a Roma. Al funerale partecipano in pochissimi, la direzione nazionale non invia né comunicati né dirigenti. Quattro giorni dopo l’omicidio, a Palazzo Sturzo si svolge il consiglio nazionale della Democrazia cristiana: il presidente del partito Ciriaco De Mita conclude il suo discorso intorno alle 13.30 davanti a una platea composta dal gotha scudocrociato, ma né lui, né il segretario Arnaldo Forlani, né il presidente del Consiglio Giulio Andreotti e neppure il ministro per il Mezzogiorno Riccardo Misasi – da decenni potentissimo leader calabrese che di Lodovico Ligato è ritenuto il padrino politico – pronunciano una sola parola sull’assassinio dell’ex presidente delle Ferrovie dello Stato.
Il medium che irrompe sulla scena per evocare lo spettro che tutti vorrebbero dimenticare si chiama Oscar Luigi Scalfaro: «Ligato è nostro. Perché fu un nostro deputato, perché a quel posto di responsabilità non ci andò da solo. Se le nubi che si sono addensate sulla sua figura si concentrano e si aggravano, tirando fuori responsabilità e nefandezze, Ligato rimane nostro. Poiché non è pensabile che da qualunque tipo di errori, anche pesanti, noi si prenda le distanze. Vogliamo andare avanti in silenzio, passando oltre anche queste scene colorate di sangue? O vogliamo fermarci a meditare quanto taluni sistemi possono portare persino a conseguenze di questo peso?»
I cronisti si precipitano intorno ai leader per raccogliere reazioni, ma si scontrano con l’imperturbabilità più completa. «Nessun commento. Comunque Scalfaro dice sempre cose interessanti», risponde Andreotti. «Io non parlo. C’è Forlani a rappresentare la DC», dice De Mita. Forlani non dice nulla. Misasi si definisce un leader calabrese, ma allo stesso tempo sostiene di essere lontano dalla Calabria da tempo, e poi aggiunge: «Ho l’impressione che la ’ndrangheta non sia organizzata come la mafia. Sono cosche divise. Si ammazzano tra loro, tranne rari casi».
I quotidiani nazionali pubblicano articoli imbarazzati, col sottinteso che la parabola di Ligato ha incontrato la sua conclusione inevitabile.
Nel frattempo a Reggio è scattata l’invasione degli ultracorpi.
Sembra che nel giro di una notte qualche scienziato pazzo abbia sostituito gli stessi cittadini, professionisti e impiegati che nel 1979 e nel 1983 avevano incoronato Lodovico Ligato con ventunomila preferenze – rendendolo il parlamentare reggino più votato di sempre – con una moltitudine di sosia, tutti freneticamente impegnati nella costruzione di una realtà alternativa nella quale quel Ligato era solo una conoscenza occasionale, una comparsa di passaggio e non il dominus della politica locale dell’ultimo decennio, scelto da un elettore su tre.
L’imbarazzo della DC nazionale ha motivi abbastanza evidenti: il partito è in crisi di credibilità e la vicenda delle Lenzuola d’Oro aveva occupato stampa e tg per mesi. La dissociazione dei cittadini ha ragioni molto più profonde: l’intera provincia – e Reggio in particolare – teme di guardare in faccia il cadavere perché vedrebbe la propria immagine riflessa.
Esistono persone in grado di sintonizzarsi sulle frequenze più rarefatte di una città. Certi conducenti di mezzi pubblici sanno sempre con precisione che tipo di traffico troveranno; alcuni agenti immobiliari sono in grado di intuire come sta cambiando il mercato di un quartiere in base a segnali minimi come l’apertura di un singolo negozio; archivisti del catasto sanno collegare elementi distanti nel tempo per concludere che una certa zona è destinata alla prosperità o alla decadenza. Lodovico Ligato era esattamente il tipo di politico capace di sintonizzarsi con questo battito: figlio di macchinista in una città di ferrovieri, inizia rimpastando comunicati stampa per poi scalare i ranghi della Democrazia cristiana con polemiche incendiarie e attacchi che radono al suolo le basi degli avversari, dentro e fuori dal partito. Alto, imponente, voce tonante e gestualità prepotente, mette in piedi una corrente formata da abitanti del rione Portanova – ferrovieri, ovviamente – capaci di gestire pacchetti di voti sempre più pesanti e di schierarsi in qualsiasi incontro pubblico – dalla più insignificante riunione di quartiere ai consigli comunali – con una compattezza tale che tutti iniziano a chiamarli «i cinesi».
In una città dove il vento cambia tre volte al giorno e il fenomeno naturale più caratteristico è la Fata Morgana, un gioco di miraggi sulle acque dello Stretto, Ligato pratica con talento formidabile la tattica del riposizionamento continuo e l’arte della trappola basata sulle illusioni. La sua capacità di decifrare le vibrazioni di Reggio è assoluta, quindi non può che sfociare nella collusione con i motori più oscuri che dirigono la città.
Dopo due mandati in Parlamento, dove è stato più volte segretario della commissione Trasporti della Camera dei Deputati, nel 1985 per Ligato la consacrazione definitiva arriva con la presidenza delle Ferrovie, un ente che solo tra i dipendenti diretti conta oltre duecentomila persone, amministra circa trentaseimila miliardi di lire e dal quale, in forma diretta o indiretta, dipende un esercito di clienti. A proiettarlo al vertice della prima azienda d’Italia per numero di dipendenti è soprattutto l’appoggio del suo grande elettore a livello nazionale, Riccardo Misasi, ex ministro dell’Istruzione, ex capo della Segreteria politica della DC. Misasi che forse avverte in quell’ex allievo troppo promettente una possibile minaccia al suo status.
Attraverso tre gradi di giudizio gli investigatori stabiliranno che l’omicidio di Ligato costituisce il culmine della guerra di ’ndrangheta in corso.
Il suo cadavere si colloca al vertice di un conflitto iniziato nel 1985 e che prima della conclusione, nel 1991, provocherà la morte di un numero imprecisato di persone; tra le cinquecento e le settecento, una cifra che – con tutte le differenze del caso – assume un significato ancora più sinistro se ad esempio si pensa che nelle otto grandi stragi commesse in Italia tra il 1969 e il 1974 muoiono 149 persone.
La cosiddetta seconda guerra di ’ndrangheta inizia la sera dell’11 ottobre 1985: mentre Antonino Imerti detto «Nano Feroce» si trova all’esterno della società di assicurazioni di Villa San Giovanni che usa spesso come copertura per svariate attività criminali, qualcuno attiva una bomba nascosta in una Fiat 500 parcheggiata sul lato opposto della strada. L’esplosione riecheggia a chilometri di distanza e fracassa le vetrate di diversi palazzi della zona, ma quando i soccorritori arrivano sul posto trovano Imerti salvo per puro caso, circondato da quello che resta delle sue guardie del corpo. Dato che Imerti si rifiuta di pronunciare anche una sola parola, gli investigatori impiegheranno diverse ore per riconoscere i fratelli Angelo e Vincenzo Palermo e Umberto Spinelli, tutti sulla ventina.
La polizia trattiene brevemente Imerti, che continua a non dire niente, e lo rilascia, ma Nano Feroce almeno una parola con qualcuno deve essere riuscito a scambiarla, perché la rappresaglia viene servita nell’arco di quarantott’ore: Paolo De Stefano, capo di una famiglia che a Reggio coincide largamente con l’aristocrazia della criminalità organizzata, viene ucciso a colpi di pistola insieme a un guardaspalle mentre sta attraversando a bordo di una moto il suo territorio, il quartiere di Archi, nella zona nord della città.
Nel 1975 Imerti e De Stefano avevano stipulato un’alleanza che, tra tensioni e sospetti, aveva retto per dieci anni. Adesso che per qualche ragione sconosciuta quel lontano accordo è – letteralmente – saltato in aria, gruppi di uomini armati iniziano a percorrere le strade della città alla ricerca del prossimo bersaglio. I De Stefano sono legati ai clan Libri e Tegano sia da rapporti di business che da una ragnatela di matrimoni incrociati; gli Imerti hanno formato una «federazione» con altre tre famiglie, i Condello, i Serraino e i Rosmini. Nel giro di un mese il contagio si diffonde nel resto della provincia e tutti i clan della costa tirrenica e della costa jonica sono costretti a schierarsi da un lato o dall’altro, e spesso decidono di sfruttare la guerra in corso per regolare conti più antichi.
«Com’era vivere in quel periodo?» sarebbe una domanda naturale, ma come molte altre cose a Reggio rimane quasi sempre sospesa. Io avevo otto anni quando la guerra è cominciata, ne ho compiuti quattordici quando è finita, e per quanto imbarazzante possa essere ammetterlo oggi, la verità è che per un bambino riflessivo, pieno di immaginazione e senza una reale comprensione del concetto di morte, tutto il clima aveva qualcosa di sinistramente eccitante. Crescevo leggendo i romanzi gialli che mia madre lasciava in giro e il quotidiano locale di mio padre, pieno di dettagli sull’ultima esecuzione. Nella mia testa Sherlock Holmes e Philip Marlowe davano la caccia a Nano Feroce e indagavano sulla morte di Lodovico Ligato, mentre il resto d’Italia guardava a quello che stava succedendo a Reggio Calabria con orrore e disgusto o l’indifferenza del lasciate-che-i-terroni-si-ammazzino-tra-loro. Tutto quello che sapevo era che nella mia città morire uccisi a colpi di pistola era una cosa assolutamente ordinaria.
Mi ricordo una serata trascorsa sul sedile posteriore dell’auto di mio padre con mamma, zio e zia, inseguiti per un lungo tratto della Statale 106 da due o tre uomini a bordo di un’Alfa scura. Se mio padre accelerava, l’Alfa ci rimaneva attaccata dietro. Se rallentava, si rifiutavano di sorpassare. Alla fine, raggiunta la periferia di Reggio, l’Alfa sparì in una via secondaria, lasciando la mia famiglia a interrogarsi su ipotesi contrastanti: un gruppo di sicari che aveva seguito l’auto sbagliata o semplicemente tre mentecatti che avevano improvvisato uno scherzo idiota per godersi il clima dell’epoca.
Mi ricordo di avere sentito colpi di pistola per strada in almeno tre occasioni, da solo o in compagnia di mia madre, e l’evento diventava sempre più comune mentre i killer si facevano sempre più spavaldi. Colpiscono in ospedale: nell’aprile del 1986 il capo dei Serraino, Francesco, detto «il boss della montagna», si trova in terapia antidiabetica agli Ospedali Riuniti. I suoi uomini hanno requisito un intero piano, ma la precauzione non impedisce a un commando dei De Stefano di far...