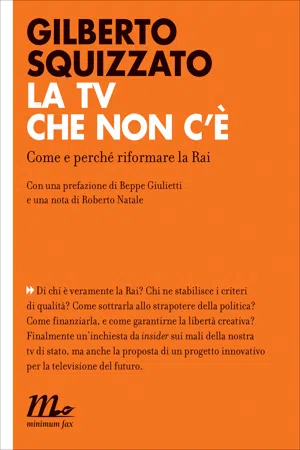1. TRENT'ANNI IN RAI, A MILANO
Avendo deciso di parlare dello stato attuale della Rai, mi pare giusto offrire prima qualche breve nota personale che possa dar meglio l’idea del tipo di attraversamento che mi ha permesso per trent’anni di esplorare gran parte di questa realtà aziendale, di studiare le logiche e le regole (talvolta assurde, spesso non molto nobili) che la governano, di conoscerne qualche recesso più o meno riservato, di decodificarne la mappa genetica progressivamente mutata con il mutare dei padroni.[1]
Quando il 2 luglio del 1979, all’età di trent’anni, entrai in Rai per essere assunto come giornalista praticante presso la redazione di Milano, avevo già un lavoro. Mi ero procurato, con anni di supplenze e superando l’esame di abilitazione, un posto come insegnante di italiano e storia nell’Istituto Tecnico di Busto Arsizio, la città dove sono nato e tutt’ora continuo a vivere (avendo rinunciato più volte all’invito di diversi dirigenti Rai a trasferirmi a Roma: non per snobismo nordista, ma per la convinzione che Milano dovesse e debba tornare a essere un luogo nevralgico dell’elaborazione e della produzione editoriale della Rai).
Non ero dunque un pivello, anche perché, già quand’ero studente di lettere moderne alla Statale di Milano, avevo cominciato a lavorare nel cinema, frequentando gli studi cinematografici Icet-De Paolis di Cologno Monzese, che erano allora di proprietà di Francesco Corti, che li avrebbe successivamente venduti a Silvio Berlusconi, astro nascente della tv commerciale. Di lì transitavano tutte le produzioni cinematografiche che venivano a Milano a realizzare i loro film, e se volevo imparare sul campo qualcosa di cinema (mentre all’università mi procuravo una preparazione di base, teorica e linguistica[2]), quello era l’unico posto dove potevo cercare un contatto con chi il cinema lo sapeva fare davvero: artigiani e artisti che negli studi della Icet, e in tanti esterni milanesi e lombardi, impiantavano i loro set, ai quali cercai di accedere prima come assistente volontario, poi come assistente retribuito con paga settimanale, infine come secondo o primo aiuto regista.
Per farla breve: fu sul set che conobbi Mario Amendola, uno dei maestri della commedia italiana degli anni Sessanta, e poi Alberto Lattuada, Carlo Lizzani e molti altri registi, autori, sceneggiatori, direttori della fotografia, e numerose star del grande schermo, da Rod Steiger a Henry Fonda, da Sophia Loren a Giancarlo Giannini. Ed ebbi il privilegio di imparare moltissimo anche dalla maestra delle segretarie di edizione del cinema italiano, Vittoria Vigorelli, madre di Piero, che in seguito sarebbe stato mio direttore al Tgr.[3]
Se in Lattuada mi poteva colpire l’eleganza della forma filmica, il perfezionismo quasi maniacale nella costruzione dell’inquadratura e nella direzione degli attori, diversa e molto più decisiva fu per me la scuola di Lizzani, di cui fui aiuto regista prima sul set di Mussolini ultimo atto (ai tempi un kolossal con migliaia di comparse in costume) e subito dopo in due instant movie a basso budget, ideati, scritti, girati e montati in soli tre mesi: Storie di vita e malavita, sulla prostituzione minorile, e San Babila ore 20, sul neofascismo milanese. Che cosa c’era da imparare da Lizzani? Era un uomo capace di governare magistralmente la poderosa, complessa macchina di un grande film storico, e di scrivere e realizzare in poche settimane dei film con costi ridottissimi su sceneggiature «aperte», accogliendo dalla realtà, giorno per giorno, gli stimoli e i suggerimenti offerti dalla cronaca e affidando perfino il ruolo di protagonisti a personaggi autentici presi dalla strada. Stupefacente era per me la capacità di Carlo di assumere decisioni rapidissime di ideazione e di regia che avevano una prodigiosa efficacia: fu una lezione che mi sarebbe servita moltissimo quindici anni dopo, quando Angelo Guglielmi mi chiamò a inventare per Rai Tre nuove formule narrative per la tv, che si chiamarono di volta in volta docufilm, film-cronaca, docufiction.
Così, mentre alla Statale il Movimento Studentesco della triade Capanna-Cafiero-Toscano inventava il turbolento Sessantotto italiano, sul set potevo ascoltare le testimonianze dirette di Lizzani che evocava i suoi anni giovanili, quando ospitava clandestinamente in casa sua i capi della Resistenza di Roma occupata dai tedeschi, e l’esperienza come aiuto regista e sceneggiatore al fianco di Rossellini che aveva appena coniato il neorealismo italiano. E intanto partecipavo da vicino, in diretta e nel mio piccolo, muovendo le comparse e occupandomi del cast dei ruoli minori, alle riprese delle scene dei suoi film in lavorazione a Milano e dintorni.
Progettavo dunque di dedicarmi al cinema quando nel ’78 il caso mi offrì la possibilità di iscrivermi alla selezione Rai per registi/programmisti che avrebbero lavorato nella neonata Rai Tre, non immaginando certo che in Rai sarei entrato un anno dopo, per altra via e per svolgere inizialmente un altro lavoro. In effetti, quando uscirono le graduatorie che alla sede di Milano dovevano assegnare il posto per quattro registi, risultai nella quaterna selezionata ma per un anno tutto tacque finché non mi giunse l’imprevista telefonata che mi cambiò la vita. Convocato a corso Sempione da Mariolino Mauri, allora caporedattore del Tg Rai, mi sentii chiedere a bruciapelo: «Vuol essere assunto come giornalista?» Caddi dalle nuvole. È vero, per cinque anni avevo diretto Foglio 5, un periodico molto combattivo del dissenso cattolico della mia città, ma non avevo mai pensato di fare del giornalismo la mia professione. Che fare? L’occasione di essere assunto per lavorare nel «servizio pubblico» non potevo certo lasciarmela scappare. Tentiamo, mi dissi, e fui assunto in prova.
Se ho descritto questo passaggio apparentemente solo autobiografico del mio ingresso in Rai è perché esso costituisce invece il paradigma di tante altre decine, centinaia di storie di giornalisti del servizio pubblico, almeno fino alla fine degli anni Novanta. Cos’era infatti successo perché potesse aver luogo la mia assunzione in Rai? Mi bastarono poche ore dopo il mio primo ingresso in redazione per venire a sapere che ero già stato messo «in quota» al Pci. Non che la cosa mi turbasse, sul primo momento: dal 1975 ero consigliere comunale della mia città, eletto, come indipendente, nella lista di quel partito. Ma fui fortemente stupito dalla potenza della politica che mi si rivelò in quell’occasione come elemento decisivo per l’ingresso in Rai di gran parte dei giornalisti. Venni infatti a sapere che dei quattro posti di redattore disponibili per il nascente tg regionale della Lombardia uno spettava alla Dc, uno al Psi, uno al Pci e l’ultimo, per accordo sindacale, a un giornalista disoccupato. All’ultima ora il designato dal Pci (un ottimo cronista dell’Unità di Milano) aveva rinunciato ed essendo necessario far subito un nome all’ufficio del personale – che aveva pronta la pratica per l’assunzione e non poteva far aspettare gli altri tre già designati – un membro del comitato di redazione di area comunista della Rai di Milano, Marino Giuffrida, aveva fatto il mio. Aveva apprezzato il mio curriculum e la mia buona prestazione nel concorso dell’anno prima a un posto di regista.
Così da quel giorno eccomi in Rai, sempre a Milano, prima come praticante, poi come redattore, caposervizio e caporedattore, e poi ancora, dall’inizio degli anni Novanta, come autore e regista per Rai Uno e per Rai Tre. Dopo aver realizzato migliaia di servizi giornalistici e centinaia di speciali e reportage – meritandomi anche qualche riconoscimento significativo come il Premio Europa e il Premio internazionale per il reportage televisivo al Festival della Tv di Montecarlo – la Rai, per un imprevedibile gioco di combinazioni, mi chiese infatti, nel 1990, di svolgere esattamente quell’attività per cui ero stato selezionato nel concorso di dieci anni prima: ecco perché, lavorando per sette direttori di rete (Guglielmi, Locatelli, Tantillo, Saccà, Zucchelli, Cereda, Ruffini), mi sono dedicato da allora alla creazione di nuovi modelli di narrazione televisiva (oggi si direbbe «format») che fondono cinema e racconto della cronaca e della storia, sempre ispirandomi a situazioni e problematiche assunte dalla realtà per rimodularle dentro lo schema della narrazione cinetelevisiva.[4]
La storia del mio ingresso in Rai mostra come corrisponda ad assoluta verità la diceria ampiamente diffusa secondo la quale gran parte delle assunzioni dei giornalisti in Rai sono state per lungo periodo sponsorizzate e/o decise dai partiti. Non ho ragione di negarlo, e questo è anzi uno dei nodi essenziali che affronto in queste pubbliche riflessioni sull’attuale condizione e sul destino (possibile) della Rai. È proprio da qui che voglio partire per andare rapidamente a evidenziare le contraddizioni (e le assurdità, anche «istituzionali») che hanno portato la Rai alla sua attuale condizione che rende sempre più difficile giustificarne l’esistenza stessa come «servizio pubblico». E aggiungo che la mia scelta di restare a Milano mi è stata molto utile per capire quanto e come lo stesso DNA della Rai sia cambiato nel tempo: le cose che accadono a Roma in viale Mazzini, se osservate da un punto di vista esterno e lontano, appaiono molto più chiare ed evidenti nelle loro logiche, spesso sconcertanti. È il contesto generale infatti, è il quadro d’insieme, e non il momentaneo capriccio del palazzo, a spiegare il perché di quanto accade: ma per capire il contesto bisogna disporre di una visione d’insieme che colleghi fatti ed elementi apparentemente molto lontani, anche nel tempo.
[1] Vale forse la pena di informare il lettore che pagando il canone paga anche il mio stipendio, quello tabellare di giornalista caporedattore. Preciso questo perché non mi piace essere confuso con chi parla del presente e del futuro della Rai rilasciando autorevoli interviste da poltrone confortate da retribuzioni ben più gratificanti, che meriterebbero peraltro, come quelle di tanti altri dipendenti pubblici, per esempio della sanità, di essere pubblicate su internet.
[2] Erano gli anni in cui la Statale di Milano era un crocevia delle grandi correnti del pensiero storico e filosofico e dove insegnavano figure come Enzo Paci e Gillo Dorfles, Remo Cantoni e Carlo Salinari, Franco Fornari e Mario Dal Prà.
[3] Tgr è il telegiornale regionale della Rai.
[4] Da quella data ho realizzato, fino al 2005, tredici serie televisive: prima di docufiction e poi di fiction (anche se io a questa definizione di genere preferisco quella di «real movie»), per un totale di più di ottanta ore. I miei real movie hanno rappresentato la Rai a Bruxelles, a Berlino, a Ginevra, a Venezia, ho vinto il Premio internazionale Flaiano per la fiction con I racconti di Quarto Oggiaro e la mia fiction storica L’uomo dell’argine è entrata nella terna finale del Premio Saint-Vincent.