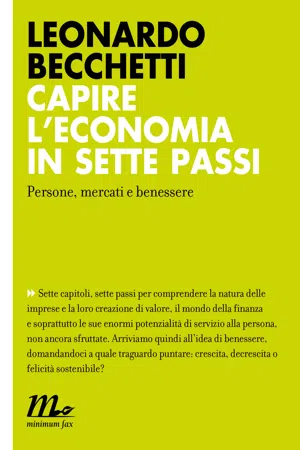![]()
1. IL CIRCUITO DI BASE DELL’ECONOMIA.
UN INTRECCIO DI PERSONE E DI MERCATI
L’esplorazione del pianeta economia non può che partire dal «circuito del reddito». Se guardiamo a come e dove il denaro circola, ci accorgiamo che l’economia non è altro che una serie di mercati (dei beni/servizi e del lavoro prima di tutto) dove «famiglie» e «imprese» interagiscono con ruoli diversi. Le famiglie (o gli individui o i nuclei familiari) domandano beni o servizi come consumatrici nei mercati dei beni (la domanda di beni) e offrono le proprie prestazioni professionali sul mercato del lavoro (l’offerta di lavoro). Le imprese vendono beni o servizi sul mercato dei beni o servizi (l’offerta di beni) e scelgono le combinazioni di fattori produttivi domandando lavoro sul mercato del lavoro (la domanda di lavoro).
L’economia è essenzialmente e primariamente un intreccio di persone e mercati.
Su questi ingranaggi di base si innestano meccanismi e attori più complessi. Come ad esempio lo Stato, che raccoglie risorse con le tasse ed eroga con la sua spesa beni e servizi pubblici che il settore privato non è in grado di fornire. Come le diverse istituzioni a esso collegate, che creano la moneta necessaria a «oliare» gli scambi e definiscono alcune fondamentali regole del gioco.
Già qui gli economisti di vecchio stampo peccano di insostenibile leggerezza e si rendono colpevoli di un primo difetto riduzionista ignorando gli effetti ambientali della produzione nel circuito del reddito che si insegna tradizionalmente nei libri di primo anno. Lo schema classico del circuito del reddito nasceva in un’epoca in cui i problemi ambientali erano lontani e il vincolo delle risorse ambientali sembrava inesistente. E infatti è come se in questo circuito tutta la pesantezza degli scambi di merci evaporasse, si volatilizzasse nei vari passaggi non lasciando nessuna «scoria». Purtroppo non è così, perché il consumo genera rifiuti, e il processo produttivo dà origine a scorie e residui. Rifiuti e scorie vanno smaltiti, e danno luogo a loro volta a nuovi settori e circuiti economici oggi sempre più importanti. Accanto alle transazioni monetarie e agli scambi di mercato esiste pertanto una contabilità delle risorse ambientali che non può e non deve essere trascurata.
I mercati, elemento fondamentale di quest’intreccio, sono come sappiamo oggetto di dispute ideologiche appassionate tra sostenitori e detrattori. Essenzialmente essi sono un meccanismo quasi provvidenziale che automaticamente incrocia i gusti dei consumatori con la disponibilità/scarsità dei beni e le possibilità offerte dalla frontiera delle tecnologie produttive originando, attraverso l’incontro della domanda e dell’offerta, quei prezzi di mercato che sintetizzano il valore (appunto di scambio) dei beni. Tutto questo avviene attraverso un meccanismo decentralizzato, senza che alcuna autorità centrale debba fare l’immane fatica di raccogliere ed elaborare la domanda dei consumatori e le decisioni di produzione dell’offerta decidendo poi quanto e cosa ciascuno deve produrre. Tutte le volte in cui si è tentato di sostituire il mercato con la pianificazione i risultati sono stati miseri perché nessun pianificatore ha l’onniscienza necessaria per organizzare un processo del genere sostituendosi alle dinamiche spontanee di domanda e offerta e ai loro effetti sui prezzi. Semplicemente, osservando un prezzo che sale sappiamo che c’è dietro una scarsità di offerta o un aumento di domanda e le forze di mercato si adattano ai segnali inviati dai prezzi modificando le loro scelte di domanda e offerta fino ad arrivare all’equilibrio.
I mercati hanno molti pregi ma altrettanti difetti che vengono al pettine quando qualcuno semplicisticamente ci vuol far credere che bastino da soli a condurci verso il traguardo del bene comune.
Il pregio principale dei mercati è quello di produrre la mutua soddisfazione dello scambio. Se due persone decidono di effettuare una transazione sul mercato (o se per esempio due squadre di calcio si scambiano calciatori) vuol dire che quello scambio sta migliorando (o almeno non peggiorando) la situazione di entrambe le persone o le squadre. Questo stesso pregio può diventare un difetto in alcuni scambi che ci appaiono come iniqui e di cui in un certo senso accusiamo il mercato. Una persona molto povera può decidere di vendersi un rene per migliorare la sua condizione economica. O una/un minorenne in un paese tropicale può vendere il suo corpo a un ricco turista straniero. In queste transazioni c’è qualcosa che ci indigna quand’anche il principio della mutua soddisfazione nello scambio venisse rispettato nelle volontà delle controparti che ipotizziamo, per semplicità, perfettamente libere nelle loro decisioni. Il motivo è che il mercato nulla fa per migliorare l’enorme diseguaglianza delle condizioni di partenza che può dar luogo a quest’ultimo tipo di scambi «iniqui». Abbiamo dunque individuato uno dei maggiori limiti del mercato (per il quale esso necessita di correttivi e integrazioni): l’incapacità di risolvere i problemi distributivi di partenza (le differenze di dotazioni di ricchezza) con le quali due individui arrivano alla transazione. Ancora dal lato dei pregi il mercato ha però una straordinaria capacità di soddisfare i desideri della «maggioranza pagante». Ma questo, oltre che un pregio (se mi domando perché alla stazione o all’aeroporto non c’è un buon gelato o una buona pizza, e se siamo in tanti a domandarcelo e a desiderarlo, e il mercato è libero, probabilmente il gelato e la pizza di qualità arriveranno), è anche allo stesso tempo un difetto, perché per poterne godere bisogna appunto essere maggioranza e paganti (inutile aspettarsi che il mercato risolva il problema dei vaccini per le malattie rare, o ti aiuti a trovare quella pellicola del cinema russo d’avanguardia di cui sei uno dei pochissimi estimatori).
Un altro difetto del mercato dipende in realtà dalla nostra incapacità di distinguere tra il prezzo di scambio e il valore intrinseco di un bene o di un servizio. Il prezzo di mercato, come sappiamo, dipende dalla combinazione di gusti/domanda dei consumatori e scarsità/progresso tecnologico/offerta dei produttori/offerenti. Un bene/servizio può costare moltissimo perché la domanda è enorme e la disponibilità relativamente limitata. Ma questo non vuol dire che quello stesso bene/servizio abbia effettivamente tutto quel «valore» in base alla nostra scala di giudizio morale o sociale. In questo caso il difetto del mercato è in realtà quello dell’afasia della nostra cultura, che non riesce per un determinato bene o servizio ad affiancare al prezzo di scambio di mercato un «valore» moralmente o socialmente condiviso. Per fare un esempio, il «salario» di una velina di successo può essere (ed è) enormemente più elevato di quello di un’insegnante elementare, ma questo non vuol dire che la professione della prima «vale» enormemente di più rispetto a quella della seconda (anzi...). Per citare un altro caso famoso e abnorme, il mercato premiava l’amministratore delegato di Lehman Brothers l’anno prima del suo fallimento con una remunerazione lorda che un insegnante di scuola avrebbe potuto accumulare ad oggi solo iniziando a lavorare dall’epoca dei Sumeri. Ma questo divario di reddito non ci dice nulla della differenza di valore tra i due professionisti e del loro effettivo contributo al benessere sociale (anzi...).
Il modo in cui il mercato riesce ad accomodare i desideri delle due parti nell’espressione sintetica di un prezzo di equilibrio, senza alcun intervento formale di un banditore o di un’autorità che raccolga e cerchi di mettere insieme i gusti dei consumatori e le possibilità di produzione dal lato dell’offerta, ha del miracoloso. Il rovescio della medaglia è che quando tentiamo di intervenire in questi meccanismi fissando dei prezzi «amministrati» o «politici» – quando in sostanza vogliamo essere noi a decidere il prezzo al posto del mercato – il mercato «si vendica» creandoci una serie di problemi.
Per dirne una, se decidiamo che un certo bene o servizio (la sanità ad esempio, o in passato le derrate alimentari di base in certi regimi politici) è di importanza primaria e il prezzo deve essere minore di quello stabilito dal mercato per garantire accessibilità a tutti, il mercato «si vendica» e ne riduce l’accessibilità. Prezzi molto bassi infatti creano un aumento della domanda e una riduzione dell’offerta, producendo eccessi di domanda. Gli eccessi di domanda in concreto si trasformano in file per acquistare (se la domanda è maggiore dell’offerta non tutti saranno soddisfatti ed è meglio dunque cercare di essere tra i primi della fila per sperare di trovare qualcosa) e in scaffali semivuoti (quelli che trova chi si è messo in fila troppo tardi). Non è un caso che quando scegliamo la sanità pubblica troviamo prezzi bassi (al netto di ticket oggi sempre più elevati) ma dobbiamo prendere il numeretto (o un disco telefonico ci avvisa che la nostra operazione è fissata di qui a tre anni). Quando invece ci rivolgiamo alla sanità privata le analisi si possono fare e ritirare nel minor tempo possibile (ovviamente pagando di più). Come si risolve il dilemma? Meglio il prezzo politico e doversi sorbire la fila rischiando di trovare lo «scaffale vuoto», o meglio evitare che il mercato si vendichi e quindi non fissare prezzi «politici» col rischio però di non rendere più accessibili ai meno abbienti prestazioni fondamentali? La soluzione pragmatica di tutti i sistemi sanitari nazionali è un un mix di pubblico e privato (con il tentativo di usare la tecnologia, ad esempio nella gestione delle file, per ridurre al massimo il costo dell’attesa nel pubblico) ma la scelta della combinazione tra i due è oggetto come sappiamo di aspre contese politiche e sociali. E sui tagli alla sanità pubblica si discute se impediranno esami fondamentali per la salute o analisi inutili e in eccesso perché gratuite.
Ma il vero grande miracolo che produce il mercato è quello di trasformare, attraverso la concorrenza, una somma di egoismi privati (i desideri di massimo profitto di ciascun imprenditore) in bene per tutti. Il meccanismo è semplice: gli imprenditori, per cercare di vendere il loro prodotto a scapito di quello dei concorrenti, devono abbassare il prezzo aumentando progressivamente il «surplus del consumatore». Ovvero la differenza tra il prezzo massimo che un consumatore sarebbe stato disposto a pagare per un bene e quello che effettivamente paga sul mercato. Per fare un esempio, il cellulare è oggi considerato dai più un bene fondamentale. Pur di averlo, pur di non restarne senza, saremmo forse disposti a pagare 1000 euro. Supponiamo di poterne comprare sul mercato uno della qualità che vogliamo che costa la metà. In quel caso 500 euro è il guadagno che la concorrenza di mercato produce per il consumatore in termini di surplus. Nel modello di concorrenza perfetta il gioco competitivo arriva all’estremo di un prezzo di equilibrio che annulla gli «extra profitti» dell’imprenditore lasciando lo spazio solo per una legittima remunerazione del suo lavoro. Il paradosso liberale dunque è che la concorrenza produce un risultato positivo (l’annullamento dei profitti) senza che tale risultato sia imposto dall’alto. E la conseguenza potenzialmente liberatoria del modello è che non c’è bisogno di avere preoccupazioni morali (né dal lato della domanda né da quello dell’offerta) perché il risultato positivo per la società (la riduzione del prezzo e l’aumento del benessere del consumatore) si produce semplicemente per via dei meccanismi automatici della concorrenza.
Tana libera tutti, dunque, ma... c’è un ma gigantesco.
Purtroppo le condizioni sotto le quali il paradosso «quasi-comunista» della concorrenza funziona (e il surplus del consumatore è massimo) sono talmente difficili da realizzare che qualcuno ha fatto l’analogia tra il modello di concorrenza perfetta e la teoria del moto in assenza di attriti in fisica (ovvero un caso limite utile per capire e a cui tendere, ma che di fatto non si realizza mai). Le condizioni difficili da realizzarsi congiuntamente sono infatti: I) libero accesso al mercato di potenziali nuovi concorrenti; II) omogeneità del prodotto (tutti devono produrre esattamente la stessa cosa); III) informazione perfetta (il consumatore sa tutto di ciò che gli viene offerto); IV) numero molto elevato di concorrenti; V) assenza di beni pubblici (una particolare tipologia di beni per i quali non valgono i criteri dell’escludibilità e della non rivalità, in base ai quali un panino che acquisto è mio e non può essere acquistato né consumato da altri a meno che io non vi rinunci o non ne regali una parte) e VI) assenza di esternalità negative (ossia gli effetti indiretti, anche se non voluti, delle nostre azioni su ogni altro essere umano). Si dà il caso che il mondo sia pieno di beni pubblici (qualità dell’aria, dell’acqua, salute, istruzione, sicurezza, difesa eccetera), e che la potenza degli esseri umani consista proprio nel non essere dei burattini instradati su binari dai quali è impossibile influire sulle vite degli altri. La forza della nostra libertà è invece tale che le nostre azioni possono avere effetti indiretti (anche involontari) molto ma molto seri su altri nostri simili. Casi classici di esternalità negative in economia sono ad esempio l’inquinamento e la congestione stradale.
Se l’utopia della concorrenza perfetta è quasi irrealizzabile gettiamo a mare concorrenza e mercato? Non proprio. Intanto prendiamo coscienza del fatto che la concorrenza di mercato e le condizioni che ne assicurano il miglior funzionamento non sono uno stato di natura ma richiedono interventi istituzionali volti a promuoverle (non a caso in tutti i paesi esistono autorità garanti della concorrenza e del mercato). E in secondo luogo accettiamo il fatto che è la combinazione di mercato e interventi istituzionali che può aiutarci a muovere verso il bene comune. Laddove sono questi ultimi che assicurano il livello ottimale di fornitura di beni e servizi pubblici e fissano regole o tasse tali da eliminare gli effetti negativi delle esternalità, facendo nuovamente coincidere interesse privato (corretto con l’incentivo della tassa o inibito dal regolamento) e interesse pubblico.
Insomma, dopo questa rapida ricognizione, più che una mano invisibile (un po’ malferma e tremolante, in verità) che fa tutto da sola automaticamente, il mercato a noi piace immaginarlo come una bicicletta. Uno strumento con potenzialità interessanti ma che può funzionare a nostro vantaggio solo con il nostro impegno e con la nostra compartecipazione. In economia non ci sono pasti gratis e tocca pedalare.
Se passiamo ora all’altro termine di quell’intreccio di persone e mercati che è l’economia, ci accorgiamo di come l’economia inquadri la persona nei suoi due ruoli fondamentali (consumatore e lavoratore), che spesso peraltro sono in conflitto tra loro e rischiano di renderci schizofrenici: comprare un prodotto a bassissimo prezzo è un successo per l’uomo-consumatore, un successo che magari un uomo-lavoratore di quella filiera di prodotto sta scontando con il suo lavoro malpagato e precario, un successo che può persino mettere a rischio il futuro come lavoratore di quello stesso uomo-consumatore. È noto che i modelli, proprio come le cartine geografiche, sono delle mappe estremamente semplificate. Devono cogliere gli aspetti essenziali tralasciando i dettagli per aiutare gli utenti a orientarsi nella giungla della realtà. Ma l’economia tradizionale qui semplifica un po’ troppo, proponendoci una visione un po’ ridotta della persona (il cosiddetto homo economicus). Essenzialmente la persona in economia è razionale e massimizzante. Arriva al supermercato con una quantità limitata di soldi nel portafoglio e la usa in modo tale da massimizzare la propria soddisfazione, acquistando quella combinazione di beni che gratifica maggiormente le proprie preferenze e la propria utilità. La somma di queste scelte individuali ottimali in funzione dei prezzi diventa la curva di domanda aggregata, quella che le politiche economiche cercano di stimolare per far crescere il Pil. In tutto questo (come al solito) c’è un pregio e un difetto. Il pregio è che l’homo economicus è un homo faber, ovvero una persona positiva e proattiva. Sa che nella vita esistono dei vincoli (di tempo, di tecnologie e di denaro) e ne tiene conto, ma non si consuma leopardianamente nell’interrogarsi sul perché la natura sia più o meno matrigna. Piuttosto impiega il suo tempo nel cercare di estrarre il massimo beneficio possibile dati i vincoli del problema, evitando gli eccessi opposti di inefficiente uso delle risorse a disposizione e di velleitarismo (voler andare oltre quanto possibile). In questo senso l’homo economicus racchiude in piccola parte le virtù dell’atleta paralimpico. Ovvero, parte dal dato di fatto del suo vincolo lanciando una nuova sfida per ottenere il meglio.
Il difetto è che l’homo economicus è stato un po’ ridotto, anche per colpa degli economisti, a una specie di smemorato di Collegno. Vale a dire che il problema operativo dell’uso ottimale delle risorse monetarie per scegliere la giusta combinazione di beni è stato scisso (almeno fino a pochissimo tempo fa) dal problema a monte, ovvero dall’indagine sulle caratteristiche delle preferenze e delle sorgenti di senso che spiegano le sue scelte.
Basta uscire un po’ dall’accademia e osservare la vita reale per accorgersi che il modello dell’homo economicus, ignorando che siamo essenzialmente «cercatori di senso», si perde veramente troppo della realtà.
Ad esempio perde tutta la dimensione della gratuità e del volontariato che gli ortodossi homoeconomicisti si sforzano di infilare nella camicia di forza dell’opportunismo senza il quale non riescono proprio a «teorizzare». Chi si dedica al volontario lo fa per riempire il curriculum e sperare di ottenere benefici futuri in termini di buoni posti di lavoro. E allora i pensionati che fanno i volontari? Ma ciò che mette in crisi ancora più fortemente il modello homoeconomicista sono i comportamenti «identitari», ovvero le decisioni di tutte quelle persone che per conformarsi a un gruppo o a un’identità collettiva scelgono comportamenti «irrazionali» secondo il paradigma dell’homo economicus, comportamenti che non aumentano ma addirittura diminuiscono e mettono a rischio le loro capacità di consumo, risparmio e accumulazione di denaro. Se eccettuiamo un’élite di furbi che sfrutta violenza, guerre e conflitti per tornaconti economici, come spieghiamo il fatto che adesioni a movimenti fanatici diventano scelte di popolo? Come si fa a spiegare con l’homo economicus Boko Haram, l’Is, vari integralismi e molti altri fenomeni dei nostri tempi? Perché alcuni ragazzi (anche educati ragazzi occidentali) invece di comportarsi da bravi consumatori e impegnarsi a sfondare secondo i canoni del sogno americano per poter mettere da parte dei soldi e farsi una bella vacanza, finiscono in scelte così controverse?
Il paradigma che dovrà progressivamente sostituire quello dell’homo economicus se vogliamo cercare di spiegare un ventaglio più ampio di azioni umane è quello del cercatore di senso. Ogni mattina, quando ci...