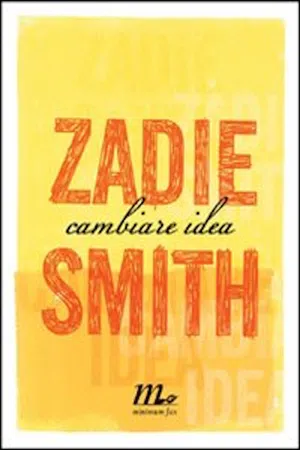![]()
LETTURE
![]()
I LORO OCCHI GUARDAVANO DIO:
COSA SIGNIFICA SOULFUL?
Quando avevo quattordici anni mia madre mi regalò I loro occhi guardavano Dio. Ero riluttante all’idea di leggerlo. Sapevo quali fossero le sue intenzioni nel darmelo, e la cosa mi infastidiva. Con lo stesso spirito, mi aveva incoraggiato a leggere Il grande mare dei Sargassi e L’occhio più azzurro, e nessuno dei due mi era piaciuto (o, per meglio dire, non avevo permesso che nessuno dei due mi piacesse). Preferivo la mia eterogenea lista di titoli liberamente scelti. Ero orgogliosa di spaziare in lungo e in largo nelle mie letture, senza mai farmi guidare, nella selezione, da ragioni di natura razziale o socioculturale. Vedendo il romanzo rimasto intonso sul mio comodino, mia madre insistette:
«Vedrai che ti piacerà».
«Perché, perché è di colore?»
«No, perché è davvero ben scritto».
Io avevo le mie idee sulla «buona scrittura». Era una categoria che non includeva il linguaggio aforistico o apertamente «lirico», l’immaginario mitico, la resa accurata della «parlata popolare» o le tribolazioni amorose delle donne. Ancor prima di aprire il libro, le mie difese letterarie si erano già innalzate. Poi lessi la prima pagina:
I desideri degli uomini viaggiano a bordo di navi lontane. Per alcuni arrivano in porto con la marea. Per altri navigano in eterno all’orizzonte, mai fuori vista, mai in porto, finché chi sta di vedetta non distoglie gli occhi rassegnato, i suoi sogni sbeffeggiati a morte dal Tempo. Tale è la vita degli uomini.
Le donne... Beh, le donne dimenticano tutto quello che non vogliono ricordare, e ricordano tutto quello che non vogliono dimenticare. Il sogno è la verità. E loro agiscono e si comportano di conseguenza.
Era un aforisma, eppure mi aveva inchiodata a terra, incapace di negarne la forza. Tempo era scritto con la maiuscola (io ero contro l’uso delle maiuscole per i nomi astratti), eppure mi ritrovai a provare tristezza per questi uomini senza nome e le loro inevitabili perdite. Quanto alla seconda parte, quella sulle donne, colpì nel segno. Rimane a tutt’oggi la più accurata descrizione di me e mia madre che abbia mai letto: «E loro agiscono e si comportano di conseguenza». E va bene, d’accordo. Mi rilassai un po’ sulla poltrona e posai la matita. Quel libro lo inalai. Tre ore dopo l’avevo finito e versavo lacrime a profusione, per ragioni che avevano a che fare solo fino a un certo punto con il tragico finale.
Ho perso diverse battaglie letterarie il giorno in cui ho letto I loro occhi guardavano Dio. Dovetti riconoscere che ogni tanto gli aforismi hanno una loro efficacia. Dovetti rinunciare all’idea che Keats avesse il monopolio sul lirismo:
Era distesa sulla schiena sotto il pero, immersa nel ronzio acuto delle api, nell’oro del sole e nell’ansito della brezza, quando le arrivò la voce inudibile delle cose. Vide un’ape carica di polline affondare nel sacrario di un fiore; vide le mille corolle sorelle inarcarsi ad accogliere l’amplesso e il brivido d’estasi dell’albero, dalla radice al ramo più sottile, per poi addensarsi in ogni fiore e spumeggiare di piacere. Dunque era uno sposalizio! Era stata chiamata ad assistere a una rivelazione. Poi Janie provò una fitta dolce, senza rimorsi, che la lasciò svuotata e languida.
Dovetti ammettere che il linguaggio mitico, se buono, è davvero sorprendente:
La Morte, quell’essere misterioso dagli enormi zoccoli quadrati che stava laggiù a Occidente. La signora che abitava nella casa dritta come una piattaforma, senza i fianchi e senza il tetto: che bisogno ha, la Morte, di un tetto sopra la testa, e quali venti possono soffiarle addosso?
La mia avversione per il dialogo (incoraggiata da Nabokov, che idolatravo) oppose qualche resistenza, ma poi crollò di fronte all’orecchio della Hurston per la parlata colloquiale dei neri. In bocca alle persone illetterate, la Hurston trova la gioia perfetta della metafora quotidiana: «Se Dio la pensa come me su di loro, quelli sono una palla perduta nell’erba alta»; della saggezza portata con leggerezza: «Secondo me, il lutto non dovrebbe durare più del dolore». I suoi dialoghi rivelano la personalità degli individui in maniera agile e accurata, come se non vi fosse alcun autore:
«Da dove arrivate, così di fretta?», domandò Lee Coker.
«Georgia centrale», rispose Starks con tono vivace. «Mi chiamo Joe Starks, e vengo dalla Georgia».
«Tu e tua figlia avete intenzione di diventare dei nostri?», domandò l’altra figura supina. «Felice di avervi con noi. Nome: Hicks. Comandante Amos Hicks, di Burton, South Carolina. Libero, solo, senza impegni».
«Perdio, non sono ancora così vecchio da avere una figlia grande. Questa è mia moglie».
Hicks tornò a sdraiarsi e perdette immediatamente ogni interesse.
«Dov’è il sindaco?», insistette Starks. «Voglio parlare con il sindaco».
«Sei un po’ in anticipo per il sindaco», gli disse Coker. «Non ce l’abbiamo ancora».
Soprattutto, dovetti abbandonare la mia antipatia per le tribolazioni amorose delle donne. La storia del cammino di Janie attraverso i suoi tre matrimoni pone il lettore di fronte a un’idea importante: la scelta che una persona compie tra diversi partner, preferendo un uomo a un altro (o una donna a un’altra), va molto al di là del romanticismo. Si tratta, in definitiva, della scelta tra diversi valori, possibilità, futuri, speranze, ragionamenti (concetti condivisi che si adattano al mondo come empiricamente lo si conosce), linguaggi (parole condivise che si adattano al mondo come si crede che sia) e vite. È evidente che il mondo che si condivide con Logan Killicks non è lo stesso mondo che si condivide con Vergible «Tea Cake» Woods. In questi due mondi separati, non si penserà nemmeno allo stesso modo: la mente, intrappolata con Logan, si libera con Tea Cake. Ma in un certo contesto come si fa a parlare di libertà? In termini pratici, una donna di colore nell’America a cavallo tra fine Ottocento e inizi del Novecento, una donna come Janie, o come la Hurston stessa, godeva all’incirca delle stesse libertà civili di un animale da fattoria: «La donna negra è il mulo del mondo», così recita la famosa battuta della nonna di Janie. Leggerla ferì il mio orgoglio. E ferisce anche Janie; lei rifiuta la realpolitik della nonna, imbarcandosi in una rivincita esistenziale che si nutre dell’immaginazione e alla quale è impossibile porre dei limiti:
Sapeva che Dio straccia ogni sera il vecchio mondo e ne crea uno nuovo prima dell’alba. Era meraviglioso vederlo prender forma con il sole ed emergere dalla polvere grigia della creazione. Le persone e le cose familiari l’avevano lasciata sola e allora, appoggiata al cancello, scrutava la strada fin dove scompariva.
Quella parte di Janie in cerca di qualcuno (o qualcosa) che rappresenti per lei «l’orizzonte lontano» ha le sue orgogliose antenate in Elizabeth Bennet, Dorothea Brooke, Jane Eyre, e persino – anche se in forma assai svilita – in Emma Bovary. Sin dagli inizi della narrativa sulle tribolazioni amorose delle donne (il che vuol dire sin dagli inizi della narrativa), l’aspetto della «ricerca dell’amore» è stato troppo spesso ridicolizzato: non molto tempo fa ero a cena con una donna americana, che mi ha raccontato quanto fosse rimasta delusa, dopo aver finalmente letto Middlemarch, dallo scoprire che narrava «soltanto la lunga, piagnucolosa, strascicante ricerca di un uomo!» Chiunque abbia letto Middlemarch in quest’ottica non troverà di suo gusto I loro occhi guardavano Dio. Il romanzo racconta la storia di una ragazza che impiega del tempo per trovare l’uomo che ama veramente. È un libro sulla scoperta di se stessi nell’altro e attraverso l’altro. Lascia intendere che persino la triste e terribile banalità del razzismo può affievolirsi fino a sparire del tutto, quando si comprende e si è compresi da un altro essere umano. E questo non equivale forse ad affermare che l’amore rende liberi? È vero che ai nostri giorni ciò che più conta è la realizzazione di se stessi, e non riuscire a raggiungerla da soli è un po’ come ammettere una debolezza. Immagino quindi che il potenziale trasporto delle relazioni umane cui la Hurston dà voce nel romanzo e il profondo «amore autodistruttivo» che Janie prova per Tea Cake possano effettivamente apparire come il lento finale di una «lunga, piagnucolosa, strascicante ricerca di un uomo». Tea Cake e Janie, tuttavia, vivono la loro reciproca scelta non come fonte di disperazione, ma come una scoperta, e il bisogno che provano l’uno dell’altra suscita in loro gioia, non vergogna. Il fatto che Tea Cake non sarebbe la nostra scelta, il fatto che spesso lo disapproviamo e ogni tanto disperiamo di lui, non fa altro che conferire forza alla sua rappresentazione. Tea Cake sembra agire in piena libertà, e Janie lo sceglie liberamente. Noi non abbiamo alcun potere, possiamo soltanto stare a guardare. Nonostante la sua struttura favolistica (con i mariti, la terza volta è quella buona), I loro occhi guardavano Dio non è un romanzo sull’appagamento dei propri desideri, e men che meno sull’appagamento dei nostri desideri. È bizzarro diagnosticare una debolezza che gli amanti stessi non percepiscono.
Dopo quella prima lettura del romanzo, piansi, non solo per Tea Cake, o per la perfezione della scrittura, e neppure per l’autentico senso di perdita che provai nel lasciare il mondo contenuto in quelle pagine. Quell’esperienza per me significò qualcosa di più di tutto questo, qualcosa che non sapevo, o non volevo, esprimere chiaramente. La sera, a cena, lo portai a tavola con me, tenendolo stretto come talvolta facciamo con i libri che non siamo pronti ad abbandonare.
«Allora?», mi chiese mia madre.
Le dissi che era fondamentalmente un buon libro.
__________
A quattordici anni, resi a Zora Neale Hurston un grave disservizio critico. Ebbi paura dei miei sentimenti «extraletterari» nei suoi confronti. Volevo essere un’esteta oggettiva e non una sciocca sentimentale. Non mi piaceva l’idea di «identificarmi» con i personaggi dei romanzi che leggevo; volevo che la Hurston mi piacesse in quanto rappresentava un esempio di «buona scrittura», e non perché rappresentava me. Nei vent’anni successivi, Zora Neale Hurston si è trasformata, da ben custodito e beneamato segreto delle donne di colore appartenenti alla generazione di mia madre, in oggetto di un’intera industria letteraria; biografie, film, Oprah Winfrey, dipartimenti di letteratura afroamericana: tutti a rendere omaggio alla sua vita e alla sua opera in quanto incarnazioni del prototipo per eccellenza della donna di colore. Nel corso di questo processo, le è stato reso un diverso tipo di disservizio critico; una sovracompensazione in senso opposto. Nel romanzo, Janie soffre per la determinazione di Joe Starks a idolatrarla: il marito cerca in tutti i modi di metterla su un piedistallo, sola di fronte alla città, per sostituire un simbolo (la Moglie del Sindaco) alla donna che è. Una cosa assai simile è capitata alla Hurston. Anche lei, come Janie, viene piazzata sulla sua veranda-piedistallo («quasi ci morivo, lassù»), lontana dalle persone e dalle cose che amava, deformata dallo sguardo dei suoi ammiratori, ridotta a vuoto simulacro delle loro idee e delle loro opinioni. In un singolo volume di saggi a lei dedicati troviamo, fra i diversi contributi, chi sostiene che la critica negativa sull’opera della Hurston rappresenti un «linciaggio intellettuale» da parte degli uomini neri, degli uomini bianchi e delle donne bianche; chi liquida il suo ultimo libro con la frase: «Seraph on the Suwanee non è nemmeno un libro sui neri, il che non sarebbe certo un crimine, ma su dei bianchi noiosi, il che invece lo è eccome»; e chi spiega «il vero grande difetto» di I loro occhi guardavano Dio, ovvero: la «curiosa insistenza» della Hurston nel narrare la storia del suo personaggio principale attraverso l’onnisciente terza persona (invece di concedere a Janie una voce tutta sua). È evidente che ci troviamo in un universo critico di una certa banalità, un universo in cui la maggior parte delle eroine dell’Ottocento sarebbero giudicate come creature oppresse, crudelmente private della terapeutica voce in prima persona. È anche un universo in cui la cosiddetta «Tradizione Letteraria Femminile Nera» è al di là di ogni biasimo:
Le scrittrici di colore hanno costantemente rifiutato la falsificazione della loro esperienza femminile di colore, evitando in tal modo gli stereotipi negativi che tale falsificazione ha spesso creato nella tradizione letteraria americana delle donne bianche e degli uomini neri. Al contrario di molti uomini neri e donne bianche loro pari, le scrittrici di colore si sono in genere rifiutate di sopprimere qualunque aspetto chiaramente nero e/o femminile della loro sensibilità nello sforzo di conseguire la mitica voce «neutra» dell’arte universale.
Per quanto potrebbe risultare gratificante concordare sul fatto che le scrittrici di colore «hanno costantemente rifiutato la falsificazione» della loro esperienza, il lettore onesto sa che questo semplicemente non è vero. In luogo della falsificazione negativa, abbiamo coltivato, negli ultimi trent’anni, una nuova feticizzazione. Oggigiorno le protagoniste di colore sono immancabilmente forti e piene di sentimento; sono sessualmente voraci e prive di paura; prendono le sembianze irreali di madri della terra, regine africane, dive, spiriti della storia; sfilano maestose e imponenti fra le pagine di romanzi intrisi di un lirismo da biglietto d’auguri. Hanno ben poco della complessità, dei difetti e delle indecisioni, della profondità e della bellezza di Janie Crawford e del romanzo della Hurston. Fungono da modelli di comportamento, utili più che altro a rattoppare le nostre ferite psichiche; sono perfette; sovracompensano. La verità è che le scrittrici di colore, pur avendo scritto molte cose meravigliose, non hanno avuto né maggiore né minore successo, rispetto a ogni altra categoria di scrittori, nell’evitare la falsificazione dell’esperienza umana. Non è certo la Tradizione Letteraria Femminile Nera a rendere grande la Hurston. È la Hurston stessa. Zora Neale Hurston – capace di esprimere la vulnerabilità dell’essere umano così come la sua forza, lirica senza sentimentalismo, romantica eppure rigorosa, una delle poche scrittrici in grado di parlare di sesso in maniera eloquente – è tanto eccezionale tra le autrici nere quanto lo è Tolstoj tra i bianchi.
È vero, tuttavia, che nei suoi romanzi la Hurston rifiutò l’«universale neutro», scrivendo orgogliosamente nel dialetto dall’inflessione nera con cui era stata allevata. Ci volle coraggio per farlo: il risultato furono ostilità e disinteresse diffusi. Nel 1937, i lettori neri erano imbarazzati dalla rozzezza linguistica dei dialoghi, e quelli bianchi preferivano l’esotismo dei suoi scritti antropologici. Chi poteva mai voler leggere dei pove...