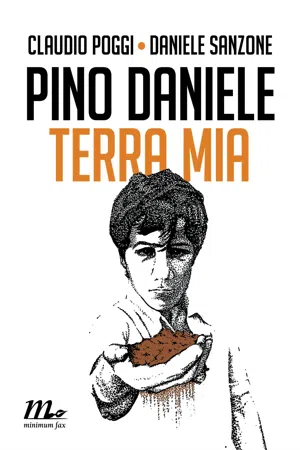![]()
TERRA MIA
«Terra mia è tutto me stesso, è tutto quello che sento e che voglio dire ora e nei dischi che farò, e anche in quelli che non farò».
A luglio del ’76 eravamo di nuovo in studio. L’unica cosa certa era il titolo dell’album, Terra mia, perché Pinotto era esattamente ciò che cantava: un magma lavico e rivoluzionario che travolgeva la tradizione, rinnovandola.
Al Quattro Uno c’eravamo trovati molto bene per la qualità dello studio e dei tecnici, ma soprattutto per l’atmosfera familiare che Claudio Mattone, da napoletano doc, aveva saputo creare intorno a noi. Il costo giornaliero dello studio era alto, anche per le ricche finanze di una multinazionale come la EMI. Lì registravano solo artisti di successo, che potevano permettersi budget milionari, ma Tibaldi riuscì ad accontentarci.
«Quando Bruno mi chiese lo studio per l’album di Pino fui molto contento, perché quel ragazzo mi piacque da subito. Si creò un’ottima sintonia con lui, Claudio e i musicisti. Ma la EMI non poteva permettersi di spendere tanto per il disco d’esordio di un cantautore, quindi pur di accontentarlo concessi un fortissimo sconto. L’album costò in totale cinque milioni di vecchie lire, che per l’epoca erano tanti, ma pochi rispetto ai parametri dei grandi dischi».
Questa volta il nostro tecnico era Stefano Taccaliti, con Gigi Notte come aiuto fonico, perché Franco Finetti, numero uno dello studio, era già impegnato con Baglioni. A completare lo staff c’era Gretsch, un bastardino che lo studio aveva adottato dandogli il nome di una famosa marca di batterie. Una zecca alla perenne ricerca di avanzi e attenzioni.
Per portare tutti gli strumenti da Napoli a Roma affittammo un furgoncino che imbottimmo di chitarre, percussioni, batteria, basso e contrabbasso. E a farci da scorta, dietro il furgone, l’immancabile Cinquecento di Dorina.
Entravamo alle 9 per uscire alle 20. Ad aspettarci fuori c’era Claudio Baglioni, che stava lavorando all’album Solo, pubblicato dalla RCA nel 1977. Claudio non aveva orari e spesso registrava fino a notte inoltrata. Nonostante ci incrociassimo quasi tutte le sere e Mattone avesse fatto di Pino una grande presentazione, non nacque in quell’occasione una particolare simpatia fra i due artisti, entrambi erano troppo concentrati sui propri dischi e in più Pinotto, pur stimandolo come interprete, non amava granché la sua musica.
Dormivamo al motel Aurora, lo stesso alberghetto dove eravamo stati durante la registrazione di «Ca calore», comodo perché poco distante dallo studio. Solo che ora il numero delle stanze e la loro composizione cambiava in base agli arrivi e alle partenze che si alternavano nelle diverse fasi di lavoro. Pino e Rosario dormivano insieme, mentre io dividevo la camera con Rino Zurzolo, ma ben presto si verificarono degli importanti cambiamenti.
Il nostro ristorante di riferimento era Moscatelli, vicino all’albergo, dove si gustava una buona cucina romana, anche se Pinotto era ossessionato dalla dieta e spesso, all’amatriciana, alla gricia e alla carbonara preferiva una fettina di carne ai ferri con insalata. Inoltre dovevamo sorbirci anche i suoi discorsi su quanto fosse importante mangiare bene e sano, discorsi che sinceramente non ci hanno mai convinto. Vista la permanenza piuttosto lunga provammo a concordare un prezzo fisso per le cene e Marcello, un simpatico cameriere con cui legammo, trovava sempre il modo di sfamarci quando eravamo a corto di soldi.
Il primo giorno di registrazione, un lunedì, eravamo tesi ed emozionati come bambini. Ora si faceva sul serio, perché si trattava di realizzare un lp. Come sempre si iniziò col registrare le basi: batterie, bassi e chitarre su cui poi si sarebbero inseriti gli altri strumenti o, come si diceva all’epoca, si sarebbero effettuate le sovraincisioni. Il primo punto da cui partire era la creazione dei suoni della batteria, che insieme al basso forma la sezione ritmica. L’obiettivo era ottenere delle sonorità che potessero avvicinarsi il più possibile a quelle straniere, e cioè a quei dischi che ascoltavamo dalla mattina alla sera. Si trattava di un traguardo assolutamente non facile, ma per noi fondamentale. A Stefano Taccaliti gli facemmo la testa così. Eravamo ossessionati dai suoni, era un continuo ascoltare dischi per fargli capire esattamente il risultato che volevamo raggiungere. Per fortuna Stefano comprese subito l’ansia da primo disco, riconobbe la nostra inesperienza, e con affetto iniziò a sfotterci: «La cassa la volete più rocciosa o più gommosa?», mettendoci seriamente in difficoltà. Ricordo che ci guardavamo interdetti. In fondo per noi era pur sempre il primo album.
Spesso ci si alienava perché le sessioni erano estenuanti, Pinotto era maniacale, un vero e proprio perfezionista, poteva stare una vita ad ascoltare il suono di un rullante o di un charleston. E vi lascio immaginare quando venne il momento di registrare le chitarre... Si fermava solo per mangiare al volo qualcosa e sorseggiare il caffè. Pretendeva sempre il meglio, prima da se stesso, e poi dal resto dei musicisti: nonostante fosse alle prime armi sapeva il fatto suo.
Avevamo deciso di iniziare il 33 giri con «Saglie saglie», per quella strana atmosfera di tristezza e malinconia, tipicamente napoletana, che appartiene un po’ a tutto l’album. E lo chiudemmo con lo stesso pezzo in chiave funky, usando la chitarra elettrica e il sax. Una sorta di ponte tra una Napoli antica e popolare e una moderna, al passo coi tempi.
Quando arrivò il momento di registrare le voci facemmo salire a Roma Donatella e Dorina, che al motel dormivano nella stessa stanza. Donatella Brighel trovò subito l’alchimia giusta, la sua interpretazione in «Saglie saglie» fu molto emozionante.
Il brano si apre con i bar chimes suonati da Jermano – quel caratteristico «scampanellio» che sarebbe diventato in futuro motivo di discussione per la frequenza con cui lo stesso Rosario avrebbe voluto usare lo strumento. Il contrasto tra la voce popolare di Donatella, sporcata con un debole effetto flanger, e quella di Pino, lontana nel timbro e nell’espressione dai cantanti napoletani dell’epoca, creava una grande atmosfera, grazie anche al controcanto di Dorina e al contrabbasso di Rino Zurzolo: strumento che non veniva quasi mai usato in chiave melodica, in questo caso suonato con l’archetto. Infine, il recitato di Pinotto enfatizzava con grande passione la forza delle parole rendendo tutto più autentico e profondo.
Molto differente ma ugualmente bella e trascinante la versione funky dello stesso brano, che vide l’inserimento dei tanti sax armonizzati da Enzo Avitabile sul groove di Rosario e il basso, questa volta elettrico, di Rino.
Poi fu la volta di «’Na voglia e jastemmà». A parte il titolo non particolarmente felice, il brano era bello tosto, con riff di chitarre elettriche, fiati di Enzo Avitabile e una potente sezione ritmica. Ricordo ancora che chiesi a Pinotto di modificare almeno il titolo, perché mi sembrava troppo forte ma, come in tante altre occasioni, non ci fu verso di fargli cambiare idea. Non accettava compromessi, specialmente sui testi, perché era convinto più che mai che la lingua napoletana dovesse rinnovarsi e sporcarsi, o meglio ritornare a dare voce al volgo. E aveva ragione. Del resto iniziare un brano con una frase come «Ma che puzza int’ a stu vico, commme fa’ ’a gente a campà...» significava rompere totalmente con gli schemi rassicuranti della struttura narrativa classica.
«Ce sta chi ce penza» è una sorta di tarantella, scandita dal ritmo del putipù, uno strumento popolare dal suono simile a un tamburo sordo che assomiglia molto a un pernacchio. E poi un tripudio di mandolini armonizzati da Pinotto. Stavolta, alle voci di Donatella e Dorina affiancammo anche quella di Rosario per ottenere l’effetto di un coro sgangherato, di strada, molto differente dai canti etnici e popolari della campagna campana. Fu difficile mixarlo per la grande quantità di strumenti e inserimenti vocali. A operare sul mixer c’era un polipo, praticamente: otto mani che alzavano e abbassavano, in determinati punti, strumenti e voci. Bastava che uno di noi dimenticasse di aprire o chiudere una pista, che si doveva rifare il mix daccapo. All’epoca incidevamo su un registratore a 16 tracce, e questo significava portare a termine un lavoro molto complesso: trasferire tutto su due semplici tracce stereo senza poter contare sulle automazioni che ci sono oggi. La scarsa esperienza e la voglia di fare sempre meglio ci portavano spesso a registrare tante cose inutili che alla fine si sentivano poco o addirittura cozzavano con altri strumenti, rendendo complicato il lavoro del fonico.
«Terra mia» fu registrata come nel provino: voce, chitarra classica e contrabbasso. Rino enfatizzò con un contrappunto melodico l’interpretazione vocale di Pinotto, che fu veramente da brividi.
Claudio Mattone si fermò in studio proprio nel mezzo della registrazione di «Terra mia» e ci chiese più volte di riascoltare il pezzo di cui si era evidentemente innamorato. Fu rapito dalla melodia, ma soprattutto dal testo, che gli ricordava la sua amata terra dove ormai non viveva più: «Nonostante “Napule è” rappresenti la canzone simbolo di Pino Daniele, io sono convinto che il brano più importante e liricamente più bello ed emozionante di quell’album sia proprio “Terra mia”. La convinzione di trovarmi in presenza di un grande Artista l’ho avuta quando l’ho ascoltato per la prima volta e niente potrà mai più restituirmi le stesse emozioni».
Pinotto colse la palla al balzo e convinse Claudio a suonare la Solina, una tastiera in quel periodo all’avanguardia per la possibilità di emulare abbastanza fedelmente le sonorità degli archi. Generalmente il maestro era riluttante a intervenire in lavori altrui, ma in questo caso fu stimolato dal brano e dal nostro entusiasmo. «Terra mia» si arricchì di brevi ma importanti inserti orchestrali, che diedero grande profondità al pezzo.
Nacque davvero un bel rapporto con Mattone, e questo permise a Pinotto di chiedergli consigli e piccoli interventi alle tastiere, anche perché non avevamo nessuno che le suonasse. Spesso Claudio si presentava all’ora di pranzo con delle enormi zuppiere ricolme di spaghetti al pomodoro fresco e basilico. E nel giardino antistante lo studio, tra un bicchiere di vino e una risata, ci perdevamo in lunghe chiacchierate. Si parlava di musica, di Napoli e di come le tradizioni stessero cambiando, ma senza mai prenderci troppo sul serio.
Mi sorprendo sempre quando mi capita di parlare con qualcuno che ascolta quest’album per la prima o per l’ennesima volta: mi sembra quasi di riassaporare, attraverso gli occhi – o sarebbe meglio dire orecchie – dell’ascoltatore le sensazioni che la nostra banda ha avuto la fortuna di vivere quarant’anni fa.
E il ricordo va a «Libertà», in assoluto il mio pezzo preferito. Un mix perfetto tra le liriche del testo e una melodia che diventa struggente nel gridare la propria voglia di uscire fuori dagli schemi vivendo senza compromessi. Una ballata che, non avendo la tipica struttura strofa-ritornello, sembra non evolversi mai se non nel finale dove irrompe la chitarra elettrica, con un fraseggio melodico da brividi. Con la mitica Gibson Diavoletto, Pinotto riuscì a dare una sonorità che difficilmente si ascoltava nei dischi italiani di allora. In fase di mixaggio, esaltato e rapito da questa atmosfera, suggerii di iniziare la canzone con il suono della pioggia, registrando un temporale su cui fare entrare in assolvenza la chitarra acustica. Per quest’idea mi presero in giro per giorni, ma poi alla fine la inserimmo, anche se nelle successive riedizioni pare che questa pioggia sia diventata impercettibile o addirittura sia scomparsa.
A ispirare «’O padrone» fu invece un fatto di cronaca. L’11 aprile del 1975 in provincia di Napoli, a Sant’Anastasia, esplose la Flobert, una fabbrica che produceva giocattoli e fuochi d’artificio, provocando la morte di dodici operai. Pinotto immaginò che, arrivati in paradiso, questi operai si aspettassero una vita migliore di quella vissuta sulla Terra: ma presto si sarebbero resi conto che pure in paradiso sarebbero stati costretti a lavorare.
’O Signore ogg’ è venuto,
’nce vuleva parlà.
Ma che ve site miso ’ncapa
’mparadiso s’adda faticà.
Al mix decidemmo che sarebbe stato più d’impatto iniziare con il suono delle mani che portano il tempo, il coro, le percussioni e la chitarra d’accompagnamento, e di far entrare poi la ritmica e il resto degli strumenti. Sulla coda del pezzo c’era un lungo assolo di sax di Enzo Avitabile che, ahimè, dovemmo tagliare affinché il brano non superasse un certo minutaggio. Fu un vero peccato, perché quell’assolo spaccava. In questo stesso brano Rino Zurzolo si superò: all’epoca era giovanissimo e timido ma ci dava dentro di brutto sia col contrabbasso che con il basso elettrico. Uno dei pochi musicisti che ti fa sentire e apprezzare il basso in ogni sua nota. Pinotto lo adorava per questo e per il suo carattere riservato, e non a caso è uno dei musicisti con cui ha collaborato maggiormente nell’arco della sua carriera.
Anche in «Chi po’ dicere», un gioiellino di appena un minuto e mezzo, il contrabbasso di Rino diventa solista caratterizzando l’atmosfera del pezzo. Tutti amavamo questo strumento e il modo in cui Rino lo suonava sottolineava quella malinconia che pervade l’intero l’album. Per la cronaca, anche in questo brano Rosario utilizzò i bar chimes, al punto che Pinotto sbottò: «Rosà cu’ ’sti campaniell’ c’e rutt’ ’o cazz’». Scoppiammo tutti a ridere.
Più o meno a metà lavoro Donatella ritornò a Napoli per un paio di serate come corista di Peppino Di Capri. Al suo ritorno si accorse che in quei sette giorni erano cambiate diverse cose. Oltre a un grande disco, stava nascendo anche un’importante storia d’amore, quella tra Pino e Dorina. Così la sistemammo in una singola e ci rimettemmo subito a lavoro.
Questa volta Donatella doveva cantare una delle canzoni più suggestive dell’album, «Suonno d’ajere». Un brano in cui emerge ancora più forte l’...