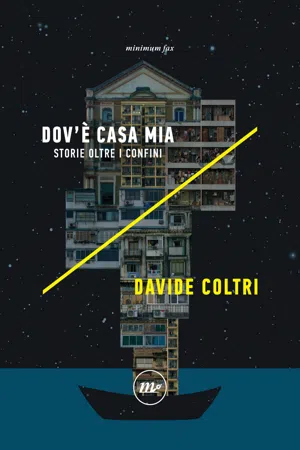![]()
KHALAT
per F., ovunque sia
I
Quella sera mio fratello Muhsen portava una camicia color panna e aveva gli occhiali tondi sul naso. Cullava Kawa, appena nato, tenendolo adagiato sull’avambraccio destro. Quando il piccolo si addormentò, Muhsen chiese a sua moglie di girargli le pagine del libro che stringeva tra le dita.
«Dovrei scrivere poesie sulla pelle di Kawa!», protestò lei raccogliendo il bambino.
Mio fratello continuò a leggere per un po’, poi mi domandò se avessi preso una decisione riguardo all’università.
«Allora, Aleppo o Damasco?»
«Damasco».
Nostro padre accolse la mia scelta sbuffando nel bicchiere di tè e agitando il cucchiaino nell’aria.
«Ma a trovarti marito sarò io», disse ancora una volta.
Aveva appena ceduto l’autorità a mio fratello: era vecchio, e temeva che agli acciacchi fisici si sarebbero aggiunti quelli della mente. Così, a parte la questione del mio matrimonio, sarebbe stato Muhsen a occuparsi della famiglia, guidando le nostre scelte. Questa era la mia fortuna – pensavo – perché mio fratello aveva studiato, aveva viaggiato molto, e sosteneva che la cosa più preziosa di tutte fosse la libertà.
Tre mesi dopo volai a Damasco e mi sistemai da una cugina di mia madre, che viveva con suo marito e tre figli maschi nel quartiere curdo di Rukneddine. La loro casa non era lontana dall’università, e sapeva di pane fritto e melassa di melograno.
Il mio corso preferito era quello di letteratura francese. Il professore aveva un accento leggero, che spuntava qua e là nelle frasi dette in arabo, e quando leggeva dall’antologia spingeva fuori le parole con una forza delicata. Mi nascondevo dietro un banco in fondo e non intervenivo mai. Un giorno mi invitò a sedermi davanti.
«Solo se non m’interroga», osai dire nel mio francese ancora incerto.
Fece un sorriso.
«Bien sûr, mademoiselle», e quelle tre parole mi entrarono dentro con l’intensità di un sì senza condizioni. Forse m’innamorai di lui per qualche tempo.
Muhsen telefonava ogni tanto per sapere come stavo, più spesso lo chiamavo io, con la tentazione di parlargli del professore. Non lo feci mai, e ora lo rimpiango.
Quando iniziarono le proteste ero in biblioteca. Sentii dei canti lontani, poi le urla, infine gli spari. Mi spaventai, aspettai che la confusione scemasse, quindi tornai a casa e telefonai a Muhsen.
«Le agitazioni finiranno presto. Non farti illusioni».
Mi tranquillizzò, in un certo senso. Ma voleva forse dirmi che lui se ne faceva?
Gli scontri non durarono molto a Damasco, ma continuarono quasi ovunque in Siria. Nella nostra città, Qamishli, le prime proteste furono pacifiche.
I telegiornali della tv di stato ripetevano con insistenza che l’esercito aveva il completo controllo della situazione, che gli scontri erano fomentati da potenze nemiche della Siria e sarebbero finiti presto. I miei professori si lasciavano andare a discorsi politici che non avevo mai sentito fare e, quando uno dei tanti sfollati giunti in città li inseguiva chiedendo l’elemosina, abbassavano la testa e solcavano imbarazzati i cancelli dell’università.
Io mi tuffai nello studio, ovvero nell’unica cosa che mi sembrava giusta anche in quei tempi confusi, e tornai dalla mia famiglia solo a fine luglio. Appena uscita dall’aeroporto di Qamishli percepii un’aria nuova, carica di attesa. La gente sembrava eccitata, per le strade e nei negozi ci si esprimeva in curdo liberamente, quasi in modo sfacciato, e la polizia lasciava correre.
Ero spaesata: fin dal primo giorno di scuola avevo imparato, a forza di punizioni, a parlare in arabo e limitare la nostra lingua alle conversazioni in famiglia. Sapevo che il regime ci aveva sempre maltrattati. Voleva che non esistessimo: gli impiegati degli uffici anagrafici non ci registravano nemmeno come curdi, per confermare la menzogna che fossimo una minoranza insignificante.
Ancora prima di entrare in casa mi giunse la voce di Muhsen. Sbirciai da una finestra: lui e altri due ragazzi si passavano un narghilè e parlavano tenendo il bocchino in un angolo della bocca.
«Fratello!», esclamai aprendo la porta.
«Khalat!», disse lui, e mi voleva abbracciare, ma non lo fece perché c’erano altri uomini.
Mi propose di unirmi a loro.
«Voglio salutare la mamma».
Ma tornai presto a origliare da dietro la porta. Uno dei ragazzi insisteva che erano stati gli arabi, molti secoli prima, a imporci la loro lingua e pure la loro religione. Se non ve n’era traccia nei libri di scuola era perché li stampavano gli oppressori.
Quando mio padre entrò in casa, i ragazzi presero a parlare a voce bassa. Lo salutai e salii in camera. Quelle discussioni mi avevano messo a disagio, perché pensavo alla mia religione come a un dono prezioso, di cui dovevo essere grata. Non importava se all’inizio ce l’avevano imposta.
«Ma vuoi proprio finire all’inferno?», chiesi a Muhsen quando venne a darmi l’abbraccio che aveva trattenuto al mio arrivo.
Capì subito e mi portò nel cortile. Mi disse che non si ribellava all’Islam, ma non poteva dimenticare che la nostra storia era fatta di soprusi e imposizioni, perfino quando si trattava della cosa che avevamo più cara.
Poche settimane dopo un attivista curdo venne ucciso nella sua abitazione, nel nostro quartiere. Ai funerali la polizia sparò sulla folla. Muhsen tornò a casa sconvolto, con i vestiti strappati. Mio padre lo guardò con preoccupazione, ma non commentò.
«Dobbiamo illuderci! Dobbiamo ribellarci!», mi urlò Muhsen, forse sperando che io ripetessi lo slogan. Mi sentii inadeguata e gli dissi, scusandomi, che volevo tornare a Damasco. Seguire il seminario sui poeti francesi, aggrapparmi con tutta me stessa a un mondo dove le tensioni si risolvevano nelle parole e non nel sangue: quella era la mia illusione.
«È la cosa migliore che tu possa fare», disse lui.
Lo pregai di essere prudente, anche se intuivo che la forza che lo trascinava via era molto più forte e violenta del mio amore di sorella.
Da Damasco telefonavo a Muhsen anche tre volte al giorno. Non gli raccomandavo di stare attento, semplicemente gli ripetevo che lo amavo, che non avevo nessun altro. Nella sua voce sentivo un’eccitazione nuova e inquietante. I miei cugini dicevano che era diventato una persona importante, un leader. Ne parlavano come di un eroe.
«Ma ha anche una moglie e un figlio», diceva la cugina di mia madre.
Ha anche me, pensavo io.
Poi mio fratello smise di rispondere al telefono. Sua moglie e il piccolo Kawa si trasferirono dai miei genitori. Mio padre mi chiamò per dirmi che Muhsen era sparito durante una manifestazione, insieme ai suoi due amici. Un peso mi si posò sul petto e i giorni diventarono un’attesa angosciata. Solo la voce del professore di francese e il suono di quella lingua mi davano sollievo.
Un pomeriggio lesse una poesia di Prévert che s’intitola «On frappe».
Qui est là
Personne
C’est simplement mon cœur qui bat
Qui bat très fort
A cause de toi
Mais dehors
La petite main de bronze sur la porte de bois
Ne bouge pas
Ne remue pas
Ne remue pas seulement le petit bout du doigt.
Al terzo ne mi invase la certezza totale, infinita e tonda della morte di Muhsen. Spazzò via persino il dolore, che era lì in agguato e aspettava il momento opportuno per attaccarmi alla gola.
Alzai la mano.
«Potrebbe rileggere?»
«Bien sûr», disse il professore, e rilesse la poesia.
Quando ebbe finito, alzai la mano ancora.
«Potrebbe rileggere?»
Il professore si guardò intorno, e solo allora notai che eravamo pochissimi nell’aula. Fece per dire qualcosa, poi schiarì la voce e rilesse la poesia. Quando finì la lettura, il dolore mi assalì, mi tolse il fiato, mi rivoltò gli organi. Chinai la testa e piansi, per un tempo che non saprei dire. Alzai gli occhi, l’aula era vuota. Il professore mi guardava da dietro la cattedra.
«Non potrò venire ai prossimi seminari».
Il professore fissava i banchi davanti a sé.
«Non credo che continueremo, sono rimasti solo dieci studenti».
«Il suo corso è la cosa più bella che mi sia capitata qui a Damasco».
«Per chi piangeva, suo padre?»
«Mio fratello».
Si passò una mano sulla fronte.
«Ho sempre pensato che la poesia ci aiutasse a comprendere meglio il presente. Ma oggi non è così, mancano parole e versi adeguati».
Mi porse il libro.
«Tenga, lo porti con sé».
Lo afferrai come qualcosa che mi veniva restituito e uscii. Attraversai i corridoi dell’università senza fretta. Incontrai pochi studenti, nessuno che conoscessi. Quando fui all’esterno mi mancarono le forze e presi un taxi. L’autista non parlava e teneva la radio spenta.
A casa trovai la cugina di mia madre in lacrime. Mi abbracciò con disperazione e mi sforzai di ricambiare. Quel suo dolore, così esibito e chiassoso, così dovuto, mi sembrava un insulto al mio, più profondo e definitivo. Lei soffriva per Muhsen, un lontano cugino; io soffrivo per Muhsen, mio fratello e grande amore, e per me stessa. Lei avrebbe continuato la sua vita di donna anziana; di me, che non avevo ancora vent’anni, cosa sarebbe stato?
Trovai le mie cose già chiuse in valigia: mio padre aveva dato disposizioni perché tornassi a casa immediatamente. Meglio così, mi dissi: un giorno in più all’università non avrebbe cambiato niente. Il marito di nostra cugina mi aspettava in cortile, la macchina era già accesa. Salii e partimmo per l’aeroporto, senza dire una parola.
II
Ci furono i funerali. Ricordo solo l’urto del dolore. Per giorni e settimane. Mi chiusi in camera, e quando ne uscii dovetti scontrarmi con il fatto che fosse mio padre, ora, a prendere le decisioni. Per mia madre non fu altro che un ritorno al passato; per le mie sorelle non cambiò nulla: vivevano fuori casa con i mariti, e a nostro padre non dovevano niente più che un rispetto ossequioso e lontano. Ma per me fu un trauma: ero abituata a discutere con Muhsen di tutto quello che mi riguardava, di quello che riguardava la nostra famiglia e il mondo.
Mio padre, invece, prendeva decisioni senza consultare nessuno e me le comunicava a cena. Capivo che faceva del suo meglio, che non avrebbe voluto trovarsi in quella situazione, e usava i criteri con cui era stato educato. Ma in un’atmosfera di allerta costante, di guerriglia tra le fazioni curde e nemici sempre nuovi alle porte della città e dentro la città, la rigidità delle leggi non scritte della tradizione era insopportabile.
Alla morte di Muhsen, Kawa aveva solo due anni. Sua madre tornò a vivere con i genitori. Andavo a trovarli ogni volta che potevo. Il bambino somigliava tantissimo a suo padre, non solo fisicamente. Quando piangeva, sua madre tirava fuori un vecchio libro e glielo apriva davanti: il bambino smetteva di singhiozzare e seguiva le linee nere, come se leggesse davvero. Mia cognata mi disse che ogni giorno conosceva una nuova vedova e questo, per quanto terribile, la aiutava a fare i conti con la sventura. Fu lei, non mio padre, a raccontarmi quello che era successo.
La polizia aveva preso Muhsen. Gli agenti lo avevano portato a casa per raccogliere le sue cose e salutare i genitori. Poi era stato arruolato con la forza nell’esercito siriano e mandato a combattere contro i ribelli a Homs. Durante un corteo, un su...