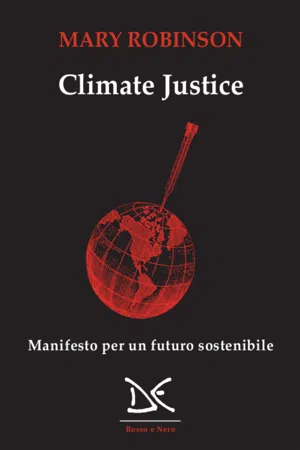
- Italian
- ePUB (disponibile su mobile)
- Disponibile su iOS e Android
eBook - ePub
Informazioni su questo libro
«Il vero scopo della lotta al cambiamento climatico è tutelare i diritti umani e garantire giustizia a chi ne subisce gli effetti più gravi, ovvero paesi e comunità vulnerabili, che nella gran parte dei casi sono i meno responsabili del problema. A costoro deve essere garantita la possibilità di condividere sia gli oneri sia i benefici del cambiamento climatico in modo equo. È questa la mia definizione di "giustizia climatica": mettere l'uomo al centro della soluzione».
Tools to learn more effectively

Saving Books

Keyword Search

Annotating Text

Listen to it instead
Informazioni
Argomento
Scienze fisicheX. Parigi: dalle parole ai fatti
Alle 19.16 del 12 dicembre 2015, nel centro congressi dell’aeroporto Le Bourget, appena fuori Parigi, il ministro degli Esteri francese Laurent Fabius ha preso il martelletto verde e l’ha battuto con fermezza sul tavolo. In quel preciso istante, dopo due settimane di maratona per negoziare gli impegni dei singoli paesi, è stato sancito il primo patto mondiale volto a scongiurare gli effetti più disastrosi del cambiamento climatico. I delegati riuniti – capi di Stato, ministri, diplomatici, imprenditori e rappresentanti della società civile – sono scattati in piedi in un fragoroso applauso, che ha poi lasciato spazio ad abbracci e acclamazioni. Guardandomi intorno, ho visto molti di noi in lacrime.
Dopo due decenni di false partenze e impasse – ed esattamente sei anni dopo i dissidi di Copenaghen – un patto del genere sembrava impossibile. Ora un accordo equo stabiliva la rotta per una trasformazione storica dell’economia mondiale fino ad allora incentrata sui combustibili fossili, e vincolava allo stesso modo i paesi ricchi e i paesi poveri a contenere le proprie emissioni entro limiti più sicuri. Le nazioni povere avevano bisogno di ricevere diversi miliardi di dollari in più per riuscire a fronteggiare gli effetti del clima estremo e per muoversi verso un’economia più green basata sull’energia rinnovabile. In una città ancora sotto shock per gli attacchi terroristici che un mese prima avevano fatto 130 vittime, l’Accordo di Parigi rappresentava il trionfo della speranza sulle tenebre: una grande opportunità per cominciare a prevenire gli effetti più devastanti del riscaldamento del pianeta.
Dopo due settimane senza quasi chiudere occhio e dopo aver trascorso giornate lunghissime in strutture temporanee nella periferia di Parigi, eravamo estenuati ma felici, e fieri di noi. L’Accordo non era soltanto un punto di svolta storico in una corsa per evitare le conseguenze potenzialmente disastrose di un pianeta surriscaldato, ma un’adesione memorabile ai principî della giustizia climatica. Come dissi a un giornalista quella sera, era un «accordo per l’umanità» in tutti i sensi. Gli artefici dell’accordo hanno riconosciuto nel testo l’importanza della giustizia climatica, assunto precisi impegni in materia di diritti umani e di uguaglianza di genere, concordato un sistema di monitoraggio dei progressi nazionali e convinto le nazioni ricche a finanziare le azioni climatiche nei paesi più poveri. Impegnandosi a contenere il riscaldamento globale «ben al di sotto» dell’aumento di 2°C rispetto alle temperature pre-industriali, l’Accordo riconosceva anche la situazione drammatica di Anote Tong e della popolazione delle Kiribati, insieme a quella di altri quarantasette paesi tra i più poveri del mondo le cui esigenze speciali erano state fino ad allora trascurate nei colloqui sul clima, dominati in genere da una politica di potere. Ora Tong e i leader di piccoli Stati insulari, come Tony de Brum delle Isole Marshall, potevano tornare a casa a testa alta e dire alla loro gente che forse c’era ancora una speranza. Acconsentendo a ridurre a zero le emissioni nette di gas serra entro la seconda metà del secolo, l’Accordo di Parigi ha riconosciuto l’operato di Hindou, Constance e Patricia. Queste donne hanno finalmente potuto dire alle loro comunità – in Ciad, in Uganda e in Alaska – che il mondo aveva deciso di liberarsi dalla dipendenza dai combustibili fossili per passare a forme di energia, di utilizzo del territorio e di smaltimento dei rifiuti più pulite e sostenibili.
Il 12 dicembre era già una data propizia nel calendario della famiglia Robinson, perché quarantacinque anni prima io e mio marito Nick ci eravamo scambiati le promesse di matrimonio. Trentatré anni più tardi, in quella stessa data, era venuto al mondo il nostro primo nipotino, Rory. Ora, a dodici anni esatti da quel giorno in cui avevo incrociato per la prima volta lo sguardo di Rory e mi ero resa conto dell’importanza che avrebbe assunto la battaglia contro i cambiamenti climatici nel mio lavoro, mi ritrovavo a festeggiare un accordo epocale che avrebbe forse offerto a quel ragazzo e alla sua generazione la possibilità di abitare un mondo migliore.
Sulla parete dell’ufficio di Christiana Figueres, l’ex segretaria generale dell’Unfccc nonché una delle principali artefici dell’Accordo di Parigi, è appeso un quadretto con un motto: «Dire che una cosa è impossibile non esprime un dato di fatto, ma un atteggiamento». Un aforisma che ha permesso a Christiana di raggiungere un obiettivo che molti consideravano impossibile dopo Copenaghen: mettersi alla guida dell’Unfccc e, imparando dagli errori di quel vertice, trascorrere sei anni sfiancanti a cercare il modo di dar vita a un accordo che fosse efficace per tutti i paesi, ricchi o poveri che fossero. Prendendo atto del fallimento del Protocollo di Kyoto del 1997 – in cui soltanto le nazioni industrializzate si erano impegnate a ridurre le emissioni –, nel periodo precedente l’incontro di Parigi l’ufficio dell'allora presidente francese Hollande invitò i paesi partecipanti, a prescindere dal loro Pil, a presentare un piano in cui indicavano come e quanto avrebbero ridotto la produzione di carbonio. Quei piani – conosciuti come Indc (un altro «brioso» acronimo che sta per Intended Nationally Determined Contributions, ovvero contributi previsti, stabiliti a livello nazionale) – sono diventati una storica conquista quando più di 190 paesi hanno poi acconsentito a raggiungere gli obiettivi prefissati. Ai paesi partecipanti è stato richiesto di riunirsi ogni cinque anni con piani aggiornati che prevedano un’ulteriore riduzione e, a partire dal 2023 e sempre a cadenza quinquennale, di riferire i loro progressi. Anche se non sono previste sanzioni per inadempienza, si spera che i paesi rispetteranno gli obiettivi dei loro Indc, in primis per via di una reale preoccupazione per il pianeta, e in secondo luogo per non correre il rischio di essere pubblicamente additati come i procrastinatori dei cambiamenti climatici.
Il primo giugno del 2017 i timori che mi avevano tenuto sveglia quella notte di novembre a Marrakech diventarono realtà: il presidente Donald Trump annunciò il ritiro degli Stati Uniti dal patto stipulato a Parigi. Ero a casa, in Irlanda, e alla tv vidi Trump che da un podio nel Roseto della Casa Bianca bollava l’Accordo di Parigi come un patto «draconiano», aggiungendo che abbandonare l’Accordo avrebbe riaffermato la sovranità americana. Ero consapevole del fatto che l’America, il secondo paese più inquinante del mondo dopo la Cina, era determinante per la buona riuscita dell’Accordo, perché il suo Indc da solo avrebbe già permesso di tagliare oltre un quinto delle emissioni fino al 2030. Inoltre, l’inosservanza americana dei propri impegni verso il Green Climate Fund e gli altri finanziamenti per il clima avrebbe reso ancora più difficile il passaggio a fonti di energia rinnovabile nei paesi in via di sviluppo. È inammissibile che gli Stati Uniti si siano sottratti così, di punto in bianco, alle proprie responsabilità nei confronti delle persone, in patria e all’estero, per privilegiare i profitti a breve termine dell’industria fossile, e che abbiano abbandonato un accordo negoziato nell’arco di decenni da oltre 190 leader mondiali nell’interesse dell’intero genere umano e del pianeta.
Ma il mio timore che l’uscita dell’America compromettesse l’Accordo non si concretizzò perché ci furono subito due reazioni molto chiare. Per cominciare, il resto del mondo si disse pronto a raddoppiare i propri impegni climatici. A pochi minuti dall’annuncio di Trump, i leader di Francia, Germania e Italia diramarono una dichiarazione congiunta in cui affermavano che l’Accordo era «irreversibile» e che i loro paesi avrebbero portato avanti gli impegni. Il giorno dopo sulle testate più importanti e sui social media in tutto il mondo si levò un coro di condanna e di critiche per la scelta di Trump. Dalla Cina alla Russia, dall’India a tutta l’Unione europea, i leader mondiali, uno dopo l’altro, ribadirono fermamente il proprio impegno nell’Accordo. In un comunicato televisivo da Parigi, il neoeletto presidente Macron invitò gli esperti climatici americani a continuare la loro attività di ricerca in Francia e promise di «far tornare grande il nostro pianeta»1. Da Berlino, la cancelliera Angela Merkel condannò l’azione di Trump e dichiarò che «non avrebbe dissuaso nessuno di noi che sentiamo il dovere di proteggere questa terra».
Alcuni Stati, città e aziende statunitensi si allearono e si impegnarono – sotto la guida del governatore della California Jerry Brown e dell’ex sindaco di New York Michael Bloomberg – a portare avanti i loro piani per ridurre le emissioni e a collaborare separatamente con la Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici. «Faremo tutto quello che avrebbe fatto l’America intera se avesse tenuto fede al patto», disse Bloomberg. Alla fine della settimana, il messaggio era ben chiaro: in quella crisi non c’era spazio per una retorica faziosa, e il mondo – con o senza il governo degli Stati Uniti – avrebbe continuato a cercare di contrastare i cambiamenti climatici. Come fece notare Christiana Figueres verso la fine dell’estate 2017, la decisione di Trump di ritirarsi aveva mobilitato il resto del mondo, creando un’enorme e crescente ondata di sostegno per l’Accordo di Parigi che difficilmente il movimento climatico sarebbe riuscito a ottenere da solo. «Ho già cominciato a scrivere la mia lettera di ringraziamento al presidente Trump», disse sardonica.
Dopo essere cresciute per decenni, negli ultimi tre anni le emissioni globali di CO2 derivanti dai combustibili fossili si sono finalmente stabilizzate. E, dato ancora più incoraggiante, sono rimaste stabili mentre l’economia mondiale e il Pil dei principali paesi sviluppati e in via di sviluppo sono aumentati2. È un’ottima notizia, un incoraggiante segnale che la nostra opera di mitigazione comincia a dare i suoi frutti. Ciononostante, serve ancora uno sforzo globale straordinario per mantenere il riscaldamento ben al di sotto dell’aumento di 2°C rispetto all’epoca pre-industriale e per salvare le Kiribati e le vite di milioni di persone vulnerabili lungo le coste di tutto il mondo. Se anche tutti i paesi raggiungessero gli obiettivi prefissati negli Indc dell’Accordo di Parigi, gli scienziati prevedono che subiremmo comunque un aumento della temperatura globale superiore a 2,7°C.
Ci troviamo di fronte a una triste verità: se è vero che Parigi rimane un successo senza precedenti, è anche vero che si tratta di una base d’azione ancora troppo fragile. Il movimento per la lotta ai cambiamenti climatici e per la giustizia climatica deve ora passare al livello successivo, con urgenza e determinazione. Stati – potenti e piccoli, ricchi e poveri –, città, comunità, imprenditori, singoli individui: siamo tutti responsabili. Il nostro pianeta è a repentaglio, ma adesso, tutti insieme, dobbiamo cogliere quest’occasione storica di mettere fine a una minaccia esistenziale, di sconfiggere la povertà e la disuguaglianza e di dare potere a chi è rimasto indietro ed è stato trascurato fino a oggi.
Questa nuova fase di interventi audaci e decisi sarà efficace soltanto se riconosciamo il legame indissolubile tra la battaglia ai cambiamenti climatici e la battaglia alla povertà, alla disuguaglianza e all’esclusione. Se lo teniamo sempre bene a mente, le nostre soluzioni saranno tanto più efficaci e durature. La crescita economica costruita su un’energia e su un utilizzo del territorio sostenibili proteggerà le vite delle persone più vulnerabili dagli effetti del cambiamento climatico e potrebbe permettere a molte comunità di uscire dall’indigenza. Se diamo voce a chi è stato emarginato ed escluso, le nostre politiche e i nostri progetti, pubblici o privati che siano, agiranno sulle cause profonde che sono alla base del cambiamento climatico e della disuguaglianza. Se seguiamo l’esempio di chi combatte in prima linea contro il cambiamento climatico, troveremo risvolti positivi di resilienza e di speranza e ci convinceremo di poter davvero cambiare le cose. Come Constance Okollet, che pianta manghi, avocado e aranci nel suo villaggio dell’Uganda orientale per fermare l’erosione del soprassuolo e prevenire le inondazioni. O come Natalie Isaacs, che porta la sua battaglia domestica nelle case di tutto il mondo, esortando le donne a cambiare vita con piccoli gesti che hanno un grande impatto sulla nostra impronta ecologica globale. O ancora come Sharon Hanshaw, l’attivista per caso, che ha dato voce alle ingiustizie subite da una comunità emarginata dopo l’uragano Katrina.
Penso spesso a mio padre, un medico di famiglia la cui vita era stata stravolta dall’elettrificazione rurale in tutta l’Irlanda. Ricordo ancora lo sbigottimento nella sua voce quando ci raccontava come un semplice gesto – premere un interruttore – avesse rivoluzionato le cose nell’esercizio della sua professione. Grazie alla luce elettrica, mio padre non dovette più far nascere bambini o curare ferite e ossa rotte al chiarore di una candela. Le elettropompe fornirono acqua potabile direttamente nelle case dei suoi pazienti, le lampadine sostituirono le fioche e pericolose lampade a olio, l’industria rurale fiorì e la radio mise fine all’isolamento sociale, portando notizie e intrattenimento nelle famiglie contadine di tutto il paese. Ma l’amara realtà è che ancora oggi molte persone, in varie parti del mondo, vivono senza elettricità come prima che Thomas Edison inventasse la lampadina. Senza un accesso sicuro all’elettricità, i dottori non sono in grado di offrire assistenza medica dopo il tramonto. I pazienti dei paesi in via di sviluppo non possono usufruire di radiografie, ecografie o incubatrici. I vaccini e i medicinali non si possono conservare, e i medici non hanno la possibilità di consultarsi con altri professionisti. Quasi tre miliardi di persone non hanno ancora accesso al clean cooking, ovvero a soluzioni che consentano di cucinare in modo pulito e sicuro per la salute. Ma si affidano invece a combustibili solidi altamente inquinanti – legna, carbonella, letame e scarti agricoli – le cui esalazioni uccidono più di quattro milioni di persone l’anno3, per lo più donne e bambini in Africa e in Asia, e ne fanno ammalare molte di più.
Fornire elettricità a quel miliardo e trecentomila persone che, in vari paesi in via di sviluppo, non vi hanno ancora accesso resta una delle sfide più grandi. Non ci può essere sviluppo senza energia ma dobbiamo perseguire gli obiettivi stabiliti nell’Accordo di Parigi e garantire l’accesso a un’elettricità pulita, economica e sostenibile. Alcuni paesi in via di sviluppo stanno già dando l’esempio promuovendo soluzioni innovative nel campo dell’energia rinnovabile. L’India, il terzo maggior produttore di CO2, dove 240 milioni di persone non hanno ancora un vero e proprio accesso all’elettricità, avrebbe la possibilità di usare il carbone per espandere in tempi rapidi la copertura elettrica del paese, ma il governo indiano ha deciso di sfruttare l’energia solare e ha promesso di fornire elettricità all’intera popolazione entro il 2030. Oltre all’obiettivo di diventare un leader mondiale nel campo dell’energia solare, l’India si è prefissata anche un altro ambizioso traguardo: generare 160 gigawatt di energia solare ed eolica entro il 2022. Grazie al finanziamento di un miliardo di dollari da parte della Banca mondiale4, il governo indiano farà installare dei pannelli solari sui tetti delle case che forniranno abbastanza energia da permettere ai bambini indiani di studiare la sera e alle famiglie di cucinare e conservare il cibo.
Nello Stato più occidentale dell’India, il Gujarat, le donne cucinano utilizzando combustibili puliti e ricaricano il cellulare grazie ai pannelli solari sui tetti delle case. Rachel Kyte, amministratrice delegata di Sustainable Energy for All, e rappresentante speciale del Segretariato generale delle Nazioni Unite, sostiene che il modo tradizionale di connettere le persone alla rete – attraverso tralicci elettrici, cablaggi in rame e carbone a basso costo – non è più applicabile in questa nuova era di energia solare e pulita. «Il modo più economico, semplice e veloce di fornire energia alle popolazioni dei paesi in via di sviluppo è attraverso sistemi rinnovabili off grid, non connessi a una rete», spiega Rachel. Una volta che i villaggi saranno elettrificati e avranno accesso al clean cooking, potranno ricevere una migliore assistenza sanitaria e i bambini potranno restare a scuola più a lungo grazie alla luce elettrica.
Garantire l’accesso ai servizi di base a chi ne è e...
Indice dei contenuti
- Copertina
- Frontespizio
- Copyright
- Indice
- Prefazione
- I. Per capire cos’è la giustizia climatica
- II. Fare tesoro delle esperienze altrui
- III. Attivista per caso
- IV. Se scompare una lingua, scompare una terra
- V. Un posto al tavolo delle trattative
- VI. Piccoli passi verso l’uguaglianza
- VII. Emigrare, ma con dignità
- VIII. Assumersi le proprie responsabilità
- IX. Nessuno resti indietro
- X. Parigi: dalle parole ai fatti
- Ringraziamenti
Domande frequenti
Sì, puoi annullare l'abbonamento in qualsiasi momento dalla sezione Abbonamento nelle impostazioni del tuo account sul sito web di Perlego. L'abbonamento rimarrà attivo fino alla fine del periodo di fatturazione in corso. Scopri come annullare l'abbonamento.
No, i libri non possono essere scaricati come file esterni, ad esempio in formato PDF, per essere utilizzati al di fuori di Perlego. Tuttavia, puoi scaricarli nell'app Perlego per leggerli offline su smartphone o tablet. Per maggiori informazioni, clicca qui.
Perlego offre due piani: Essential e Complete
- Essential è l'ideale per studenti e professionisti che amano esplorare un'ampia gamma di argomenti. Accedi alla libreria Essential, che include oltre 800.000 titoli di comprovata qualità e bestseller in vari settori, tra cui business, crescita personale e discipline umanistiche. Include tempo di lettura illimitato e voce standard per la sintesi vocale.
- Complete: perfetto per studenti e ricercatori esperti che necessitano di un accesso completo e illimitato. Accedi a oltre 1,4 milioni di libri su centinaia di argomenti, inclusi titoli accademici e specialistici. Il piano Complete include anche funzionalità avanzate come la sintesi vocale premium e l'assistente di ricerca.
Perlego è un servizio di abbonamento a testi accademici, che ti permette di accedere a un'intera libreria online a un prezzo inferiore rispetto a quello che pagheresti per acquistare un singolo libro al mese. Con oltre 1 milione di testi suddivisi in più di 1.000 categorie, troverai sicuramente ciò che fa per te! Per maggiori informazioni, clicca qui.
Cerca l'icona Sintesi vocale nel prossimo libro che leggerai per verificare se è possibile riprodurre l'audio. Questo strumento permette di leggere il testo a voce alta, evidenziandolo man mano che la lettura procede. Puoi aumentare o diminuire la velocità della sintesi vocale, oppure sospendere la riproduzione. Per maggiori informazioni, clicca qui.
Sì! Puoi utilizzare l'app di Perlego su dispositivi iOS o Android per leggere quando e dove vuoi, anche offline. È perfetta per gli spostamenti quotidiani o quando sei in viaggio.
I dispositivi con iOS 13 e Android 7 o versioni precedenti non sono supportati. Scopri di più su come utilizzare l'app.
I dispositivi con iOS 13 e Android 7 o versioni precedenti non sono supportati. Scopri di più su come utilizzare l'app.
Sì, puoi accedere a Climate justice di Mary Robinson in formato PDF e/o ePub, così come ad altri libri molto apprezzati nelle sezioni relative a Scienze fisiche e Riscaldamento globale e cambiamento climatico. Scopri oltre 1 milione di libri disponibili nel nostro catalogo.