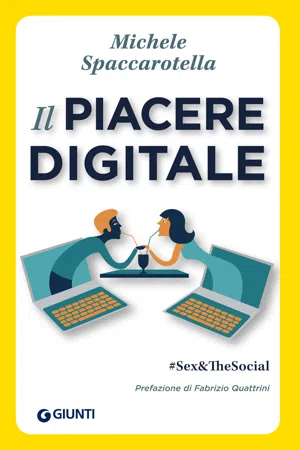![]()
Parte I
Corpi
![]()
1
La celebrazione dell’Io: il selfie
Siamo l’esercito del selfie, di chi si abbronza con l’iPhone, ma non abbiamo più contatti, soltanto like a un altro post.
Takagi & Ketra, L’esercito del selfie
Prendete in mano il vostro smartphone, accedete al menu principale ed entrate nella galleria delle foto. Scorrete con calma tutte le immagini ed esplorate in maniera approfondita la vostra ultima settimana, racchiusa in quelle immagini. Ora portate l’attenzione su un elemento specifico: quanti selfie vi siete scattati? Contateli. Senza barare o tentare di giustificarne il numero, poiché solamente voi sarete a conoscenza della risposta. Riguardandoli tutti insieme (nel caso fossero più di uno), provate a riflettere: vi sembrano troppi? Se vi state interrogando sul fatto che siate più o meno affetti da “selfite” (o sindrome da selfie) troverete molte più informazioni nel prossimo box. Se riuscite a trattenere la vostra curiosità, appare utile intanto compiere una riflessione sulla propagazione di un comportamento che, seppur diffusissimo attualmente, non esisteva fino a qualche anno fa. O forse sì. Partiamo dal vocabolo stesso: selfie, che nel nostro paese viene generalmente rappresentato e tradotto dalle parole autoscatto o autoritratto fotografico. L’Accademia della Crusca lo ha definito un prestito (alla lingua italiana) non adattato dall’inglese, che rientra nel novero dei forestierismi che sono nati sul web e si sono diffusi tramite i social network. Nel 2013, il blog dell’Oxford English Dictionary l’ha definita “word of the year”, la parola dell’anno. Rispetto al 2012, il suo utilizzo tra i termini inglesi era cresciuto del 17000% e veniva definita “a photograph that one has taken of oneself, typically one taken with a smartphone or webcam and shared via social media”, ovvero una fotografia scattata a sé stessi, solitamente realizzata con uno smartphone (o un tablet) oppure con una webcam e che viene condivisa attraverso i social media. Da principio, si presupponeva che la condivisione di tale fotografia fosse un tratto distintivo, ma in realtà lo scatto può non essere condiviso, oppure può immortalare altre persone insieme a chi effettua l’istantanea. L’immagine può essere divulgata anche tramite servizi di messaggistica come WhatsApp, Messenger, Telegram e Snapchat, oppure venire mostrata direttamente a terzi tramite l’esposizione diretta dello schermo del telefonino. A tal proposito, Barbieri (2016) sottolinea che l’idea di una fruizione esclusivamente personale e privata del selfie risulta tanto infrequente da farne accantonare ogni distinzione con l’autoritratto fotografico. Quando è nato dunque questo neologismo? Il termine selfie è comparso per la prima volta in Australia, in un forum online del network ABC (nella sezione del Dr. Karl, pseudonimo di Karl S. Kruszelnicki), ed è da attribuire a un ragazzo, Nathan Hope (registrato sul portale con il nickname Hopey). Raccontando una propria disavventura (una caduta avvenuta a causa del suo stato di ebbrezza durante il compleanno di un amico), postò una foto della sua bocca per testimoniare la presenza di alcuni punti di sutura sul labbro inferiore e, rispondendo a un’altra utente che gli aveva precedentemente chiesto come se li fosse procurati, scrisse: «E mi dispiace per la messa a fuoco, era un selfie». Questa frase risulta pertanto la prima apparizione documentata (in forma scritta) del vocabolo in questione. Il suffisso “-ie” rimanda a un vezzeggiativo, tipico dello slang australiano, che può implicare un aspetto affettuoso e familiare ma, come nota Pamela Rutledge, da un punto di vista semantico il selfie è un “piccolo Sé” (Marchioro, 2015), un aspetto dell’identità. Ho parlato di comparsa del termine perché vi è un ampio dibattito su chi sia stata la persona che possa fregiarsi del titolo di aver “inventato” il selfie. È possibile affermare che l’originario, pionieristico autoscatto della storia appartenga a Robert Cornelius e che l’evento risalga all’ottobre del 1839. Sì, avete letto proprio bene. Nell’agosto di quell’anno, infatti, Louis Daguerre mise a punto il dagherrotipo. In che modo era possibile ottenerlo? Utilizzando una lastra di rame su cui veniva applicato uno strato d’argento, sensibilizzato alla luce tramite dei vapori di iodio. La lastra doveva essere esposta entro un’ora e per un periodo variabile tra i 10 e i 15 minuti. Dopo l’avvento di questa innovazione, Joseph Saxton (tra i primi a leggere le istruzioni di Daguerre) incaricò Cornelius di creare una piastra di rame per “fotografare” la Central High School di Philadelphia. Robert, amante della chimica e dei metalli, riuscì non solo a eseguire il compito, ma anche a sperimentare un’altra importante novità, divenendo egli stesso il soggetto raffigurato nell’immagine. Il “dagherrotipo selfie” di Cornelius mostra l’uomo, leggermente spostato sulla destra, con un braccio sul petto e i capelli spettinati. Lui stesso affermò che era corso a mettersi di fronte all’apparecchio e che rimase immobile per tutto il tempo necessario a “fissare” l’immagine. La lastra fu siglata di suo pugno sul retro, riportando la scritta «The first light picture ever taken. 1839» – la prima immagine di luce mai realizzata. Se quindi facciamo fede al termine autoritratto (non pittorico), si può affermare che Cornelius sia stato il primo essere umano a riprodurre un’immagine di sé con l’ausilio della fotografia (l’autoscatto infatti è un dispositivo, generalmente azionato da un meccanismo a orologeria, che serve a fare scattare automaticamente, con un certo ritardo, l’otturatore della macchina fotografica o la fotocamera dello smartphone, per consentire a chi fotografa di far parte del soggetto da ritrarre). Se invece utilizziamo come riferimento il fatto che il soggetto che scatta tenga in mano l’apparecchio durante l’istantanea, allora è possibile considerare avanguardista anche la foto del 1913 della allora tredicenne granduchessa Anastasija Nikolaevna Romanova, quartogenita dello Zar Nicola II, la quale si scattò un’istantanea con una storica Kodak Brownie S1. L’immagine venne successivamente inviata a un amico, accompagnata da una lettera, nella quale la ragazza confessava che non era stato semplice realizzare quell’immagine, poiché durante lo scatto aveva le mani tremanti. La foto riproduce Anastasija inginocchiata su una sedia posta davanti allo specchio, stringendo tra le mani la Kodak che teneva all’altezza dell’ombelico. Pochi anni dopo, nel 1920, veniva invece realizzato il primo selfie di gruppo. La foto mostra cinque Lord dello studio fotografico Byron Company, sul tetto del Marceau Studio di New York, con in mano una macchina fotografica preistorica, talmente pesante da dover essere impugnata da due persone: Joseph Byron e Ben Falk. Altri selfie “storici” sono quelli del pittore belga Henri Evenepoel del 1898 e dell’artista australiano Harold Cazneaux del 1910. Ciò consente di intuire come la riproduzione dell’immagine di sé abbia sempre avuto una importante relazione con la sperimentazione dell’identità (e con l’ambito artistico), e che solo la diffusione e la facilità di utilizzo degli strumenti digitali di massa lo abbia reso un gesto popolare e accessibile a tutti. Il selfie non appartiene solo agli esseri umani. Negli ultimi anni, infatti, sono stati registrati anche due selfie “eccezionali”: il primo, realizzato da un macaco. Era infatti il 2011 quando il fotografo naturalista David Slater, che si trovava in Indonesia sull’isola di Sulawesi, decise di lasciare la propria macchina fotografica su un treppiedi a disposizione delle scimmie. Una di queste si avvicinò all’attrezzatura e premette più volte il pulsante di scatto, mentre fissava l’obiettivo. Molte foto risultarono inutilizzabili, ma due di queste erano venute perfette. Nacque così il “selfie del macaco”, diventato virale in tutto il mondo e per anni al centro di un’aspra disputa legale inerente i diritti d’autore. Il secondo scatto “straordinario” è stato invece compiuto nel 2012 dal rover Curiosity, il robot della Nasa utilizzato per l’esplorazione del pianeta Marte, che attraverso una sofisticata macchina fotografica, collocata su un braccio meccanico, è riuscito a scattare 55 immagini di sé stesso (assemblate in un secondo momento attraverso un software). Questo breve riepilogo storico permette di sottolineare come il desiderio di raffigurarsi sia sempre appartenuto all’essere umano, il quale in passato utilizzava primariamente la pittura: basti pensare a grandi artisti del calibro di Raffaello, Rubens, Dührer o De Chirico, come ampiamente documentato da Barbieri (2020). L’autore spiega efficacemente la distinzione tra le due forme di rappresentazione: il selfie è caratterizzato dalla velocità e dalla superficialità, ha bisogno di un tempo brevissimo per la sua realizzazione e coinvolge in modo solo tangenziale ed effimero il pensiero dell’autore; l’autoritratto pittorico richiede tempo, lentezza, cura, precisione, abilità tecnica ed elaborazione del pensiero e delle emozioni durante la sua esecuzione. Di fronte a un autoritratto pittorico, l’osservatore, come l’autore, può far penetrare il proprio sguardo in profondità, può riflettere, può interrogare le proprie emozioni, mentre una simile disposizione mentale è difficile da riscontrare in chi guarda un selfie, il quale si costituisce spesso come semplice testimonianza di esperienze e occasioni particolari. L’avvento della fotocamera frontale, presente nelle tecnologie digitali, e la comparsa delle piattaforme social hanno dunque reso estremamente più facile e rapido un processo di autorappresentazione che, da sempre, appartiene alla nostra specie e che si lega con forza al tema dell’identità e alla rappresentazione di sé. I ricercatori di tutto il mondo stanno iniziando a comprendere la vasta portata del fenomeno, non solo da un punto di vista sociologico ma anche psicologico, osservando e studiando quali motivazioni sociali e soggettive possano essere coinvolte nella massiccia diffusione degli autoscatti.
Curiosità: Soffro di “selfite”?
Nel marzo 2014, si era diffusa a macchia d’olio la notizia, pubblicata su Adobo Chronicles, che l’American Psychiatric Association (APA) aveva riconosciuto la “selfite” come un vero e proprio disturbo mentale. L’annuncio si era propagato in maniera così rapida in tutto il mondo da indurre l’APA stessa a dover smentire tale comunicato. Questa suggestione è stata però raccolta da Mark Griffiths, un noto studioso di dipendenze comportamentali, il quale a seguito della fake news ha davvero condotto una ricerca pilota sull’argomento (Balakrishnan, Griffiths, 2018) per comprendere se esistesse realmente questo tipo di disturbo ed eventualmente per delinearne i tre livelli di “gravità” (riportati dalla “bufala”): borderline, acuto e cronico. Lo studio aveva anche l’obiettivo di approfondire: quali sono le sotto-dimensioni che aiutano lo sviluppo della selfite e identificare in che modo questi elementi si differenzino all’interno dei tre livelli. La scelta del campione da indagare ricadde sugli studenti indiani (principalmente sotto i 25 anni), poiché l’India rappresenta il paese con più utenti Facebook al mondo e detiene il maggior numero di morti a causa dei selfie pericolosi (parlerò delle differenti tipologie di selfie nel prosieguo del capitolo). Nonostante ciò, gli autori hanno tenuto a specificare che il campione di 400 studenti non è da considerare rappresentativo né della popolazione indiana né di altre. Sono comunque interessanti le sei sotto-dimensioni individuate che sembrano essere trasversali ai livelli di gravità: autostima, ricerca d’attenzione, cambiamento dell’umore, valorizzazione personale da parte dell’ambiente di riferimento, conformismo (soggettivo) e competizione sociale. Riporto integralmente la SBS (Selfitis Behaviour Scale – Scala della Selfite) tradotta in italiano*. Le risposte vanno da 1 (totalmente in disaccordo) a 5 (totalmente d’accordo).
1. Scattare selfie mi dà la piacevole sensazione di godermi al meglio il mio ambiente.
2. Condividere i miei selfie mi dà la sensazione di creare una sana competizione con i miei amici e colleghi.
3. Ottengo molta attenzione condividendo i selfie sui social network.
4. Farmi dei selfie mi aiuta a ridurre lo stress.
5. Quando mi faccio un selfie avverto più fiducia in me stesso.
6. I miei gruppi sociali di riferimento mi accettano di più quando scatto selfie e li condivido.
7. All’interno del mio ambiente mi esprimo meglio attraverso i selfie che di persona.
8. Scattare selfie nelle occasioni più disparate aumenta il mio status sociale.
9. Mi sento più popolare quando pubblico i miei selfie sui social network.
10. Scattare più selfie migliora il mio umore e mi fa sentire felice.
11. Divento più positivo verso me stesso quando mi scatto selfie.
12. Postare i miei selfie mi rende un membro importante del mio gruppo sociale.
13. Scattare selfie consente di conservare ricordi migliori del momento e dell’esperienza.
14. Pubblico spesso selfie per avere like e commenti sui social network.
15. Pubblicando i selfie, mi aspetto che i miei amici mi apprezzino.
16. Scattare selfie migliora immediatamente il mio umore.
17. Scatto ulteriori selfie, che guardo in privato per aumentare la mia autostima.
18. Quando non faccio selfie, mi sento distaccato dal mio gruppo sociale.
19. Prendo i selfie come fossero trofei per i ricordi futuri.
20. Uso gli strumenti di modifica per migliorare i miei selfie e apparire più bello/bella degli altri.
Alla luce di quanto riportato, tengo a precisare che questa scala non ha valenza diagnostica ed è solo un punto di partenza che gli autori dello studio hanno voluto promuovere per future ricerche, ma se nel rispondere a questi venti quesiti avete riportato un punteggio elevato (il massimo è 100), il risultato può darvi la possibilità di interrogarvi su quanto un simile comportamento possa aver preso piede nella vostra vita e sia diventato non solo un gesto automatico svuotato di senso, ma soprattutto un’azione che inconsapevolmente rappresenta un sostegno per un’autostima carente e vi fa sentire accettati.
Nel selfie, chi guarda chi? Questa domanda, che può sembrare curiosa, introduce la tematica del rapporto con lo specchio (e quindi con lo sguardo) e svela il principio che distingue un’azione che faccio per me da una che ha bisogno della presenza dell’Altro. Se mi guardo allo specchio (o mi faccio un selfie allo specchio), lo sguardo in questione è solo il mio. Se mi guardo allo specchio e chiamo qualcuno (o scenario più diffuso: scatto un selfie allo specchio e lo invio a qualcuno su WhatsApp e/o lo condivido sui social network), lo sguardo in questione non è più solamente il mio, ma quello di un pubblico, e lo sguardo dell’Altro (o degli altri) mi torna indietro attraverso un commento, un giudizio, un emoticon, e si trasforma in un feedback, in una valutazione, diventa l’immagine di me che l’Altro mi restituisce. Qui si può comprendere il passaggio concettuale dall’autoritratto pittorico, inteso come atto unico e teso alla rappresentazione di sé, al selfie, riconoscibile come atto ripetibile all’infinito e orientato al racconto di me. L’avvento della fotocamera frontale ha permesso a chiunque di trasformarsi in “provetto” fotografo: basta inquadrare, scattare e riguardarsi. Ovviamente, non è sufficiente fare delle foto per definirsi fotografo; sto parlando piuttosto della diffusa percezione di diventare competente, in un certo settore, semplicemente utilizzandone gli strumenti di riferimento (e questo gli psicologi lo sanno bene). Dunque lo smartphone assume le funzioni di uno specchio, simbolico e materiale. E se lo scatto non mi piace, posso rifarlo ancora, e ancora, e ancora. Inoltre, raggiunta l’immagine desiderata, posso modificarla con i filtri, sia attraverso quelli già in dotazione gratuitamente su famosi social network (come Twitter o Instagram), ma anche tramite specifiche applicazioni (di cui alcune anche a pagamento) per poter rendere la foto ancora più desiderabile. A furia di modificare le immagini però, creiamo un Sé ideale (e idealizzabile dagli altri) che ci riproduce per come ci piacerebbe vederci, o per come abbiamo l’ambizione di diventare. Nelle modificazioni più marcate assistiamo a delle vere e proprie trasformazioni, correndo il rischio di diventare avatar di noi stessi, creando un alter ego virtuale, verosimile ma non reale. Non intendo oppormi alle sperimentazioni, che reputo importanti e formative, ma il suggerimento è di fare queste esperienze in maniera oculata e intelligente, poiché in alcune situazioni si corre il rischio di andare incontro a uno “scollamento” tra il Sé reale e quello idealizzato. Gli altri, specialmente se sconosciuti, entreranno in contatto solo con l’immagine “migliorata” di noi e si relazioneranno a quella, facendoci sentire accettati solo per ciò che “di bello” mostriamo. Ripensate a quante risate abbiamo fatto in passato, guardando alle nostre “imperfezioni” nelle vecchie foto scattate nelle cabine fototessera (o dal fotografo professionale), destinate a documenti quali carta d’identità, patente e passaporto. Uno scatto per il quale ci si prepara(va) più o meno minuziosamente e che ha la funzione di accompagnarci per molti anni, tutti quelli necessari ad arrivare alla scadenza del certificato. Bene, i tempi sono cambiati anche per le fototessere: se prima era la macchina che decideva per noi, dandoci poche opzioni per scegliere l’immagine migliore, oggi (per esempio grazie all’app ImpressMe) è la foto cabina che si mette al nostro servizio e stampa le foto che decidiamo noi. Tramite un software infatti, è possibile inviare le nostre immagini al noto apparecchio posto nelle strade e nelle stazioni delle nostre città e riprodurre su carta i nostri scatti preferiti. Allo stesso modo con cui vengono applicati filtri e migliorie nel post-produzione delle foto, anche questo passaggio storico testimonia come siamo diventati noi gli attori principali di tutto il processo: soggetti della foto, “scenografi”, fotografi, “editori”. Sottolineo, come nelle righe precedenti, che ciò non significa poter fare a meno di professionisti che hanno studiato per diventare competenti ed esperti nel loro campo, ma che il libero accesso a queste strumentazioni dia l’opportunità a ognuno di concentrare su di sé il pieno potere di ogni fase (viene alla mente YouReporter, il primo sito giornalistico “partecipativo” dove si possono caricare video dal cellulare e “trasformarsi” in cronisti). Ho parlato di specchio e di immagini, e la novità che da qualche anno ha fatto irruzione nelle nostre vite di cittadini del mondo globale è proprio questa: dare la possibilità a chiunque di raccontare la propria vita, giorno per giorno, attraverso le immagini. Si è passati dunque dal blog, fatto di parole e racconti scritti, al vlog (video blog), composto da immagini e video. Uno storytelling che non conosce sosta e che risulta costantemente disponibile al “nostro pubblico”, una narrazione spesso ego-riferita, che consente di avere la sicurezza della presenza dello sguardo altrui h24. Un Grande Fratello tascabile insomma. Sono state nominate le foto e non solo, perché nel corso del tempo gli scatti sono diventati brevi video (spopolò, prima di chiudere, Vine: un’app che consentiva di girare video da 6 secondi), a loro volta soppiantati dalle “storie” di Instagram, che consentono invece di avviare una diretta (il live streaming), di realizzare video con effetti speciali (inserire sottofondi musicali, utilizzare lo zoom e il rewind), registrare video della durata di 15 secondi, ma che possono proseguire a oltranza, trasformandosi in lunghe clip. Sempre per rimanere in tema televisivo/orwelliano, negli ultimi tempi è stata addirittura lanciata la TV di Instagram, realizzata con l’insieme dei video di tutti gli utenti che seguiamo e che preferiamo, una sorta di personalizzazione ancora maggiore rispetto alle possibilità già prospettate da YouTube. Tutte le attività che ho descritto possono essere anche corredate da accorgimenti che favoriscono la diffusione di questi contenuti e mi riferisco a:
• gli hashtag, l’etichetta che associa il simbolo # a termini o slogan significativi, per permettere una ricerca più rapida delle parole chiave;
• il geotag, la pos...