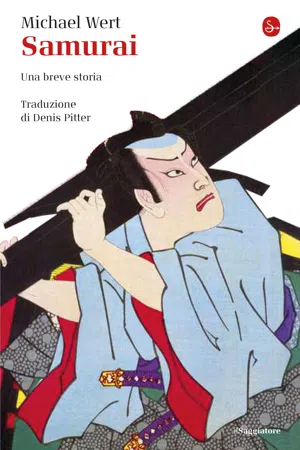![]()
1. Diventare «coloro che servono»
Il termine samurai viene usato colloquialmente, anche in Giappone, come sinonimo di «guerriero», ma ciò è fondamentalmente scorretto. In origine aveva un significato molto generico, riferendosi a chiunque fosse al servizio di un nobile, anche con un ruolo non militare. Progressivamente è diventato il titolo dei servitori armati delle casate di guerrieri – infatti, prima del xvii secolo, un guerriero di rango elevato si sarebbe offeso se fosse stato chiamato «samurai». Nel Giappone classico e medievale vi erano altri termini, più comuni, per indicare i guerrieri e che riflettevano i loro vari doveri verso lo Stato, la nobiltà e le altre gerarchie superiori. La maggior parte degli esperti giapponesi e occidentali utilizza il termine generico bushi, che significa «guerriero».
Guerriero è un termine volutamente ambiguo per indicare un ampio gruppo di individui, prima del xvii secolo, con un qualche ruolo di natura militare, e ciò include tutti coloro che, all’occorrenza, erano tenuti a prestare servizio militare per lo Stato o che avessero ricevuto un riconoscimento ufficiale da un’autorità governativa, come per esempio la nobiltà, la corte di Kyoto o le istituzioni religiose. Il termine guerriero è impreciso anche perché suggerisce erroneamente che la guerra fosse l’unica occupazione di tale gruppo. A seconda delle epoche e dello status, infatti, i guerrieri potevano alternare governo, commercio, agricoltura, pittura, scrittura, istruzione privata o attività più losche.
Un’altra accortezza, quando si usa il termine guerriero, spesso è il valore morale che l’uomo moderno attribuisce a questo concetto. L’esercito statunitense usa il termine «guerriero» in molti dei suoi programmi di addestramento, come il «Warrior Mind Training», un programma di meditazione creato per aiutare i soldati ad affrontare il disturbo post traumatico da stress e per prepararli alla durezza del conflitto. Lo sviluppatore ha sfruttato l’immagine del samurai per vendere il programma, «facendolo risalire all’antico codice di autodisciplina dei samurai».1 Ma un tale codice non esisteva. Anche le espressioni utilizzate ironicamente presuppongono l’esistenza di un’autentica e ammirevole immagine di guerriero; «il guerriero della domenica», per esempio, sembra suggerire che durante la settimana siamo persone ordinarie e noiose, ma che diventiamo qualcun altro, in qualche modo più selvaggi, durante i fine settimana. In questa accezione moderna, guerriero è qualcosa che si è, non qualcosa che si fa.
Tuttavia, nel corso della storia giapponese, la popolazione ha spesso disprezzato i guerrieri. Artisti e scrittori li rappresentavano come bestie al pari dei cani, esseri rozzi e assassini. Talvolta i guerrieri compivano razzie e omicidi nei villaggi che incontravano lungo la strada. I contadini li detestavano e li temevano perché erano quelli che pagavano il prezzo più alto per i loro saccheggi e i danni collaterali. Ironia della sorte, fu solo nel Giappone premoderno (1600-1868), un’epoca di relativa pace, che la gente comune cominciò ad ammirare e a imitare i samurai.
Sia chiaro, una delle occupazioni dei guerrieri era ovviamente combattere. Tuttavia, essi trascorrevano la maggior parte del tempo a fare altro, come cercare di accrescere lo status della famiglia in una società elitaria dominata dalla nobiltà, oppure gestire i contadini nelle proprie tenute, o addirittura, per quei guerrieri di basso rango, dedicarsi a occasionali truffe. I limiti delle attività di un samurai erano determinati dalla definizione stessa di «guerriero», che mutava con il passare del tempo. Se un samurai fosse tornato indietro nel tempo, per esempio dal xix secolo al ix, difficilmente sarebbe stato riconosciuto come appartenente alla stessa categoria.
I guerrieri del lontano passato erano fonte di intrattenimento, inquietudine e ispirazione per i samurai delle epoche successive. All’inizio del xviii secolo, un’epoca di pace, un cronista samurai si lamentò così dei suoi contemporanei: «anche il polso della gente è cambiato. Quello dell’uomo è diventato uguale a quello della donna», niente a che vedere con i veri guerrieri del secolo precedente, un’epoca di guerra.2 Hōjō Masako, una monaca buddhista del xiii secolo, fece appello al retaggio del suo defunto marito Minamoto Yoritomo, una sorta di padre spirituale dei guerrieri che combatté contro un imperatore a Kyoto. E non bisogna nemmeno dimenticare il fascino materiale del passato: i samurai di alto rango amavano collezionare spade o tazze da tè appartenute a famosi guerrieri di epoche precedenti.
I guerrieri si servivano dell’abilità militare anche come mezzo per fare carriera. Dal punto di vista politico erano degli outsider: semplici strumenti nelle mani di nobili influenti che li usavano come scagnozzi per presidiare le proprie terre o per sorvegliare altre casate intente a conquistare i territori con la forza. Gran parte del Giappone apparteneva di fatto all’imperatore (il tennō, letteralmente «sovrano celeste») che, secondo l’antica mitologia, discendeva dagli dèi, mentre i guerrieri proteggevano gli interessi del sistema imperiale che aveva sede nelle antiche capitali di Nara, Nagaoka e, dal 794, di Kyoto. Difendevano la capitale da potenziali focolai di violenza, attaccando chiunque, nelle province lontane da Kyoto, potesse minacciare il regime e conducendo campagne contro le numerose tribù «barbare» che si trovavano ai confini del Giappone, nel Nordest o nel Sudovest del paese.
Il termine «guerriero» solitamente non includeva chi vivesse di violenza, come mercenari, banditi e pirati. Prima del xvii secolo, tuttavia, lo status di una persona non era così ben definito. Alcuni individui, temporaneamente legati a un’istituzione ufficiale, potevano prendere parte legalmente alla guerra, alle attività di governo e al commercio. Per esempio, sebbene la maggior parte dei guerrieri e delle autorità descrivessero i pirati come violenti banditi del mare, a volte questi si arruolavano comunque al servizio del regime guerriero chiamato shogunato, oppure di un’istituzione religiosa come un tempio buddhista o di un nobile che si era rifugiato nella capitale di Kyoto. I pirati monopolizzavano il commercio marittimo, imponevano regole di condotta e avanzavano pretese su tutte quelle popolazioni che vivevano lungo i corsi d’acqua, esercitando l’autorità come lo avrebbe fatto un condottiero o un’amministrazione militare.
Negli studi linguistici sia giapponesi sia inglesi è infuriato un dibattito sulle origini dei guerrieri del Giappone premoderno, in parte proprio a causa della definizione di samurai. Si trattava, dunque, di una mera estensione e prosecuzione dei soldati antichi? Le prime testimonianze su guerrieri-soldati sono anteriori alla storia scritta e al Giappone stesso. Gli haniwa, figure di terracotta raffiguranti soldati, servitori e animali, erano collocate all’esterno delle tombe che costellavano le antiche aree di sepoltura già fra il iii e il vi secolo d.C., e l’importanza dei guerrieri si ritrova nelle armi e nelle armature dei soldati, che rispecchiano quelle dello stesso periodo in Cina e nei regni di Corea, presentando uno stile comune che evidenzia l’esistenza di un antico sistema di governo che influenzò in particolar modo il Giappone centrale e sudoccidentale. Si trattava forse di cacciatori e proprietari terrieri delle province orientali? Oppure di guerrieri professionisti ingaggiati dalla corte di Kyoto? Possiamo affermare con certezza che la figura del militare specializzato emerse come una caratteristica permanente nella storia giapponese intorno al ix secolo, quando alcuni di questi guerrieri iniziarono a rivendicare la propria autorità sul prossimo piuttosto che a servire come semplici soldati.
Le testimonianze scritte della storia dei guerrieri possono essere fatte risalire alla fine dell’viii e all’inizio del ix secolo, quando il primo Stato giapponese adottò la struttura amministrativa della dinastia cinese Tang (618-907), potere culturale e politico dominante dell’Asia orientale. Oltre a adattarne i vari titoli di corte, i gradi nobiliari, le strutture burocratiche e la cultura, i primi sovrani giapponesi copiarono anche l’organizzazione militare Tang. La corte aveva bisogno di uomini che operassero nelle unità provinciali nei momenti di bisogno e, sebbene sulla carta esistesse un esercito di leva, la maggior parte dei soldati si presentava solo per brevi incarichi occasionali (fino a trenta giorni circa). Molti di questi coscritti, per esempio, servivano nella guardia di frontiera, mentre per gran parte dell’anno si dedicavano al proprio sostentamento. Dovevano inoltre procurarsi armi e attrezzature proprie e non passavano molto tempo a addestrarsi. Solo gli ufficiali lavoravano nell’esercito per periodi più lunghi di tempo e alcuni storici hanno sostenuto che questi fossero per lo più impegnati in incarichi gestionali, piuttosto che in intensi addestramenti militari o di guerra. Gran parte del modello amministrativo dei Tang fu abbandonato in Giappone verso la fine dell’viii secolo e fu gradualmente sostituito, nel corso del secolo e mezzo successivo, da guerrieri specializzati.
Più in generale, a partire dall’inizio dell’viii secolo esistevano varie tipologie di guerrieri, la maggior parte dei quali non «possedeva» le terre in senso stretto, ma riceveva parte della rendita di una tenuta e il diritto di riscuotere le tasse – e di farci la cresta – dalle tenute di proprietari terrieri non residenti e che vivevano a Kyoto. Alcuni godevano di una discreta libertà dalle ingerenze delle autorità di Kyoto o dei loro rappresentanti nelle province. Altri possedevano terreni e ne consegnavano parte a una famiglia nobile non guerriera di Kyoto in cambio del patrocinio, cioè della garanzia che altri non ne avrebbero rivendicato la proprietà. Altri guerrieri ancora erano loro stessi membri di casate nobili, seppur di rango inferiore rispetto alla maggior parte dei potenti che detenevano le alte cariche burocratiche nella capitale. Di questi, alcuni avevano allacciato legami e alleanze sul territorio durante un mandato di governo in provincia, per poi stabilirvisi in modo permanente e diventare così signori-guerrieri che si appoggiavano a famiglie di guerrieri minori, pur continuando a mantenere i legami con gli alleati e le risorse della capitale. Kyoto era il centro del governo e la città più grande dell’epoca ed esercitava una forza centripeta sui clan elitari di tutto il Giappone. Chi apparteneva all’aristocratica stirpe di Kyoto, poteva occupare, nelle province, gli strati sociali più alti della società. Nelle campagne, le famiglie eminenti temevano che Kyoto inviasse i governatori a controllarle, e che la politica della capitale potesse minacciare il loro accesso alle risorse locali.
Questi guerrieri non avevano un modello organizzativo unico. Alcuni si riunivano in bande armate, fondate su legami di parentela, lealtà personale o nemici comuni. Altri cooperavano per conto di famiglie nobili che vivevano nella capitale, per funzionari provinciali o per signorotti locali. Non sorprende dunque che la capacità di combattere e di organizzare risorse per una campagna militare fosse più efficiente tra questi gruppi specializzati rispetto ai soldati di leva, le cui fonti di sostentamento venivano interrotte, e non accresciute, dalla guerra. In definitiva, lo Stato dipendeva da queste milizie specializzate per le attività militari e di polizia, ma tale dipendenza non implicava che i guerrieri sottraessero autorità allo Stato, né si trattava dell’inizio della fine per la classe dirigente, come si insegnava una volta; la corte e la nobiltà erano comunque al comando.
Tendenzialmente, i guerrieri più potenti del Giappone classico e medievale appartenevano a loro volta alla nobiltà e, quindi, erano poco incentivati a sfidare lo statu quo della loro comunità. Molte grandi casate interconnesse che dominavano il Giappone, come i Taira e i Minamoto, sebbene non raggiunsero mai i gradi più alti della nobiltà, discendevano comunque da figli di imperatori esclusi dalla successione dinastica. L’imperatore conferiva un cognome a questi figli, che davano vita a clan propri o intraprendevano carriere simili a quelle delle famiglie nobili (servire come funzionari a corte, ricoprire un ruolo importante e influente nel clero buddhista o diventare guerrieri professionisti). Ma non tutte le famiglie col medesimo cognome, come i Minamoto, seguirono lo stesso percorso.
Ci si potrebbe chiedere, però, se qualche guerriero abbia cercato di rovesciare l’imperatore a Kyoto o di ritagliarsi un proprio territorio indipendente. Taira Masakado fu il primo aspirante ribelle contro la corte. Viveva nel Giappone orientale, non lontano dall’attuale Tokyo, circondato da altre famiglie del clan Taira che controllavano i territori a est. Alcuni di loro erano rappresentanti della corte imperiale. Masakado aveva vissuto a Kyoto al servizio della corte, ma era soprattutto un uomo dell’Est, una terra lontana dal centro del potere politico e culturale. Quello che era iniziato come un conflitto per il territorio tra diverse famiglie del clan Taira e i parenti di Masakado – scontri che la nobiltà di Kyoto aveva ampiamente ignorato – si trasformò in un vero e proprio atto di ribellione nel 935, quando Masakado si oppose ai Taira, che erano i rappresentanti dell’imperatore. Probabilmente Masakado non aveva una reale intenzione di rivoltarsi contro l’imperatore, né aveva mezzi sufficienti per minacciare direttamente Kyoto, ma si autoproclamò comunque «nuovo imperatore» d’Oriente, una carica che tuttavia non detenne a lungo, perché fu ucciso da un cugino nel 940.
Un altro sfidante dell’autorità imperiale e nobiliare fu Taira Kiyomori, anch’egli discendente di un imperatore e cresciuto a Kyoto come altri aristocratici. Quando all’interno della famiglia imperiale scoppiò una disputa di successione su chi sarebbe diventato il nuovo imperatore, Kiyomori guidò le truppe del vincitore; gli sconfitti, per lo più sotto il controllo di Minamoto Yoshitomo, furono esiliati o uccisi. Ciò che era iniziato come una lotta contro le forze che rappresentavano i nobili mecenati si trasformò in una rivalità tra Kiyomori e Yoshitomo. Il primo sconfisse il secondo e cominciò ad accumulare titoli aristocratici, incarichi burocratici e proprietà terriere di provincia. Sul finire del 1170, era diventato una vera e propria minaccia per il potere imperiale. A Kyoto, collocò degli alleati in posizioni importanti non ancora sotto il suo diretto contr...