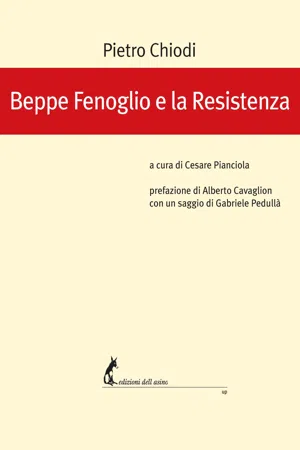![]()
Pietro Chiodi di Cesare Pianciola
L’assunzione consapevole di ciò che è stato,
è il coraggio di fronte al limite che il passato impone al futuro.
P. Chiodi, Arte e ripetizione,
“I 4 Soli”, novembre-dicembre 1956
Forse per vivere bisogna dimenticare,
ma certamente per capire bisogna ricordare.
P. Chiodi, Fenoglio, scrittore civile, 1965
Riproponiamo tre scritti di Pietro Chiodi su Beppe Fenoglio, Leonardo Cocito e la Resistenza, riportando in appendice un saggio di Gabriele Pedullà che analizza estesamente questi temi.
Cinquant’anni fa, il 22 settembre 1970, il filosofo moriva alle Molinette di Torino, per le complicazioni di una operazione cui si era sottoposto per alleviare i dolori artritici che lo tormentavano fin da studente e si erano nel tempo aggravati. La morte improvvisa gli impedì di affrontare la traduzione della Critica del giudizio, dopo quelle della Critica della ragion pura e degli Scritti morali di Kant che aveva pubblicato presso l’Utet (Torino 1967 e 1970), e di scrivere il saggio sulla nozione di “bisogno” che aveva progettato.
Era nato il 2 luglio 1915 in provincia di Brescia, a Corteno (paese dell’alta Val Camonica, oggi Corteno Golgi, dove il padre era panettiere e la madre maestra). Dopo le magistrali a Sondrio, con una borsa di studio si trasferì a Torino per frequentare l’Università e laurearsi nel 1938 alla Facoltà di Magistero con Nicola Abbagnano, che l’anno seguente avrebbe pubblicato La struttura dell’esistenza, un libro fondamentale dell’esistenzialismo italiano. Nell’autunno 1939 cominciò a insegnare al Liceo classico “Govone” di Alba e qui ebbe tra suoi allievi in terza liceo il futuro scrittore Beppe Fenoglio, che lo avrebbe ricordato insieme ad altri suoi insegnanti in Primavera di bellezza e lo avrebbe raffigurato come professor Monti nel Partigiano Johnny (“Chiodi s’era alzato, nella sua orsina massiccità di montanino retto da anni di esistenza pianurale. Gli diede un abbraccio filosofico, dicendo come il rivederlo fisicamente gli piacesse distruggendo la prescienza della comunicazione”). In una intervista del 1962 sulla “Gazzetta del Popolo” lo scrittore ricordava così il suo insegnante: “Il prof. Chiodi, massimo studioso di Heidegger in Italia, (…)sapeva parlare ai giovani a scuola e nelle sale dei caffè e spalancava menti e coscienza. Quanti di noi andammo nei partigiani perché sapevamo che c’era anche lui? E quanti gli devono la propria formazione intellettuale e civica?”.
Al “Govone” strinse un profondo legame di amicizia con il collega di italiano Leonardo Cocito, la cui vicenda partigiana, conclusasi tragicamente, ebbe tratti comuni con quella di Chiodi, che nel marzo 1944 comincia l’attività resistenziale ad Alba; l’8 giugno ritrova con gioia Cocito, che era già alla macchia da mesi con i suoi uomini, ai primi di luglio organizza una banda nel Roero, sulle colline intorno a Bra. Il 18 agosto Cocito, Chiodi e altri compagni furono catturati dalle SS italiane, interrogati dalla Gestapo a Bra e poi trasferiti alle Nuove di Torino. Cocito venne impiccato dai tedeschi il 7 settembre 1944, insieme ad altri sette condannati a morte, a Carignano, dimostrando un coraggio che impressionò i suoi carnefici.
Chiodi invece fu deportato negli stessi giorni in un lager a Bolzano, poi in un altro ancora alla periferia di Innsbruck, dove, malandato e al limite delle forze fisiche, fu aiutato da un medico austriaco a farsi passare per lavoratore volontario italiano immigrato e ad avere il documento per il rimpatrio. All’inizio di ottobre ritornò fortunosamente a casa dei suoceri a Montaldo Roero e nel gennaio 1945 riprese con il nome di “Valerio” a riorganizzare la guerriglia, partecipando a vari scontri armati e poi alla liberazione di Torino alla fine di aprile come comandante del battaglione garibaldino “Leonardo Cocito”. Appena dopo la guerra, Chiodi raccontò in forma diaristica queste vicende in Banditi, uscito nel 1946 a cura dell’Anpi di Alba, con l’avvertenza dell’autore: “Questo libro non è un romanzo, né una storia romanzata. È un documentario storico, nel senso che personaggi, fatti ed emozioni sono effettivamente stati”. Fu ripubblicato a Cuneo nel 1961 da Panfilo, alias di Arturo Felici, un piccolo tipografo-editore, ex resistente di Giustizia e Libertà, e poi dal 1975 in varie edizioni postume da Einaudi (ora è in catalogo con un’ampia introduzione di Gian Luigi Beccaria, che come Franco Fortini, Claudio Pavone e Mimmo Franzinelli, lo colloca tra i migliori esempi di memorialistica resistenziale).
Ritornato al “Govone” di Alba, riprese l’insegnamento e gli studi. Grazie ai suoi lavori, tra cui, oltre a molti articoli e recensioni, la prima traduzione italiana di Essere e tempo di Heidegger (1953), che coniò i termini essenziali del vocabolario heideggeriano poi usati in Italia – a partire da Dasein, tradotto con Esserci – , e i libri L’esistenzialismo di Heidegger (1947) e L’ultimo Heidegger (1952), ottenne nel 1955 la libera docenza in Storia della filosofia. Nel 1957 si trasferì a Torino con la sua giovane compagna Aida Ribero (1935-2017), dalla quale ebbe nel 1965 il figlio Andrea.
Divenuto titolare della cattedra di Filosofia della storia a...