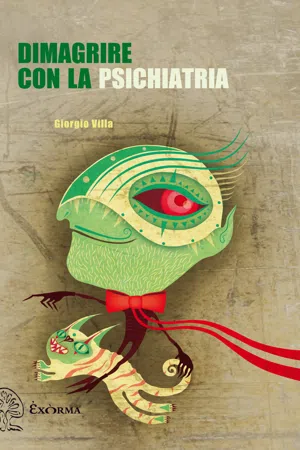![]()
F70.9 Ritardo Mentale Lieve [317]
F60.6 Disturbo Evitante di Personalità [301.82]
LA COSTELLAZIONE DI MORTE
«Vi ammazzo! Vi ammazzo tutti! Brutti ladri!», urlava, nel cuore della notte, Enrico, ventottenne, 130 kg di peso per 1 metro e 90 di altezza, brandendo un tubo di ferro.
Da due mesi era in Comunità e sembrava trovarcisi abbastanza bene. Aveva addirittura tenuto una specie di conferenza su un tema a lui estremamente caro: “La pesca in acqua dolce”.
Forse era stata una conferenza troppo tecnica, costellata di termini specifici relativi al tipo di pastura da utilizzare, di informazioni sul grado di elasticità delle canne e sulla robustezza dei fili di nylon da usare, a seconda del tipo di preda che si era scelta ma, del resto, la pesca era l’unica passione di Enrico e il luogo nel quale si esaltava la sua attitudine a stare da solo per ore e ore.
Attraverso la pesca Enrico si era fatto un’idea del mondo che era destinato a un catastrofico processo di involuzione. Secondo lui, da una mitica “età dell’oro”, che coincideva con le culture dei cacciatori-raccoglitori, epoca nella quale si pescava liberamente e ovunque, si era andati incontro all’“età dell’argento”, che individuava nell’antico Egitto, all’“età del bronzo”, epoca dell’antica Roma, per continuare all’“età del ferro”, coincidente con il Medioevo, all’“età della terra”, dal Rinascimento fino alla fine della Seconda Guerra Mondiale e, da allora fino ai nostri giorni, all’“età della merda”.
In questa ultima epoca tutto è sottoposto a regole ferree e pazzesche, ma tutto è anche inquinato ed è pazzo chiunque voglia mangiare i pesci che pesca.
Nel corso della conferenza Enrico si era fatto sempre più cupo e, alla fine, dardeggiava tutte le dodici persone presenti alla sua performance con uno sguardo di fuoco, cattivo, parlando in tono sempre più minaccioso. Gli ultimi dieci minuti erano stati da incubo: «Chi sono i responsabili?», diceva, sempre più spesso, facendo una pausa a effetto e gli spettatori si muovevano a disagio sulle seggiole, convinti che Enrico individuasse in loro gli autori del disastro ecologico e dell’inquinamento della nobile arte della pesca.
Tutti si sentivano in trappola e non parve vero che il moderatore cogliesse un momento di pausa più lungo per accennare a un applauso al quale tutti si unirono disperatamente, sperando che fosse finita.
L’altra passione, il karatè, l’aveva dovuta abbandonare, non solo per l’eccessiva crescita del suo peso, ma anche perché aveva il difetto di doversi praticare almeno in due persone e, col tempo, Enrico non riusciva più a sopportare neanche la madre, figurarsi un estraneo!
Per questo era stato proposto il suo inserimento in Comunità, dal momento che si riteneva che non potesse vivere da solo in un piccolo appartamento ed era necessario capire quali regole di comunicazione dovessero porsi fra lui e la madre. Il padre era sparito tanti anni prima, sembrava si fosse fatto un’altra vita in Brasile.
Ma quella notte la pazienza di Enrico era arrivata al limite.
Già gli erano sparite tre o quattro musicassette e, dal portafogli, due banconote da mille lire. Subito dopo cena, quella sera, si era coricato sul letto e aveva cercato, automaticamente, il pulsante di accensione della sua radio.
La mano si era mossa nel vuoto: aveva guardato e si era accorto che la radio non c’era più.
Il suo compagno di stanza, Fabrizio, col quale aveva stretto un iniziale rapporto di amicizia, cercava di calmarlo: «Sai, sono cose che succedono: ho anche dei sospetti su chi possa essere stato, ma, per amicizia, non posso proprio dirtelo!».
Naturalmente era stato Fabrizio, espertissimo in furti con destrezza, a trafugare la radio e a rivenderla prontamente per potersi fumare qualche sigaretta in più.
Le parole di Fabrizio invece che calmare Enrico erano state come benzina sul fuoco e l’avevano portato a una progressiva esplosione di collera.
«Pezzi di merda… Pezzi di merda… Pezzi di merda», continuava a ripetersi fra sé e sé, in un vortice di rabbia impotente.
Gli operatori di turno avevano tentato di calmarlo in tutti i modi e sembrava che ci fossero, almeno in parte, riusciti, ma quando tutti erano andati a dormire la rabbia era cresciuta di nuovo a dismisura.
Era uscito dalla stanza e aveva incontrato Micia, la gattina della Comunità.
Gatto nero vuol dire scalogna. L’aveva afferrata e gettata dalla finestra. Micia, per fortuna, non ne riportò danni, se la diede a gambe e per qualche giorno, opportunamente, decise di non farsi vedere nei dintorni.
Era andato in bagno e, visto un vecchio tubo di ferro lasciato la sera prima dagli idraulici che stavano sistemando una perdita d’acqua, l’aveva afferrato e si era messo a gambe aperte in mezzo al corridoio.
Tutto il mondo gli era nemico, tutto il mondo era corrotto.
Si era sentito investito da un potente spirito vendicativo: anzi si sentiva il Vendicatore. I pazienti stavano tutti a letto, terrorizzati, e facevano finta di dormire: del resto, chi poteva affrontare quella montagna d’uomo!
Non sapeva bene con chi prendersela, ma intanto si era creata una tipica situazione di stallo.
Antonio, l’infermiere di turno, mi telefonò, allarmato, e si rassicurò del fatto che sarei subito arrivato in Comunità; a questo punto decise di agire.
Antonio non aveva mai dato fastidio a nessuno, ma nessuno aveva neppure dato fastidio a lui: una sua breve descrizione potrà rendere conto di questo fatto.
Antonio, trentacinque anni, è alto 1 metro e 70 e pesa 80 kg di muscoli formidabili nascosti sotto una fitta trama di tatuaggi tantrici.
Quindici anni fa ha iniziato la sua carriera di istruttore di arti marziali e, contemporaneamente, un percorso spirituale che lo ha portato – anno dopo anno durante le sue ferie – dal Tibet, al Nepal, al Buthan, al Sikkim, alla Giamaica, a Bangkok e così via sempre alla ricerca di illuminazioni spirituali e di maestri nelle arti marziali.
A ogni viaggio la sua pelle diventa sempre più coperta di tatuaggi meravigliosi al punto che, anche d’estate, è costretto a indossare camicie chiuse ai polsi e strette sul collo per evitare di far spaventare le persone che non lo conoscono ancora.
Silenziosissimo, passa i suoi turni in angoli remoti della Comunità avvolto in una nuvola di incenso, spesso in meditazione, talvolta studiando.
Per tutti i pazienti è un mito: vanno da lui come si può andare a piedi alla madonna di Medjugorje. Lui li ascolta, fa il suo dovere di infermiere, ma talvolta li tratta a parolacce perché si presentano con la sigaretta accesa. Da lui i pazienti accettano ogni rimbrotto, lo rispettano troppo.
Solo una volta all’anno Antonio appare un po’ sbattuto e con il segno di alcuni lividi sul volto.
È il Giorno della Prova, come mi ha confessato lui stesso. In quel giorno tutti i suoi allievi, una decina di bestioni dai 90 kg in su, devono cercare di sconfiggerlo con tutte le loro forze e contemporaneamente. Lui deve semplicemente parare i colpi e deve sforzarsi di mantenere la serenità e di non fare male seriamente a nessuno.
Confesso che vorrei assistere qualche volta a una di queste prove che mi figuro un po’ come una ripetizione, in piccolo, di un combattimento di Bruce Lee.
Ma torniamo alla fatidica notte.
Mentre Antonio, leggero come un gatto, imboccava il lungo corridoio chiuso dalla massa imponente di Enrico pensava tra sé e sé: «Cosa faccio? Lo metto fuori combattimento e gli rompo un paio di costole, così giusto per ricordo? Oppure lo ammazzo e non se ne parla più, così la smette di rompere i coglioni, tanto stupido è, e stupido rimarrà e neppure tremila reincarnazioni lo salveranno da un i...