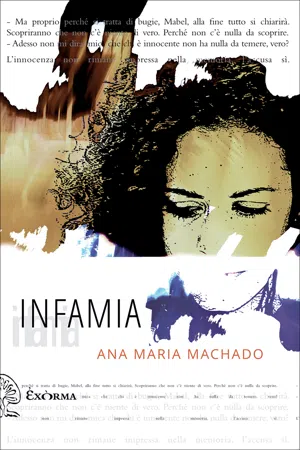![]()
prima parte
![]()
Intrusi
1
Frammenti.
Almeno, era quello che sembrava. E se così non fosse? La grafia non era nitida. Spazi, linee discontinue, caratteri poco chiari. Senza punteggiatura né accenti. Senza stanghetta sulla t. Ammesso che quella fosse una t. Poteva non esserlo.
Riconosceva la grafia inclinata della figlia sull’etichetta che identificava la cartellina. Una forma concreta per confermare la sua sopravvivenza lì, accanto a lui. Indizio fisico della sua presenza. Come se fosse necessario.
Una scrittura inconfondibile. Che, tuttavia, lo confondeva per mancanza di chiarezza. Sempre quei manoscritti vaghi. Vestigia di gesti rapidi rimaste sulla carta, che lasciavano spazio ad avventure divinatorie. O a sforzi di decifrazione. Soprattutto ora che la sua vista non gli permetteva più di distinguere così nitidamente. Forse dopo l’operazione ne sarebbe stato capace. Se, alla fine, si fosse davvero deciso a sottoporsi all’intervento. Ancora non sapeva cosa fare. Per il momento si trattava solo di una possibilità. Una prospettiva vaga. Tornare a vedere meglio. Scommettere. Correre il rischio che non andasse bene. E per che cosa?
Sfiorò la cartellina sulla quale un giorno avevano indugiato le mani della figlia, con le loro dita lunghe, capaci fin dall’adolescenza di realizzare al pianoforte un orgoglioso accordo di ottava. Sulla superficie di cartone erano passate quelle mani morbide che non gli avrebbero mai più potuto accarezzare il viso. Forse anche il retro dell’etichetta conservava ancora residui del suo bacio, nelle cellule di saliva lasciate dalla lingua di Cecília per incollarla e identificare così il contenuto. Ci aveva scritto sopra prima o dopo questo movimento? Quella parola che non riusciva a decifrare.
Frammenti, sembrava. Cocci. Schegge. Residui. Minuscoli resti materiali del suo cedimento.
Adesso, anni dopo, l’immaginazione del padre tentava di rivivere i suoi gesti, passo dopo passo, nello sforzo di comprendere la situazione in cui aveva lasciato sola la figlia. Abbandonata a sé stessa e al suo dolore mentre lui era assente. Per discrezione, eccessivo rispetto. Per paura di essere considerato un intruso nella sua vita.
Fece nuovamente uno sforzo per concentrare lo sguardo ed essere certo di quello che c’era scritto. Difficile. Nemmeno la luce lo aiutava. Forse, se si fosse alzato dalla poltrona, avesse aperto le tende e lasciato entrare nella sua pienezza il sole del mattino… Ma non era necessario: la lampada rischiarava già in pieno tutta la superficie. Illuminava la cartellina di cartone verde, con l’etichetta in basso a destra. Un’unica parola scritta a occupare tutto lo spazio bianco.
Manuel Serafim Soares de Vilhena aveva l’impressione che ci fosse scritto Frammenti.
O no.
C’era qualcos’altro. Forse un punto, un’abbreviazione? Impossibile esserne certi. Chissà, forse un’altra parola. Ma sembrava proprio quella. Si sarebbe quasi potuto affermare con certezza. Anche se non assoluta.
Frammenti. Fram.menti…?
Menti e mentire. Menti che serbano menzogne.
Schegge di debolezza senza fondamento. Non era necessaria una cartellina per conservarle. Né identificarla con un’etichetta riempita con una parola qualsiasi.
Resti di bugie affollavano ancora la sua mente – e quella di Ana Amélia, senza dubbio – confusi con la verità che gli era sempre stata davanti ma che entrambi non avevano saputo riconoscere nel momento in cui avrebbe fatto una qualche differenza. Ora questi indizi trascurati s’intrecciavano con elementi che riaffioravano, tessendo una trama di deduzioni. Occupavano tutto lo spazio disponibile, l’unico nel quale fosse interessato a muoversi. Si confondevano nel tempo della sua veglia e perfino durante il sonno. Una successione di giorni, ore, minuti e secondi, dietro i suoi occhi chiusi, dentro i suoi occhi aperti che fuori vedevano sempre meno.
– Posso interromperti?
Ancora prima di udire la voce di Ana Amélia, l’aveva sentita aprire la porta dello studio. Con la delicatezza di sempre, nonostante fossero passati tanti anni, non era capace di entrare senza bussare e aveva tamburellato lievemente sulla superficie di legno. Non tanto forte da svegliarlo nel caso si fosse appisolato ma non così piano da non farsi annunciare, per evitare di irrompere nella stanza all’improvviso.
Socchiuse gli occhi e rispose:
– Entra pure tesoro, tu non mi interrompi mai.
Non era vero, e lo sapevano entrambi. Ma faceva parte di quel tipo di attenzioni residue che gli piaceva coltivare.
– So di averti interrotto, Manuel. Quando ti ho visto con la testa appoggiata allo schienale, gli occhi chiusi e quel mezzo sorriso sognante, ero consapevole d’interromperti.
Sapevano tutti e due che il sorriso era inesistente. Ma l’ambasciatore stette al gioco.
– Se sorridevo vuol dire che non stavo dormendo.
Mentre si avvicinava alla finestra e scostava le tende pesanti, avendo cura di lasciare chiuse le altre, sottili e trasparenti, più vicine al vetro, lei disse:
– So di non averti svegliato. Ma penso di aver interrotto qualcosa. Pensieri, sogni, chissà cosa. E non mi piace, lo sai. Ma dovevo farlo.
– Perché, è successo qualcosa?
– No, niente. Non volevo intromettermi, ma la ragazza è già arrivata.
La ragazza? Quale ragazza? Non sapeva di nessuna ragazza.
Chi s’intrometteva adesso? Questa sì che era un’intrusa. In casa sua? Nel suo studio? Quel luogo che aveva creato con cura anni fa e che aveva riprodotto, sempre simile, in tutte le case e gli appartamenti dove aveva abitato, nelle molte città dei molti paesi in cui aveva vissuto. Biblioteca, ufficio e stanza di lavoro, era il suo angolo tra i libri, con una scrivania, una poltrona e un’ottima luce, il luogo da dove s’inoltrava in letture nelle quali, di solito, era lui a essere l’intruso. Era la sua pista di decollo per sbarcare in altri universi. Senza essere atteso né invitato, l’intruso perfetto. Anche adesso che quasi non leggeva più.
Come qualche istante prima, quando la moglie lo aveva interrotto.
Non so chi sarò dopo. Ogni volta mi sorprendo. E, se manca la sorpresa, desisto. Non mi attira più. Tranne quando sto solo prolungando un’esistenza già iniziata nelle pagine precedenti. In questo caso è un approfondimento e non c’è bisogno che sia una novità. Può continuare, perché non si tratta di mera ripetizione. Ma, a parte ciò, quello che mi affascina è il non avere idea di come andranno le cose, di quale direzione prenderanno e in quale maniera si evolveranno, prima che inizino ad accadere. Non immagino nemmeno chi sarò ogni volta. In quale scenario vivrò, in quale epoca. O con quanti mi identificherò, con quali anime torbide o trasparenti ma invariabilmente piene di sorprese. Quello che so, sempre, è che sarò un intruso a fianco di tanti altri esseri. Nessuno di loro sa che sono lì. E, tuttavia, nel crearli, qualcuno si era rivolto a me, aveva scommesso sul mio eventuale arrivo, senza potermi definire in anticipo.
Queste intrusioni mi viziano. Immersioni avide che ne esigono sempre un’altra subito dopo, e ancora un’altra, ogni volta più numerose e profonde. Da ogni tuffo ritorno più denso, portandomi dietro la perplessa evidenza dell’infinitezza umana. Una vita sola non basta. Ho preso il vizio di ricorrere ad altre vite, infinite.
2
Più tardi Giuseppe se ne sarebbe ricordato. Si svegliò prima che iniziasse ad albeggiare. Lentamente, mentre la stanza veniva invasa dalle prime luci, distinse i volti dei compagni addormentati. Faceva freddo. Nonostante il calore intenso delle giornate, quelle prime ore del mattino erano sempre molto rigide. Sentì la mancanza di qualcosa da mettersi addosso. Una tunica che lo scaldasse. Anche una qualsiasi, che non fosse la sua. Quella tunica inconfondibile. Quella veste dai molti colori che il padre gli aveva dato. Fatta fare apposta per il figlio della sua vecchiaia. Tessuta con fili che formavano motivi differenti, colorata con pigmenti di varia origine. Quella che gli avevano strappato quando era stato assalito, gettato nel buio, fatto uscire solo per essere venduto e fatto schiavo.
La sensazione di freddo lo spinse a ripiegarsi su sé stesso. Rannicchiò le gambe mettendole sotto la veste grossolana e di poco prezzo, dalla trama larga. Il corpo continuava a chiedere qualcosa di più. Non c’era bisogno che fosse il mantello che aveva usato recentemente e che pure aveva perso. Quel tessuto ornato di frange nel quale era solito avvolgersi negli ultimi tempi, quando il sole tramontava e la temperatura si abbassava – un’ampia cappa che, per qualche tempo, era servita a distinguerlo da lontano, mentre dava ordini e amministrava la casa del suo signore. Il mantello che aveva causato la sua disgrazia.
Faceva giorno. Giuseppe si sfregava le braccia nude e contemplava la trama rozza delle sue vesti, ruvide, frutto di mani callose su telai rudimentali. Fili grossolani intrecciati gli uni sugli altri, fino a sommare le forze e poter sopportare la pressione, sostenere peso e movimento.
I suoi pensieri si dilatavano, seguivano direzioni diverse. Con quanti fili si tesse un intrigo. Con quanti s’intreccia una trama. Con quante fibre si annoda una corda. Con tutti questi, con un solo nodo, s’impicca un uomo. Innocente o colpevole.
Meglio coperti, i suoi compagni di prigionia continuavano a dormire. Sonni inquieti, agitati. Alla sua destra il coppiere cambiò posizione, con un movimento brusco. All’altro angolo della cella il panettiere emise qualche lamento. Ma si calmarono subito entrambi. Meglio così. Che dormissero tranquilli. Un modo per passare il tempo, nell’attesa angosciosa che accadesse qualcosa.
Sebbene Giuseppe fosse straniero, gli altri erano soliti discorrere con lui. Si sfogavano. Alle volte gli chiedevano perfino dei consigli. Erano tutti uguali in quel momento, uniti da un destino comune. Dal passato, tuttavia, portavano con loro storie diverse. Nel futuro, solo il Signore avrebbe potuto dire cosa li aspettava. Quello che i Suoi piani prevedevano per tre uomini tanto diversi che si trovavano nella stessa cella.
Dal momento che sapeva di essere innocente, Giuseppe tendeva ad avere un giudizio simile sui due che dormivano. Concedeva loro il beneficio del dubbio. Evitava di credere nelle accuse che pesavano sui suoi compagni, incarcerati lì per aver fatto infuriare il sovrano che si era sentito offeso da loro. Da parte sua, non giudicava nessuno. Potevano essere entrambi senza colpe come lui. Come saperlo? Ignorava quali fossero i disegni di Dio per averli riuniti in quel luogo. Si limitava ad avere fiducia. Come sempre aveva fatto fin da bambino con la famiglia, giocando ai piedi dei genitori, al fianco dei fratelli.
La sua vita aveva già preso molte strade. Adesso aveva un compito, che gli era stato assegnato come parte della sentenza. Doveva servire gli altri due prigionieri, un coppiere e un panettiere. Prima di allora aveva già servito tra altre pareti, ma aveva anche vissuto all’aria aperta, padrone di sé stesso. Aveva già conosciuto la vastità dei campi e del deserto e il confino sepolcrale nel fondo di un pozzo asciutto. Aveva già ricevuto amore e affetto, e anche bastonate da chi amava. Era già stato dato per morto e venduto come schiavo. Aveva servito il capo delle guardie. Aveva amministrato tutti i beni del padrone, curato i suoi affari, lo aveva fatto prosperare. Era già stato calunniato e gettato in prigione. Condannato con prove e testimoni – anche se falsi. Come credere in quello che dicevano gli uomini? Si limitava alla parola del Signore.
Non si faceva alcuna illusione sulle deposizioni dei testimoni né sugli indizi. Nella sua breve vita, già per due volte una veste era servita come prova per cambiare il suo destino. In entrambe le occasioni era stata usata per avvalorare parole false e dargli un fondamento. Per costruire una menzogna.
Ancora bambino, nell’intromettermi in questa trama, era stato quello il dettaglio che, per primo, aveva richiamato la mia attenzione. Insieme alla cattiveria dei fratelli, è chiaro. Quell’invidia crudele era impressionante per un ragazzino al quale il padrino aveva regalato un volume della Storia Sacra, come lettura complementare del catechismo con il quale si preparava alla prima comunione. Mi sarei comunicato per la prima volta il giorno in cui il prete fosse venuto fino alla fazenda, in occasione della festa della santa patrona. Con un fiocco di taffettà bianco sulla manica candida della giacchetta inamidata, nella speranza di trovare un giglio che simboleggiasse la purezza. Forse sarebbe andata bene anche una dama-da-noite profumata, di quelle che crescono lungo lo stagno, con le radici nell’acqua. Finché non fosse arrivato quel giorno, io ero ancora solo una piccola anima forse peccatrice, forse condannata al limbo, sulla quale ricadevano le colpe ancestrali della sua specie. Un bambino terrorizzato dai racconti delle cattiverie dei grandi. Un ragazzino che sentiva di portare sulle spalle l’enorme peso del peccato – originale o comune – di cui tanto si parlava nelle domande e nelle risposte del catechismo imparate con metodo e ostinazione. Ma anche un bambino inquieto e pieno d’immaginazione, che aveva appena conquistato ali capaci di renderlo leggero e farlo avventurare in voli insperati, da intruso: fin dall’inizio dei tempi, ero il primo bambino di tutta la mia stirpe ad aver imparato a leggere. E avevo solo otto anni.
Grazie a questo miracolo, cominciavo a poter scavalcare le frontiere, scappare quando volevo ed essere un intruso nelle storie degli altri, anche quelle che giungevano da tempi immemorabili. Tutto, nella mia vita futura, sarebbe stato una conseguenza di questo potere inedito.
Perfino quando l’età e la fragilità mi avessero costretto a dipendere dalla vista altrui, che avrebbe invaso il mio territorio e il mio tempo. Intrusa, a sua volta.
Adesso, guardando gli abiti grossolani che vestiva, Giuseppe ricordava. Richiamava alla memoria ogni storia. Anche ciò che non aveva visto e poteva solo immaginare, come se l’avesse vissuto. Senza rammarico, nel tentativo di capire, di cercare un significato superiore. Certo che esistesse un proposito, un disegno più ampio per quella trama.
Nella prima occasione, era ancora un bambino. Era andato incontro ai fratelli, che badavano alle greggi della famiglia. All’improvviso, tutti insieme lo avevano aggredito e gettato nel fondo di un pozzo asciutto. Ma prima era stato spogliato della sua tunica. La bella veste, piena di colori, inconfondibile, fatta fare dal padre per vestire il figlio più amato. In seguito, lo avevano venduto al mercato degli schiavi.
Senza i suoi ricchi abiti, Giuseppe venne portato molto lontano da casa. Non era più vestito di vari colori quando attraversò il deserto, a piedi, con gli ismaeliti. Coperto di stracci, accompagnò la loro carovana di cammelli carichi di resine, balsami e laudano, in cammino per l’Egitto. Dove quelle merci erano molto valutate. Avrebbero reso bene perché erano usate per l’imbalsamazione. La tunica invece era rimasta là.
I fratelli la cosparsero con il sangue di un capretto e la inviarono al padre con un messaggio:
Ecco cosa abbiamo trovato. Guarda se è la tunica di tuo figlio.
Quale prova più eloquente della tragedia che non era accaduta? Quale indizio migliore per scagionarli e nascondere il crimine che, in realtà, avevano commesso?
Giacobbe riconobbe immediatamente la veste. Lui stesso l’aveva fatta fare con lane pregiate, tinte con pigmenti differenti.
– Povero me! È la tunica di mio figlio! È stato divorato da una belva! Il figlio amato della mia vecchiaia!
In segno di lutto, il padre rispose con i suoi abiti al messaggio che la tunica insanguinata gli recava. Strappò le proprie vesti. Si coprì con un sacco. Per lungo tempo pianse il figlio. Si pentì d’averlo mandato lontano da Cana in compagnia dei fratelli, per pascolare le greggi a Sichem.
Intimamente rimpianse di essere ...