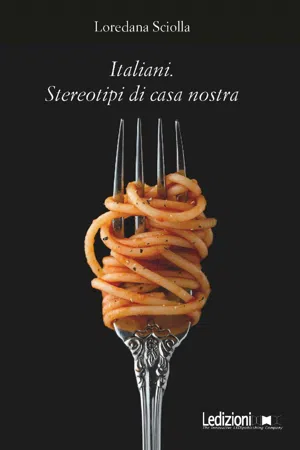![]()
Circoli virtuosi del familismo
Lealtà particolari nelle società moderne
Pensare per dicotomie e antitesi è caratteristica dell’inclinazione teorica delle scienze sociali. Nella tradizione sociologica è successo, a volte, che alcune dicotomie concettuali da strumenti euristici, utilizzati per cogliere i tratti salienti di fenomeni e processi sociali concreti, siano state innalzate a forme a priori dell’esperienza sociale, con un uso non più solo descrittivo, ma valutativo. Essere classificato nell’uno o nell’altro polo dell’alternativa implica, in altri termini, anche un giudizio di valore, positivo o negativo. Rientrano tra queste dicotomie quelle classiche di comunità/società e di particolarismo/universalismo.
Se mi soffermo su queste assai note e influenti dicotomie è perché entrambe, tra loro strettamente collegate, fanno da sfondo al modello interpretativo dell’arretratezza della società italiana fin qui considerato, nel senso che ne costituiscono gli assunti impliciti, dati per scontati. Nella formulazione classica, dovuta al sociologo tedesco Ferdinand Tönnies, mentre la comunità (Gemeinschaft) è intesa come «vita reale e organica», la società (Gesellschaft) è intesa come «formazione ideale e meccanica»; nella prima gli individui, che sono legati dalla comune appartenenza, sentono di fare parte di un tutto che li trascende, nella seconda essi si uniscono non in base a legami affettivi, ma al fine di perseguire un interesse comune.
Vengono così individuate due diverse forme di mentalità e di relazione sociale, che sono considerate tipiche rispettivamente del gruppo naturale, in cui rientrano la «comunità di sangue» (la famiglia e la parentela), la «comunità di luogo» (il vicinato) e la «comunità di spirito» (l’amicizia), e dell’associazione convenzionale (le associazioni volontarie e tutto ciò che ha una base contrattuale).
Si può dire che i due termini particolarismo e universalismo indichino, nel linguaggio delle scienze sociali, i due criteri di azione che contraddistinguono l’uno le relazioni comunitarie, l’altro quelle societarie. Si adotta – secondo Parsons – un orientamento particolaristico quando si agisce «in termini di obbligazioni verso un parente, un vicino, un membro di un qualsiasi gruppo solidale, in forza di questa appartenenza in quanto tale». Si agisce, invece, universalisticamente quando il criterio dell’azione è derivato dalla generalità di una regola normativa e di standard sganciati da contesti specifici, ad esempio l’obbligazione di adempiere agli accordi contrattuali. L’affinità tra le due dicotomie spiega perché spesso si usi indifferentemente l’una o l’altra, anche se la prima è un po’ passata di moda. Il pensiero sociologico sembra però dividersi su quale valore attribuire alla comunità e alla società, mostrando in alcuni casi una forte inclinazione a vedere in positivo la comunità in quanto stile di vita coeso e integrato contro quello individualista e atomizzato della società.
Le due antitesi non sono solo state usate per rappresentare analiticamente diverse forme della vita sociale, ma anche per indicare fasi successive del processo storico. Il passaggio dalla società tradizionale alla società moderna è stato inteso come transizione dalla comunità alla società, dal particolarismo all’universalismo.Secondo la teoria sociologica classica, in ciò affiancata dalla teoria liberale e dal marxismo, l’affermarsi della società industriale avrebbe comportato un processo di generale sradicamento. Le antiche differenze culturali e lealtà comunitarie sarebbero state progressivamente, ma irreversibilmente erose, soppiantate da relazioni sociali funzionalmente differenziate, orientate razionalmente e universalisticamente.
Le due antitesi vengono così ricomprese in una terza antitesi, quella che oppone la tradizione alla modernità, e il processo di modernizzazione finisce per assomigliare sempre più a un processo a somma zero in cui la presenza di alcune caratteristiche, che il termine modernità sintetizza, esclude tutte quelle riconducibili alla tradizione. Gli aspetti centrali del paradigma familistico/particolaristico possono essere visti come conseguenze logiche di questi assunti. Sinteticamente esse dicono: 1) legami e lealtà particolari sono residui del passato; la loro permanenza in alcune società moderne è indice inequivocabile di arretratezza e di modernizzazione incompiuta; 2) essi rappresentano in quanto tali il principale impedimento allo sviluppo di forme politiche e sociali basate su criteri universalistici, solidarietà ampie, relazioni aperte.
Il problema è che, nonostante una certa eleganza e consequenzialità logica, l’intero ragionamento non riflette o riflette solo parzialmente la realtà sociale e politica del XIX e del XX secolo. Innanzitutto paesi di nuova industrializzazione – in particolare dell’Asia e dell’America latina, tra cui il Giappone è il più noto – hanno mostrato che altissimi livelli di modernizzazione economica non solo sono compatibili con il mantenimento di rapporti e valori tradizionali, nel caso del Giappone anche di vaste ed efficienti reti clientelari, ma ne ricevono addirittura un sostegno. I rapporti particolari stessi, in questo caso, è bene sottolinearlo, non hanno escluso, ma hanno integrato criteri più oggettivi legati alla competenza tecnica. Anche nel cuore del vecchio mondo industrializzato si sono verificati fenomeni che per natura ed estensione non erano previsti dalla teoria prima descritta, mostrando che la sua principale inadeguatezza sta proprio nella sua forma rigidamente dicotomica, nella sua dimenticanza sistematica della forza e della capacità di adattamento e trasformazione dei legami fondati sull’appartenenza all’interno di società altamente sviluppate.
Quasi tutti i maggiori conflitti politici, ma anche alcuni tentativi di integrazione sociale, di questo secolo sono stati innescati da problemi legati, in vario modo, a solidarietà particolaristiche, basate sull’etnicità, la religione, il localismo. Basti pensare all’esplosione dei movimenti «afro-americani» alla fine degli anni Sessanta, alle resistenze all’assimilazione di diverse etnie negli Stati Uniti, all’attrazione esercitata dal richiamo ai confini etnici anche in situazioni caratterizzate da un alto grado di erosione culturale come in molte situazioni africane, alle rivendicazioni autonomistiche e ai conflitti endemici di comunità contraddistinte da specifiche caratteristiche linguistiche e religiose (Paesi Baschi, Galles, Quebec, Irlanda del Nord), ai movimenti indipendentisti in antiche nazioni come la Scozia e la Catalogna fino all’attuale esplosione dei conflitti etnici e nazionalistici nei Balcani e nei domini dell’ex Unione Sovietica, alla rivitalizzazione di movimenti religiosi fondamentalisti (negli Stati Unit...