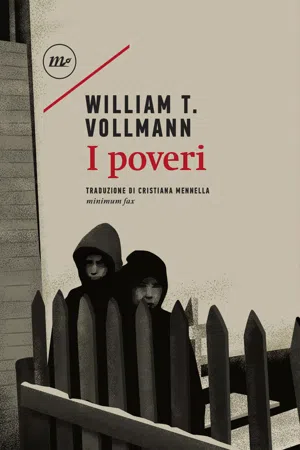![]()
1
/
Io penso di essere ricca
Thailandia, 2001
La prima volta che incontrai Sunee ero a Klong Toey in cerca di una persona povera a cui poter chiedere perché esisteva la povertà e lei mi si fiondò addosso ubriaca, tirandomi per la manica, pregandomi di andare a casa sua. Secondo la mia interprete era di sicuro un’ex prostituta perché sapeva qualche parola di giapponese e quando ci versò l’acqua esclamò giovialmente in inglese, proprio come le entraineuse di Patpong: Bele, bele!
Sebbene sconsigliato dall’interprete, decisi di accettare la proposta di Sunee [fotografie 19-21]. Eravamo a Klong Toey da neanche cinque minuti. Entrando nella baraccopoli più vicina, che era a una cinquantina di metri, ci ritrovammo nel solito dedalo di marciapiedi umidi e in pendenza, con le case a forma di scatola così vicine da toccarsi fra loro. Gli abitanti mi studiavano furtivamente dalle finestre-pertugio: volevo comprare eroina o delle bambine? Sunee ci faceva strada barcollando trionfante, la mano sul cuore. Due minuti dopo arrivammo a casa sua, o per meglio dire alla capanna di sua madre, con le pareti e il soffitto di tavole inchiodate fra loro, deformate, piene di fessure per la gioia delle zanzare thailandesi. Ci sedemmo tutti e quattro a gambe incrociate sul telo di vinile azzurro che copriva il pavimento di cemento. Notai per prima cosa il gatto rosso e scheletrico che si leccava e si rosicchiava, a causa delle pulci, immagino, poi lo specchio tondo che rifletteva puntualmente una parete di lamiera (e una mensola con dei barattoli), e infine l’odore di acqua marcia che regnava ovunque. La mia interprete, ancora indispettita, notò i casalinghi della madre di Sunee, in particolare due ventilatori, uno dei quali, quello funzionante al soffitto, era stato acceso dalla nostra ospite in segno di benvenuto; devo poi aggiungere il filtro dell’acqua, il televisore e il microfrigorifero. L’interprete mi informò con aria arcigna che Sunee non poteva assolutamente essere povera perché Sunee, o almeno la madre, possedeva più elettrodomestici di lei! La mia interprete era scaltra, esperta e, salvo quando si faceva ingannare dal rancore, non sbagliava mai. Nella fattispecie, il suo giudizio si dimostrò esatto quanto fulmineo perché venni subito a sapere che la casa era di proprietà; l’anziana signora l’aveva pagata di tasca propria. Bene. Dunque erano ricche. Intanto Sunee non la smetteva di guardarmi, sfiorandosi i seni da sopra la camicetta, asciugandosi di continuo il viso con l’orlo e il colletto.
Si era sposata una prima volta a diciassette anni, quando ancora era vivo suo padre. Risultato: quattro figli. Il marito faceva il muratore. Per dirla con le parole di Sunee: Lui non mi amava davvero, perché l’aveva lasciata per un’altra. Dieci anni dopo si era risposata e in premio aveva avuto un altro bambino. Se ho inteso bene, anche il secondo marito l’aveva abbandonata, anche se Sunee, che si dondolava e piangeva ubriaca, lo rievocò in maniera confusa, con la reticenza che in realtà forse serve a mascherare un dolore intimo; stavolta l’annoiata e disgustata interprete non fu d’aiuto come in precedenza. Comunque i due mariti, più che protagonisti del racconto sembravano generici agenti fecondativi che l’avevano attraversata come malattie. Sunee si era svegliata ritrovandosi madre di cinque figli, punto; aveva lavorato sodo per provvedere a tutti quanti, singhiozzò, soffiandosi il naso con la camicetta, appoggiandosi alla spalla della madre. Tre di loro facevano l’università; non venivano mai a trovarla. La quarta lavorava in banca. La più piccola viveva ancora con lei.
La bella frangetta ordinata e argentea della madre tremava nella brezza del ventilatore mentre la donna tracciava dei motivi serpentini sul vinile blu che copriva il pavimento, rattoppato ai bordi con il nastro da imballaggio. Lei stessa aveva partorito otto figli, tre dei quali erano già morti. Aveva sessantasette anni e Sunee più di quaranta.
Ora la mia vita è solo con mia madre, proclamò Sunee. Il mio solo potere è la mia mamma. Mi ha sempre detto: Sunee, cerca di essere forte perché io sono qui e non ti butterò mai via.
E la madre, con una smorfia larga, gentile, sdentata, guardava assorta la donna ubriaca.
Sunee faceva continuamente il wai, l’inchino thailandese a mani giunte in segno di benvenuto, gratitudine o rispetto, e poi diceva kap kun kah, grazie, a volte a me, altre alla madre.
Lavorava per un’impresa di pulizie cinese clandestina che non le concedeva mai un giorno di riposo; il suo capo aveva un cuore molto cattivo e al ricordo che esisteva una persona simile, la sua voce in fervida adorazione per la madre diventò stridula; continuò per un bel pezzo a graffiare l’aria mentre parlava male di lui finché, stremata dalla collera, si soffiò di nuovo il naso con la camicetta.
La madre frenava con dolcezza i suoi gesti più eccessivi. Ogni tanto le diceva di non essere maleducata.
Visto che sei infelice, vorresti farti suora?, chiese l’interprete.
No, non voglio. Dammi il tuo numero di telefono, mi disse Sunee. La madre le toccò mestamente il ginocchio; ma lei, ignorando l’avvertimento, iniziò di colpo a supplicare e pretendere, chinandosi in avanti, gesticolando, lisciandosi indietro i capelli. La mia interprete, che voleva bene a tutti e aiutava praticamente chiunque, compresi i terroristi, non riusciva a provare il minimo rispetto per Sunee, che continuava a dire: Mia figlia è buona; mia madre è buona. Io sono un’ubriacona.
Cosa ti piace bere? Mekong?
Il whisky locale.
Se potessi avere quello che vuoi, cosa ti piacerebbe?
Si strinse i pugni al seno e disse con voce lacrimosa: Soldi! Diecimila bath per mandare a scuola la più piccola. Mia figlia è buona. Adesso la mia vita non conta.
Una zanzara mi pizzicò il braccio.
Sunee doveva avermi preso per un missionario cristiano. Per quale altro motivo un uomo, per giunta bianco, avrebbe accettato di entrare in quella casa? In fondo lei era troppo vecchia per essere sexy, giusto? E allora perché non volevo darle il mio numero di telefono? Fissandomi maliziosa o forse con aria di sfida, gridò: Gesù ha detto: Posso morire per umani. Io, anche, posso morire... per mia figlia.
A questa dichiarazione, che in effetti avrebbe potuto indisporre un missionario cristiano, la madre le diede mestamente uno schiaffo sul ginocchio. Ignorando quel rimprovero come aveva ignorato i precedenti, Sunee continuò con voce ancora più forte: Io non faccio niente per altri, solo per mia figlia. Perché Gesù ha fatto le cose per tutte le persone del mondo? Perché per mia figlia no?
La madre le diede un altro schiaffo sul ginocchio.
Ti consideri povera?, chiesi.
Sì...
Ormai, ogni volta che penso a Sunee, mi torna in mente quella sua abitudine di toccarsi il seno e spalancare le braccia di scatto, come se le mancasse l’aria. Ho il ricordo di una persona che soffocava.
Non voglio essere ricca come il primo ministro, frignò. Se avessi soldi, li darei solo ai miei figli...
Quell’anno un dollaro americano valeva quarantacinque baht, perciò le visioni di Sunee ammontavano a circa duecentoventicinque dollari, di cui mi potevo tranquillamente privare. Sarebbe servito a qualcosa?
Mia madre dice che sono ignorante, ma in realtà sono intelligentissima... – e si chinò verso di me, strizzandosi i seni. Mia figlia lavora in banca; ha la macchina, ma non ci dà mai niente. Be’, non voglio crearle problemi! In realtà ogni tanto mi dà cinquecento baht più o meno...
In breve, Sunee che in teoria portava a casa il pane forse era una sanguisuga. La madre abbassò gli occhi, lisciando il pavimento con imbarazzo.
Quando non sono ubriaca, sono una persona tranquilla. Sono vent’anni che mi ubriaco. Se non mi ubriaco non riesco a dormire. Il whisky mi rispetta più degli uomini! Mia madre non prende mai whisky...
Secondo te perché certe persone sono povere e altre ricche?
Lei annaspò e disse: Noi siamo buddisti. Certe persone sono ricche perché hanno donato in una vita precedente. Quello che hanno donato viene restituito in questa vita.
E cosa ne pensi dell’idea comunista secondo cui le persone sono povere perché i ricchi gli portano via tutto?
Sì, perché quando ero in Giappone prima...
Non le dia retta, disse la madre. Non è mai stata in Giappone!
Ma l’interprete era sicura di sì. Molto probabilmente ci era stata, ma non lo aveva detto alla madre. Per anni ho visto le ragazze di Patpong tutte allineate sotto l’insegna YOUR’S HOUSE, una decina in abito lungo scollato, rosso o azzurro o rosa, ferme proprio sul bordo sotto le luci e gli archi, la porta alle loro spalle che non si apriva quasi mai; una volta all’ufficio passaporti di Bangkok ho incontrato un intero carico di ragazze uguali a loro, compreso l’abito pastello; un gentile giapponese pagava il visto per il suo paese, senza dubbio perché era puro d’animo. Donne della stessa nazionalità di Sunee mi hanno riempito il bicchiere a Kabukicho, il quartiere a luci rosse di Tokyo; una volta ho chiesto a tre cameriere in abito scollato se le loro madri sapessero in quale paese si trovavano in quel momento; si sono messe a ridere coprendosi la bocca con la mano.
Comunque il nostro re è molto buono!, gridò con patriottismo Sunee. Lui dona sempre.
Chiesi alla madre se anche lei pensava che i ricchi, le aziende o le nazioni fossero responsabili almeno in parte della sua povertà (oh, scusate; lei non era povera), e lei assentì subito alla maniera thailandese che non significa nulla. Buddista come la figlia, sapeva che le sue esistenze passate determinavano quella attuale.
Quindi, se uno è povero in questa vita, significa che ha fatto delle brutte cose nella vita precedente?
Certo, rispose Sunee al suo posto. E subito si tirò su i pantaloncini per mostrarmi le cosce avvizzite.
Siediti!, gridò in un inglese gioioso a un vecchio vicino tatuato che ci sbirciava dalla finestra e, quando lui entrò, si diede una manata sulla coscia.
Ma non riusciva a dimenticare l’impresa di pulizie clandestina di cui era schiava, che non le dava mai le ferie, ragion per cui se le prendeva da sola, come in quel momento, per esempio, ogni volta che sentiva il bisogno di ubriacarsi. Se ne stava lì, senza essere pagata, nella dimora di sua scelta, il sangue già addolcito da mezza bottiglia di whisky, e ancora non riusciva a staccarsi dal lavoro! Senza libertà di espressione non esistiamo. Sarà per questo che la vittima di un’atrocità, malgrado i bene intenzionati consiglino a più riprese di «lasciarsela alle spalle», non fa che ricordarne l’orrore. La giornata lavorativa di Sunee iniziava alle otto del mattino e finiva alle cinque e un quarto di sera. Probabilmente aveva un’ora per il pranzo e quindici minuti di pausa durante la giornata, perché l’impresa di pulizie le pagava otto ore di lavoro. Imparai a conoscere bene la frase dalle otto del mattino alle cinque e un quarto di sera perché, a ogni nostro incontro, Sunee la ripeteva tre o quattro volte; era un caposaldo della sua esistenza. Molti penseranno che otto ore di lavoro non siano troppe, e perciò si può ben dire che Sunee non aveva di che lamentarsi, che il suo bisogno di protestare, e dunque di avvelenare la beata amnesia che apparentemente andava cercando, merita disprezzo. In fondo il precetto vittoriano della quieta rinuncia resta il rimedio più venduto nella nostra farmacopea per le aspettative dei poveri. Ma Sunee, chissà perché, non riusciva a tacere. Ogni volta che tornava sull’argomento lavoro, cosa che faceva spesso come un mastino all’attacco strattonato indietro dal contraccolpo della catena, si metteva a schiaffeggiare l’aria, la voce sempre più roca e stridula. Odiava così tanto il suo capo; odiava così tanto l’impresa di pulizie. – Uguale a estorsione!, esclamava di continuo.
T...