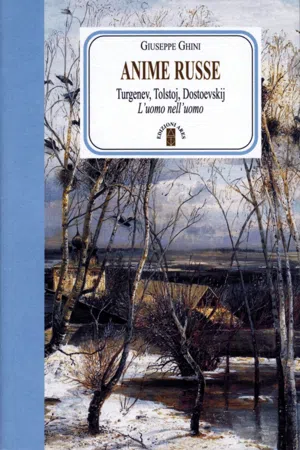
- Italian
- ePUB (disponibile su mobile)
- Disponibile su iOS e Android
eBook - ePub
Anime russe. Turgenev, Tolstoj, Dostoevskij
Informazioni su questo libro
Se in generale la grande letteratura è non solo una lavagna su cui riprodurre creativamente la realtà ma uno strumento per indagarla e comprenderla, Turgenev, Tolstoj e Dostoevskij misero decisamente al centro delle loro opere personaggi di grande complessità e umanità, dando un contributo decisivo allo studio dell'Io. Lo fecero ognuno a suo modo, elaborando un personaggio-persona che anticipa le successive scoperte delle discipline dell'uomo, ma evitando le secche in cui queste cadono allorché muovono da un'antropologia parziale, riduttiva. I tre romanzieri si mossero così verso il recupero di un'antropologia tripartita dove, accanto alla sfera fisica e a quella psichica, emerge una sfera spirituale che consente l'inabitazione del divino nell'uomo. Solo l'esistenza di questa regione spirituale permette all'uomo di scegliere liberamente, di decidere responsabilmente sottraendosi ai condizionamenti dell'ambiente. Solo questa dimensione spirituale puù spiegare il centro trascendente del personaggio, qualcosa che è nel personaggio ma che contemporaneamente lo supera. Lo supera dando vita a un amore benevolente, un amore che non nasce dall'uomo, ma che l'uomo può testimoniare ai suoi simili, restaurando la loro esistenza oltraggiata.
Domande frequenti
Sì, puoi annullare l'abbonamento in qualsiasi momento dalla sezione Abbonamento nelle impostazioni del tuo account sul sito web di Perlego. L'abbonamento rimarrà attivo fino alla fine del periodo di fatturazione in corso. Scopri come annullare l'abbonamento.
No, i libri non possono essere scaricati come file esterni, ad esempio in formato PDF, per essere utilizzati al di fuori di Perlego. Tuttavia, puoi scaricarli nell'app Perlego per leggerli offline su smartphone o tablet. Per maggiori informazioni, clicca qui.
Perlego offre due piani: Essential e Complete
- Essential è l'ideale per studenti e professionisti che amano esplorare un'ampia gamma di argomenti. Accedi alla libreria Essential, che include oltre 800.000 titoli di comprovata qualità e bestseller in vari settori, tra cui business, crescita personale e discipline umanistiche. Include tempo di lettura illimitato e voce standard per la sintesi vocale.
- Complete: perfetto per studenti e ricercatori esperti che necessitano di un accesso completo e illimitato. Accedi a oltre 1,4 milioni di libri su centinaia di argomenti, inclusi titoli accademici e specialistici. Il piano Complete include anche funzionalità avanzate come la sintesi vocale premium e l'assistente di ricerca.
Perlego è un servizio di abbonamento a testi accademici, che ti permette di accedere a un'intera libreria online a un prezzo inferiore rispetto a quello che pagheresti per acquistare un singolo libro al mese. Con oltre 1 milione di testi suddivisi in più di 1.000 categorie, troverai sicuramente ciò che fa per te! Per maggiori informazioni, clicca qui.
Cerca l'icona Sintesi vocale nel prossimo libro che leggerai per verificare se è possibile riprodurre l'audio. Questo strumento permette di leggere il testo a voce alta, evidenziandolo man mano che la lettura procede. Puoi aumentare o diminuire la velocità della sintesi vocale, oppure sospendere la riproduzione. Per maggiori informazioni, clicca qui.
Sì! Puoi utilizzare l'app di Perlego su dispositivi iOS o Android per leggere quando e dove vuoi, anche offline. È perfetta per gli spostamenti quotidiani o quando sei in viaggio.
I dispositivi con iOS 13 e Android 7 o versioni precedenti non sono supportati. Scopri di più su come utilizzare l'app.
I dispositivi con iOS 13 e Android 7 o versioni precedenti non sono supportati. Scopri di più su come utilizzare l'app.
Sì, puoi accedere a Anime russe. Turgenev, Tolstoj, Dostoevskij di Giuseppe Ghini in formato PDF e/o ePub, così come ad altri libri molto apprezzati nelle sezioni relative a Letteratura e Critica letteraria europea. Scopri oltre 1 milione di libri disponibili nel nostro catalogo.
Informazioni
Argomento
LetteraturaCategoria
Critica letteraria europeaTOLSTOJ
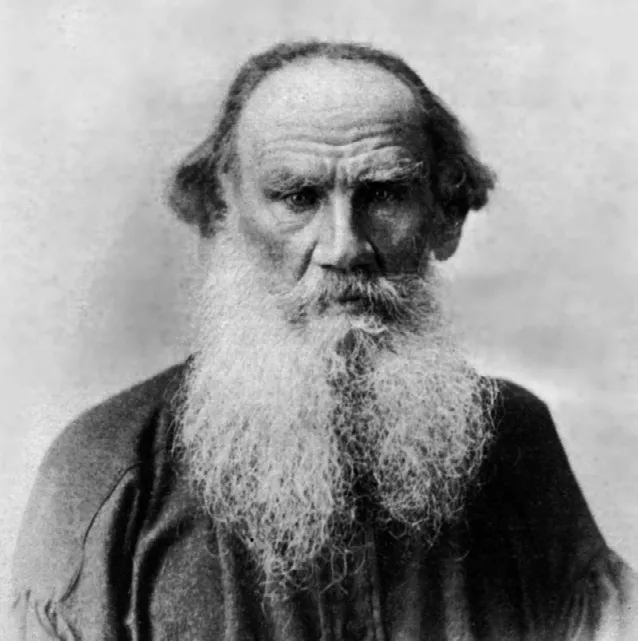
Capitolo 9
La colpa del giocatore
Pur analoghi per mole, alcuni romanzi russi – ad esempio quelli di Dostoevskij – sviluppano dettagliatamente una vicenda che dura pochi, pochissimi giorni, altri – quelli di Tolstoj – sono «romanzi di lunga durata», per rubare un termine a F. Braudel: la vicenda di Guerra e pace spazia dal 1805 al 1820, quella di Anna Karenina dal 1873 al 1876. Il lettore segue la vita dei personaggi nel corso di anni: Nataša fa in tempo a fidanzarsi con il principe Andrej, innamorarsi di Anatole, tentare di suicidarsi, rompere con Andrej, assisterlo morente, litigare e rappacificarsi con la sua famiglia, attendere che Pierre rimanga vedovo, sposarlo e dargli quattro figli. Questo comporta di necessità che i personaggi cambino, si trasformino, che nella Nataša dell’Epilogo, «più piena e più larga, [...] sarebbe stato difficile riconoscere [...] la sottile, agile Nataša di un tempo» (T GP: 964). Non si tratta, però, solo di questo. Come abbiamo già accennato a proposito della crisi dei personaggi di Turgenev, i recenti studi sulla sceneggiatura costringono i critici letterari a riconsiderare la centralità del cambiamento dell’eroe del romanzo. Ecco cosa scrive Dara Marks nel suo Arco di trasformazione del personaggio:
Perché una storia sia interessante dal punto di vista drammatico e forte dal punto di vista tematico, il protagonista deve essere vicino al punto di combustione interna, là dove un conflitto nella sua vita esteriore richiede una trasformazione interiore necessaria per la sopravvivenza. [...] Il cambiamento è necessario per la crescita, è un requisito obbligatorio per la vita; se qualche cosa non cresce e non evolve può solo essere destinata al decadimento e alla morte; non esiste una condizione di stasi in natura. Nulla raggiunge una posizione permanente in cui non sia in gioco né la crescita né la regressione»1.
Anche i personaggi di Tolstoj affrontano questo passaggio obbligatorio per la loro sopravvivenza, mutano, cambiano interiormente, ed è assolutamente necessario che noi esaminiamo più da vicino questo snodo della loro vicenda.
Nikolaj Rostov, il fratello della contessina Nataša, entra prepotentemente in scena nei capitoli XV e XVI della I parte del II tomo di Guerra e pace. Com’è stato notato2, è questa un’entrata importante, perché è proprio in queste pagine che il giovane ussaro diventa partecipe di quella pienezza di vita che nel romanzo è propria della sua famiglia. Il fatto singolare è che l’entrata nel centro vitale del «mondo dei Rostov» avviene attraverso un avvenimento sventurato, la perdita al gioco di ben 43 mila rubli, una cifra capace di rovinare definitivamente le già dissestate finanze familiari. Ho menzionato il mondo dei Rostov, il nido caldo e felice che costituisce l’anima stessa dell’universo creato da Tolstoj; è questo il mondo di una nobile famiglia moscovita che ha mantenuto un vivo contatto con la natura e con il popolo russo, trascorre parte dell’anno nell’usad’ba di campagna (la villa padronale in cui coesistono padroni e domestici), partecipa collettivamente alla caccia e alle feste tradizionali. Il mondo dei Rostov è uno di quei «ritratti di certi stati psichici generali che trascendono i limiti della coscienza individuale e uniscono gli uomini in un’esperienza di vita condivisa», che Lidija Ginzburg considera «le espressioni più alte del genio di Tolstoj» (1994: 309).
Non è difficile individuare qui i tratti di un chiaro dualismo che attraversa l’intero romanzo: è quel dualismo che oppone miticamente la città alla campagna, San Pietroburgo a Mosca e provincia, i salotti della capitale amministrativa alle rustiche abitazioni della campagna russa, i raffinati e vuoti invitati che discettano in francese di politica internazionale al servo-contadino capace di afferrare per le orecchie un lupo vivo, la scuola di ballo del maestro Jogel col suo affettato pas de châle alla danza popolare ballata «istintivamente» dalla contessina che partecipa dell’intatta «anima russa». In questa sequenza di opposizioni, la famiglia Rostov si colloca proprio nel centro della seconda serie.
Ora, tra tutti i membri della famiglia Rostov, Nikolaj è quello più tiepido, almeno fino alla perdita al gioco. Il ritorno a casa, infatti, coincide con la sua personale scoperta del mondo dei Rostov: è proprio la distanza, l’estraneità dovuta alla peculiare situazione psicologica che gli permette infine di cogliere la ricchezza del nido in cui è sempre vissuto in modo piuttosto apatico3. La sventura che ha espulso un tiepido Nikolaj dal mondo dei Rostov, permette tuttavia ad un Nikolaj più maturo di rientrarvi. I critici della scuola formalista, Šklovskij in primo luogo, hanno definito questo cogliere e rappresentare di bel nuovo una realtà percepita in modo ormai automatizzato con il termine «straniamento». Si tratta a un tempo di un procedimento letterario e di una percezione psicologica, e Tolstoj fonde indissolubilmente queste due dimensioni.
Dunque, rientrato «nel felice quadro familiare» col cuore pesante per la stupida perdita al gioco, Nikolaj sente la voce della sorella che canta una barcarola: «E a un tratto tutto il mondo si concentrò per lui nella attesa della nota seguente, della frase seguente, e tutto nel mondo si divise per lui in tre tempi: “Oh, mio crudele affetto!... Uno, due, tre... uno, due... tre... uno... Oh, mio crudele affetto! Uno, due, tre... uno. Eh, che vita stramba la nostra!” – pensava Nikolaj» (T GP: 298). La partecipazione di Nikolaj all’incantevole vita dei Rostov avviene attraverso una vera e propria estasi musicale. Nikolaj non solo attende la nota dalla voce educata eppur non ancora impostata di Nataša, ma, senza accorgersene, emette lui stesso quella nota, sostenendo il canto della sorella e unendosi a lei: esce da se stesso, trascende i propri guai e fonde la propria voce con la voce della sorella, entrando così in un mondo di grazia e di pienezza.
Ora, come dicevamo seguendo l’interpretazione di Sergej Bočarov, vita stramba ed estasi musicale non solo coesistono in questo snodo della personalità di Nikolaj, ma è proprio attraverso la crisi che il giovane ussaro prende coscienza di quanto la vita della sua famiglia vi sia d’incantevole. Anzi, è l’intero romanzo che è costruito sulle crisi: crisi familiari – la fine del primo matrimonio del principe Andrej, la successiva rottura del fidanzamento tra questi e Nataša, la crisi del matrimonio di Pierre, che si risolvono in un nuovo rapporto più autentico, cioè nel matrimonio di Nataša e Pierre; crisi nazionali – la crisi della nazione russa che, dopo le disfatte subite dall’esercito quando era una forza di occupazione, emerge invece come forza invincibile quando popolo ed esercito insieme si schierano a difesa della madre patria. Dallo «sfacelo delle precedenti condizioni di vita» – è la definizione con cui Tolstoj descrisse la situazione dei suoi personaggi nel 1812 (Ibid.: 721) – emergono nuovi rapporti più autentici e una nuova percezione di sé. Nella guerra si forgia la pace così come l’intendeva Tolstoj: valori autentici, giovinezza, salute, poesia della musica e dell’arte, solidarietà umana, armonia di relazioni gioiose. Dalla crisi del personaggio, anzi nella crisi del personaggio emerge il valore autentico.
In Nikolaj, e più in generale nel personaggio di Tolstoj, non c’è solo alternanza di sentimenti, ma combinazione di sentimenti diversi, a volte opposti4. Nikolaj è in preda all’angoscia, ma questo non gli impedisce di scoprire il mondo incantevole dei Rostov; Nataša ama di un amore sincero il serioso principe Andrej, ma questo non costituisce una corazza contro le avances del vacuo Anatole, di cui giunge ad innamorarsi; il giovane Nikolen’ka Irten’ev, protagonista della trilogia Infanzia, Adolescenza, Giovinezza (Detstvo, Otročestvo, Junost’, 1852-7) piange sopraffatto dal dolore sulla tomba della madre, e contemporaneamente si preoccupa dell’impressione che produce sugli astanti. Tolstoj riprende qui le acute osservazioni di uno dei filosofi più amati, Montaigne, sulla «mutevolezza dell’animo umano», e supera decisamente tanto la semplicistica fissità dei caratteri dei personaggi classici sempre uguali a se stessi, quanto l’enigma inspiegabile dell’eroe romantico. La mutevolezza degli stati d’animo si combina pertanto in Tolstoj con la personalità del personaggio. È la personalità che conferisce unità e stabilità al personaggio-persona nel cui animo compaiono sentimenti anche contrapposti. Pertanto, all’origine del suo comportamento non sempre coerente c’è la selezione e l’attivazione di alcuni elementi della coscienza, e la rimozione o la repressione di altri.
Come abbiamo già anticipato, nel suo scavo della psiche del personaggio, Tolstoj è tra i primi scrittori a mettere in luce questa dinamica di rimozione e repressione. Nel capitolo di Guerra e pace che stiamo considerando, ne abbiamo un’efficace esemplificazione. «Nataša, con la sua sensibilità, aveva notato sull’istante lo stato del fratello», scrive Tolstoj. «L’aveva notato, ma si sentiva così gaia in quel momento, così lontana da ciò che era dolore, tristezza, rimprovero, che di proposito, come spesso accade ai giovani, volle ingannare se stessa (naročno obmanula sebja). “No, ora sono troppo allegra per guastare la mia gioia con la compassione per il dolore altrui”, così sentì e si disse. “No, sbaglio di sicuro: egli dev’essere allegro al pari di me”» (Ibid.: 297).
Nella sua egoistica felicità, Nataša si sforza consciamente di ingannare se stessa (repressione: «No, ora sono troppo allegra per guastare la mia gioia con la compassione per il dolore altrui»), ed il suo convincimento penetra tanto profondamente dentro di lei da darle la certezza inconscia che anche il fratello è allegro come lei (rimozione: «No, sbaglio di sicuro: egli dev’essere allegro al pari di me»). In questa rappresentazione dei sentimenti interiori, consci e inconsci, Tolstoj è davvero insuperabile. Non solo li rappresenta in modo convincente, ma strappa al lettore la considerazione che sì, è davvero così, che anche a lui è capitato, che lui stesso può confermare l’analisi del romanziere russo. La generalizzazione che qui Tolstoj opera – «come spesso accade ai giovani» – viene così percepita dal lettore come una conferma della validità della rappresentazione psicologica del personaggio.
Il capitolo XVI, di seguito riportato estesamente, riconduce il nostro Nikolaj dal terzo cielo dei Rostov, dall’estasi musicale alla dura realtà della sua perdita al gioco. Esso ci consente di vedere più da vicino il carattere del nostro personaggio, soprattutto il suo atteggiamento nei confronti della propria colpa. La crisi accennata nel capitolo XV viene qui sviluppata nella coscienza del personaggio; ci avviciniamo a quel punto di combustione, dove un conflitto nella sua vita esteriore richiede necessariamente una trasformazione interiore.
Nikolaj, udito che era giunto [il padre], andò da lui.
– Ebbene, ti sei divertito? – disse Il’ja Andreič, sorridendo al figlio con gioia e con orgoglio. Nikolaj voleva dir «sì», ma non poté: per poco non si mise a singhiozzare. Il conte stava accendendo la pipa e non notò lo stato del figlio.
«Eh, è inevitabile!», pensò Nikolaj per la prima e ultima volta. E a un tratto col tono più noncurante, come se avesse chiesto la carrozza per fare una scappata in città, tanto che egli stesso si sentì ignobile, disse al padre:
– Papà, son venuto da voi per un affare. Stavo per dimenticarmene. Ho bisogno di denaro.
– Guarda un po’ – disse il padre, che si trovava di umore particolarmente gaio. – Te lo dicevo io che non sarebbe bastato. Molto?
– Moltissimo – rispose Nikolaj arrossendo e con uno sciocco e negligente sorriso, che poi per lungo tempo non si poté perdonare. – Ho perduto un poco, cioè molto, anzi moltissimo, quarantatremila rubli.
– Che cosa? Con chi?... Scherzi – gridò il conte, diventando a un tratto apopletticamente rosso sul collo e sulla nuca, come diventano i vecchi.
– Ho promesso di pagare domani – disse Nikolaj.
– E via!... – rispose il vecchio conte allargando le braccia, e si abbandonò senza forza sul divano.
– Che farci! A chi non è mai accaduto questo? – disse il figlio con un tono disinvolto e ardito, mentre nell’anima sua si stimava un farabutto, un vile che con una vita intera non avrebbe potuto riscattare il suo delitto. Avrebbe voluto baciar le mani a suo padre, chiedergli perdono in ginocchio, e invece aveva detto con un tono negligente e perfino ruvido che ciò accadeva a tutti.
Il conte Il’ja Andreič abbassò gli occhi, udendo queste parole del figlio, e si mise in fretta a cercare qualcosa.
– Sì, sì – proferì – è difficile, temo che sia difficile procurarsi... a chi non è accaduto? sì, a chi non è accaduto... – E il conte gettò di sfuggita uno sguardo al viso del figlio e andò via dalla stanza... Nikolaj si era preparato a una resistenza, ma in nessuna maniera si aspettava questo.
– Papà! pa...pà! – gli gridò dietro singhiozzando – perdonatemi! – E afferrata la mano del padre, vi premé sopra le labbra e si mise a piangere.
[...] Rostov, aspettando il denaro che il vecchio conte non poté subito mettere insieme, passò ancora due settimane a Mosca, senza uscir di casa, e di preferenza nella stanza delle signorine.
Sonja era con lui più tenera e più devota di prima. Pareva volesse fargli vedere che la sua perdita era stata un atto eroico, per il quale ella l’amava ora anche di più; ma Nikolaj adesso si stimava indegno di lei.
Egli riempì gli albi delle fanciulle di versi e di musica e, senza essersi accomiatato da alcuno dei suoi conoscenti, dopo avere infine mandato tutti i quarantatremila rubli a Dolochov e da lui ricevuto quietanza, partì alla fine di novembre per raggiungere il reggimento, che era già in Polonia. (Ibid.: 298-300)
All’atto dell’arrivo del vecchio conte, Nikolaj decide di non por tempo in mezzo e lo affronta. Si turba all’ingenua domanda del padre («E allora, ti sei divertito?»), si convince di non poter evitare il confronto e con un tono indifferente che lo fa apparire ignobile a se stesso gli rivela che ha perduto al gioco 43 mila rubli. Il giovane ussaro sembrerebbe aver superato di slancio le remore che gli impedivano di confessare al padre la colpa, ma non è così. Come ritornando psicologicamente sui suoi passi, Nikolaj tenta un’ultima difesa di fronte a se stesso: «Che farci? A chi non è mai accaduto questo?», afferma, con una fuga dalla responsabilità in direzione del «mal comune, mezzo gaudio». Una fuga, peraltro, che lo stesso Nikolaj giudica come una vigliaccheria («disse il figlio con un tono disinvolto e ardito, mentre mentre nell’anima sua si stimava un farabutto»), esattamente come prima aveva riconosciuto quanto fosse ignobile il tono con cui si rivolgeva al padre.
Notiamo che le due azioni – il parlare con il padre e il giudicare il modo in cui sta parlando – sono contemporanee, ennesima dimostrazione della coscienza a più strati del personaggio tolstoiano. E notiamo ancora che, in questa ammissione di colpa, Nikolaj si riconosce contemporaneamente malfattore ed espiatore, colpevole e salvatore: «nell’anima sua si stimava un farabutto, un vile che con una vita intera non avrebbe potuto riscattare [iskupit’] il suo delitto». Аll’epoca in cui Tolstoj scriveva, il verbo iskupit’ possedeva il significato di «riscattare, redimere attivamente» oltre a quello di «espiare passivamente», come testimonia il romanziere stesso, oltre al grande lessicologo Vladimir Dal’5: è il riscatto come «ricevere in cambio di una cifra», che lascia intravedere il legame di iz-kupit’ (espiare) con il verbo kupit’ (comprare). Ancor più che in italiano, dunque, il termine rinvia al riscatto attivo di una colpa piuttosto che all’espiazione passiva, subita, e bene ha fatto il traduttore italiano a rendere appunto con «riscattare». D’altronde, che si tratti di un riscatto attivo lo conferma il fatto che nell’argomentazione di Nikolaj non compare nessun altro attore di questa espiazione, nessuno che abbia compiuto una espiazione vicaria di cui lui possa beneficiare. Il protagonista della futura espia...
Indice dei contenuti
- Copertina
- Introduzione
- PERSONAGGI
- TURGENEV
- TOLSTOJ
- DOSTOEVSKIJ
- Conclusione
- Note
- Indice dei personaggi delle opere di Turgenev, Tolstoj e Dostoevskij
- Indice dei nomi
- Bibliografia