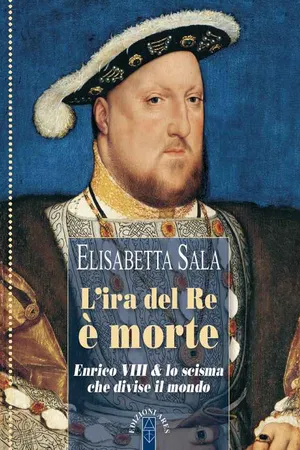
- 256 pagine
- Italian
- ePUB (disponibile su mobile)
- Disponibile su iOS e Android
eBook - ePub
Informazioni su questo libro
Nel secolo che vide frantumarsi l'unità religiosa d'Europa, il capriccio e la determinazione di un sovrano furono sufficienti, in un rapido volo d'anni, a sganciare l'Inghilterra dal suo passato e dalla sua fede secolare.
I molteplici quadri di questo dramma sono riproposti dall'autrice con una narrazione limpida e partecipata, che delinea con precisione un'epoca di intrighi e nobiltà, di luce e sangue. Di fronte alle spettrale imponenza di Enrico si succedono figure di uomini cinici e di persecutori (Thomas Cromwell e Thomas Cranmer ne furono esempi tra i tanti), così come di martiri e santi, tra cui primeggiano i nomi di Thomas More, Cancelliere del re stesso, e dell'indomito cardinale John Fisher.
Questa nuova indagine su Enrico VIII esamina gli sconvolgimenti che l'Inghilterra, impoverita e insanguinata nonché percorsa da inquietudini sociali, dovette d'improvviso affrontare, soffermandosi in particolare sul periodo del «terrore enriciano», troppo spesso silenziato dalla storiografia.
Nel riproporre la cronistoria dello scisma anglicano, l'autrice cerca di rispondere a quesiti tuttora aperti: «Davvero Enrico, oltre a voler risolvere le sue questioni matrimoniali, assecondò il desiderio d'indipendenza religiosa dei suoi sudditi? Quale fu, in realtà, l'impatto sul popolo? E quale il ruolo della propaganda? Quanti e quali furono perseguitati? Davvero il ripudio del papato creò, a lungo termine, le premesse per la tanto celebrata politica di tolleranza religiosa?».
Sono interrogativi che gettano ombre sull'esaltazione di un momento storico in cui molti ravvisano l'aurora dell'uomo europeo secolarizzato.
Domande frequenti
Sì, puoi annullare l'abbonamento in qualsiasi momento dalla sezione Abbonamento nelle impostazioni del tuo account sul sito web di Perlego. L'abbonamento rimarrà attivo fino alla fine del periodo di fatturazione in corso. Scopri come annullare l'abbonamento.
No, i libri non possono essere scaricati come file esterni, ad esempio in formato PDF, per essere utilizzati al di fuori di Perlego. Tuttavia, puoi scaricarli nell'app Perlego per leggerli offline su smartphone o tablet. Per maggiori informazioni, clicca qui.
Perlego offre due piani: Essential e Complete
- Essential è l'ideale per studenti e professionisti che amano esplorare un'ampia gamma di argomenti. Accedi alla libreria Essential, che include oltre 800.000 titoli di comprovata qualità e bestseller in vari settori, tra cui business, crescita personale e discipline umanistiche. Include tempo di lettura illimitato e voce standard per la sintesi vocale.
- Complete: perfetto per studenti e ricercatori esperti che necessitano di un accesso completo e illimitato. Accedi a oltre 1,4 milioni di libri su centinaia di argomenti, inclusi titoli accademici e specialistici. Il piano Complete include anche funzionalità avanzate come la sintesi vocale premium e l'assistente di ricerca.
Perlego è un servizio di abbonamento a testi accademici, che ti permette di accedere a un'intera libreria online a un prezzo inferiore rispetto a quello che pagheresti per acquistare un singolo libro al mese. Con oltre 1 milione di testi suddivisi in più di 1.000 categorie, troverai sicuramente ciò che fa per te! Per maggiori informazioni, clicca qui.
Cerca l'icona Sintesi vocale nel prossimo libro che leggerai per verificare se è possibile riprodurre l'audio. Questo strumento permette di leggere il testo a voce alta, evidenziandolo man mano che la lettura procede. Puoi aumentare o diminuire la velocità della sintesi vocale, oppure sospendere la riproduzione. Per maggiori informazioni, clicca qui.
Sì! Puoi utilizzare l'app di Perlego su dispositivi iOS o Android per leggere quando e dove vuoi, anche offline. È perfetta per gli spostamenti quotidiani o quando sei in viaggio.
I dispositivi con iOS 13 e Android 7 o versioni precedenti non sono supportati. Scopri di più su come utilizzare l'app.
I dispositivi con iOS 13 e Android 7 o versioni precedenti non sono supportati. Scopri di più su come utilizzare l'app.
Sì, puoi accedere a L'ira del re è morte di Elisabetta Sala in formato PDF e/o ePub, così come ad altri libri molto apprezzati nelle sezioni relative a Storia e Storia britannica. Scopri oltre 1 milione di libri disponibili nel nostro catalogo.
Informazioni
1. Re Enrico
Anno del Signore 1509. The King is dead. Long live the King3. Precisiamo che il «lunga vita» non è una presa in giro al morto, né si tratta di un riferimento alla vita eterna: è al nuovo re che è augurata lunga vita. Il nuovo re in questione succedette al padre Enrico VII e venne proclamato, per triste paradosso, proprio il 23 aprile, san Giorgio, patrono d’Inghilterra. Pochi altri re nella storia furono acclamati con tanta gioia, pochissimi suscitarono nei loro sudditi tante aspettative di pace, prosperità, trionfo della cultura e dell’arte.
Per dirla con un noto studioso, oggi per noi è difficile capire quanto gloriose fossero le aspettative, negli anni che aprirono il regno di Enrico VIII, e quanto altrettanto completa fu la delusione nell’assistere alla deliberata frustrazione di tutte le speranze4.
Il re padre, Enrico VII Tudor, proveniva da un casato dalla nobiltà non eccelsa; era riuscito ad assicurarsi il trono strappandolo in battaglia a Riccardo III, ponendo così fine alle famose guerre (civili) delle Due rose che, tra una schermaglia e l’altra, si trascinavano da trent’anni. Non era nobilissimo, dunque, Enrico il vecchio, ma era molto determinato e, soprattutto, aveva sfruttato un momento in cui le grandi famiglie legate alle due case di Lancaster e York si erano quasi completamente sterminate a vicenda: tra i due litiganti…
Soprattutto in quanto dinastia nuova, i Tudor avevano bisogno di sentire il trono ben saldo, al sicuro da ogni altro eventuale pretendente: Enrico VII procedette dunque ad allontanare il più possibile dalla corte i (pochi) nobili rimasti, affidando cariche importanti a gente di umile origine, tra cui non pochi chierici. Non mancò di servirsi, naturalmente, di un pugno di ferro e di una forte propaganda, il tutto accompagnato da un nodo ermetico ai cordoni della borsa, ché dopo una guerra civile, si sa, il Paese è in ginocchio e c’è bisogno di un po’ di pace.
Il figlio no, il figlio era diverso: abituato al lusso fin da bambino, non aveva certo intenzione di moderare il suo tenore di vita. Anzi. Era contentissimo del gruzzolo lasciatogli da papà e non vedeva l’ora di spenderlo. Tanto più che, da secondogenito, inizialmente non era neppure destinato a salire al trono, bensì, pare, a diventare arcivescovo di Canterbury, la massima carica ecclesiastica d’Inghilterra (alla faccia della lotta per le investiture). Il trono se lo sarebbe accaparrato suo fratello maggiore Arthur. Ma Arthur morì a quindici anni ed Enrico, alla fine, divenne re.
Egli ereditava una fortuna quale nessun altro re inglese aveva mai neppure sognato e, secondo Scarisbrick, l’Inghilterra era allora lo Stato meglio governato e meno incline alla rivolta dell’intera Cristianità5.
Ciò che colpiva all’istante il visitatore straniero, oltre all’opulenza della capitale, era la bellezza di quel Paese verdeggiante, letteralmente costellato di tesori d’arte, soprattutto chiese e monasteri6. E una cattedrale, naturalmente, non era soltanto un prodigio architettonico: oltre a essere spesso ricoperta di affreschi, essa ospitava innumerevoli statue, in pietra o in legno dipinto, splendide vetrate, arredi ecclesiastici di pregio e beni artistici di ogni tipo (si pensi alla sola argenteria) dal valore incalcolabile; per non parlare delle ricchissime biblioteche monastiche che di quel patrimonio erano parte integrante.
L’umanista Thomas More, che, da giovane parlamentare, aveva avuto qualche problemino con Enrico VII perché troppo libero nell’esprimersi, esaltò ora il nuovo sovrano in un poemetto: era la fine della tirannia, era l’inizio di un periodo di pace, gioia e cultura, perché il nuovo re amava la filosofia e le nove muse. Il parere di More era condiviso da molti altri giovani studiosi.
Ed era vero. All’inizio, almeno. Enrico VIII sembrava un vero princeps rinascimentale: era alto, bello, atletico, versato in tutti gli sport, abilissimo cavaliere e schermidore. Aggiungeva all’accettabile cultura, certo considerevole per un sovrano, una certa competenza in teologia e, soprattutto, era un ottimo musicista (si dice, tra l’altro, che anche la popolare canzone Greensleeves sia sua). La regina che si era scelto, Caterina d’Aragona, non era certo da meno: donna di altissima statura morale, e non meno colta del marito, ella divenne presto un punto di riferimento per diversi umanisti, tra i quali spicca lo spagnolo Vivés. Anche il re, sebbene mancasse di riconoscere in Erasmo da Rotterdam un genio da incoraggiare, promosse una notevole rinascita culturale: il grande pittore Holbein il giovane lavorò a lungo a Corte e la poesia rinascimentale nacque proprio in questo àmbito, intorno al re, con Wyatt e Surrey che introdussero il sonetto petrarchesco importandolo direttamente dall’Italia, mentre i consigli ai prìncipi contenuti in Utopia erano ovviamente indirizzati a lui. Ciò che cortigiani e umanisti non potevano immaginare era che, nel giro di pochi anni, Enrico sarebbe passato alla distruzione, violenta e deliberata, del maggior numero di capolavori artistici, nonché di tutte le menti promettenti in campo filosofico e letterario, mai operata in Europa prima del Novecento. Oltre a cancellare il 90% del patrimonio artistico medievale, infatti (e alcune arti minori scomparvero per sempre), Enrico VIII procedette, con la sua riforma, a ciò che tra gli studiosi è comunemente noto come «l’arresto dell’umanesimo»: Wyatt finì nella Torre e ne uscì spezzato; Surrey ci rimise la testa. Nessuno dei due vide la pubblicazione delle proprie opere, per la quale si dovette attendere almeno dieci anni dopo la morte del re. Altri ricchi protettori di artisti e di centri universitari, tra cui il cardinal Wolsey, caddero in disgrazia e diversi umanisti, tra cui Erasmo stesso, preferirono lasciare l’Inghilterra per sempre. Vivés fu imprigionato e in seguito espulso dal regno, mentre i personaggi più colti del Paese, vale a dire Thomas More, John Fisher e il monaco Richard Reynolds, furono pubblicamente giustiziati in quanto colpevoli di alto tradimento (e, tra questi, Reynolds fu squartato vivo). La rinascita artistica e letteraria venne inabissata per almeno altri quarant’anni7.
I nostri libri di testo, però, non ne parlano. I nostri libri di testo passano con compiacente disinvoltura dagli sventurati pionieri del Rinascimento del periodo enriciano agli illustri artisti elisabettiani che seguirono di una o due generazioni, buttandoli tutti nello stesso calderone.
2. Caterina d’Aragona
Di lei, di solito, si sa pochissimo. Tra i numerosi ritratti che rivendicano il suo volto pare che due soltanto la rappresentino al di là di ogni dubbio: nel primo ella è una ragazza su per giù sedicenne; nell’altro è una dama di mezza età8. Le due immagini sono tra loro tanto dissimili da farle sembrare due persone diverse. Nei libri di storia Caterina è solitamente una figura statica, piatta, un’immagine da quadro, appunto, senza consistenza e senza carattere; una moglie certamente innocente ma noiosa, ingrassata e imbruttita dalle continue gravidanze; una sposa messa da parte, una pedina contesa tra re e imperatore, una regina quasi sterile, dunque inutile. Un fallimento di donna. Ma sarà stato proprio così?
Ultimogenita di Ferdinando d’Aragona e Isabella di Castiglia, Caterina nacque alla fine del 1485. Dalla madre ereditò una fede incrollabile, un grande senso del dovere e una volontà di ferro. Ricevette una cultura inaudita, a quel tempo, per una donna. Oltre ad assicurare a tutti i suoi figli i precettori di prim’ordine che lei non aveva potuto avere, infatti, la regina Isabella aveva introdotto l’umanesimo in Spagna e fu grazie a lei che, tra i cultori dell’umanesimo, numerose furono le donne, più che in ogni altro Paese9. Molti umanisti ebbero incarichi a Corte e diversi di loro furono pedagoghi dei fanciulli reali. Uno dei precettori di Caterina fu il noto studioso ed ecclesiastico italiano Alessandro Geraldini.
Caterina e le sue sorelle (l’unico fratello, Juan, morì appena sposato e senza eredi) sapevano – avevano sempre saputo – che un giorno, per il bene della Spagna e della loro famiglia, avrebbero lasciato per sempre il loro Paese e sarebbero andate in spose ai più grandi prìncipi europei, suggellando con il loro sangue patti di alleanza «perpetua» ed entrando a far parte dei principali giochi dinastici che tenevano in pugno tutto il mondo allora conosciuto. Juana, in seguito tristemente nota come Giovanna la Pazza, andò in sposa a Filippo il Bello, figlio del sacro romano imperatore Massimiliano I d’Asburgo e arciduca di Borgogna, mentre Isabella e Maria sposarono in successione Emanuel, re del Portogallo. Caterina fu destinata fin da piccolissima al trono inglese e fidanzata al principe di Galles, Arthur, primogenito di Enrico VII.
Quando, quindicenne, ella sbarcò a Plymouth con il suo splendido seguito, quasi una piccola corte, gli inglesi la accolsero festanti e le manifestarono da subito un attaccamento che perdurò nella sventura. La futura regina non era una qualsiasi principessa straniera: il suo sangue nobilissimo includeva in alta percentuale quello del più grande re inglese che la tradizione ricordasse, Edoardo III, dal cui figlio, John of Gaunt, Isabella di Castiglia discendeva sia in linea materna, sia in linea paterna.
Anche Enrico VII era un discendente di John of Gaunt, sebbene (ma non si poteva dir forte) attraverso un figlio illegittimo. Era un po’ come se il sangue di Edoardo III tornasse finalmente a casa. E sappiamo tutti quanto gli inglesi, ancora oggi, tengano a queste cose.
Il 14 novembre 1501 vennero celebrate le nozze; e in grande sfarzo, nonostante la proverbiale avarizia del re. Per Enrico VII si trattò di una buona opportunità di propaganda per la sua dinastia. In quell’occasione, probabilmente, Caterina ebbe modo di conoscere il fratellino del suo sposo, il principino Enrico, un bel bambinone biondo di dieci anni che si muoveva a Corte con perfetto agio e, pare, era già più alto e robusto del gracile quattordicenne Arthur. Subito dopo le feste, i banchetti e i tornei cavallereschi di rito, i giovani sposi partirono per il Galles, dove la presenza dell’erede al trono (nelle cui vene, grazie al nonno paterno e ai suoi antenati, scorreva sangue gallese) serviva a tenere buoni i nobili di quelle parti, notoriamente bellicosi. Il problema fu che, nel giro di pochi mesi, Arthur morì improvvisamente. Tra le tante ipotesi, tra i tanti flagelli letali dell’epoca, il più probabile è quel male inesorabile allora chiamato sweating sickness, malattia del sudore, una febbre altissima – e contagiosa – che uccideva il primo giorno. Se si superava la prima crisi, in genere, si sopravviveva. Anche Caterina si ammalò, ma per sua fortuna (?) ne uscì, sebbene la convalescenza fosse lunga e faticosa.
Caterina e la sua dueña10 giurarono entrambe, molti anni dopo, che quel matrimonio non fu mai consumato, anche quando divenne più conveniente affermare il contrario.
Grande fu la costernazione a Corte per la morte del giovane principe. Al dolore naturale per la perdita di un figlio si aggiungeva un problema dinastico: ora non restava che un unico erede maschio, il che, visto l’indice di mortalità dell’epoca, non era molto. Vero, il ragazzo sembrava terribilmente robusto, ma rimaneva comunque il solo baluardo contro l’eventualità di un’altra guerra civile. Vero anche che il giovane Enrico aveva ancora due sorelle, una maggiore, una minore (l’ultimo fratello, Edmund, era morto da piccolo). Ma, diversamente da quanto accadeva in Castiglia, non era un fatto sicuro che i riottosi nobili inglesi potessero accettare di essere governati da una regina senza batter ciglio: l’unico esempio precedente, molto lontano nel tempo11, non era un bel ricordo per nessuno ed era stato occasione, tanto per cambiare, di guerre civili.
E che fare, ora, per giunta, della principessa spagnola? Si sarebbe potuta dare in sposa al secondogenito, trasferendo così a lui il pacchetto tutto intero: trono, moglie e alleanza con la Spagna. Sì, si sarebbe potuto, se non fosse stato che quel furfante di Ferdinando suo padre non aveva ancora saldato la dote.
Caterina, dal canto suo, non ne volle sapere di tornare in Spagna: sarebbe stato, per lei, come ammettere la sconfitta definitiva della missione per cui era nata. Dopo un paio d’anni di negoziazioni, infine, e dopo un’altra rata da parte di Ferdinando e Isabella, Caterina e il giovanissimo Enrico furono solennemente fidanzati. Poi la questione si fece difficile. Per farla breve, Isabella morì (nel 1504); Ferdinando ed Enrico padre cominciarono a non andare troppo d’accordo e il resto della dote si fece attendere; Enrico cominciò a parlare di un altro matrimonio per suo figlio e, semplicemente, smise di mantenere Caterina e la sua piccola corte. Ma Caterina non rinunciò. La fame, ma non la sconfitta. Piuttosto, fece vendere o impegnare quasi tutti i suoi gioielli e l’argenteria. Piuttosto, mandò in giro le sue damigelle con i vestiti rattoppati o «girati». Ferdinando, dal canto suo, pur incoraggiando la figlia a resistere, continuò a non pagare; ciò nonostante, la fedeltà di Caterina, e la convinzione che il padre fosse sempre in buona fede, per il momento non vennero meno.
Poi il re d’Inghilterra morì e, torniamo al 1509, il giovane Enrico gli succedette. Ancor prima dell’incoronazione egli buttò all’aria i progetti di matrimonio più recenti e volle inaspettatamente sposare la sua promessa, e ormai povera, Caterina. Senza dubbio egli le apparve allora come il suo salvatore. Il giovane Enrico ricorse a una giustificazione piuttosto sbrigativa con i nobili stranieri coinvolti in quei nuovi progetti matrimoniali, adducendo come scusa l’ultima volontà di Enrico VII; ipotesi, questa, piuttosto poco credibile. Quella più probabile, invece, quella che viene sempre scartata parlando di matrimoni tanto altolocati, è che il novello re fosse davvero innamora...
Indice dei contenuti
- Introduzione
- 1. Re Enrico
- 2. Caterina d’Aragona
- 3. Il grande cardinale
- 4. Anna Bolena
- 5. Il «divorzio»
- 6. Un nuovo consigliere
- 7. Lo scisma e il Terrore
- 8. Sfida alla supremazia: san Thomas More
- 9. Sfida alla supremazia: san John Fisher
- 10. Caterina regina
- 11. Fine dei monasteri
- 12. Robert Aske & il Pellegrinaggio di grazia
- 13. Fine del Terrore?
- 14. Come andò a finire
- Tavola cronologica
- Appendice: Le rovine di Walsingham
- L’autore della poesia
- Bibliografia essenziale
- Elenco dei Nomi citati
- Note
- Inserto fotografico