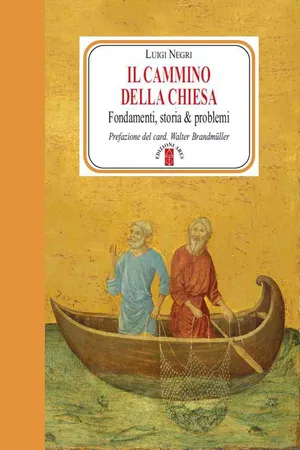
- 320 pagine
- Italian
- ePUB (disponibile su mobile)
- Disponibile su iOS e Android
eBook - ePub
Informazioni su questo libro
«Mons. Luigi Negri con questo nuovo volume offre al pubblico un capolavoro. Mentre non pochi considerano la storia della Chiesa come una mostra di antiquariato, ovvero un gabinetto di curiosità la cui visita promette divertimento, l'arcivescovo di Ferrara ci fa capire che la storia è il retroscena dell'oggi, indispensabile per poter valutare e inquadrare ciò che stiamo vivendo. Questo è un primo elemento caratterizzante del libro: riconoscere l'importanza della storia per capire il presente. Un secondo aspetto è l'ottica con la quale si con sidera la storia della Chiesa. L'autore ci rammenta il fatto che ogni ricerca scientifica necessariamente deve partire dalla natura dell'oggetto della sua ricerca. Mentre il grande numero di quanti scrivono su questi temi considera la Chiesa come una realtà meramente socio-culturale, anzi politica, mons. Negri fa capire la vera natura della Chiesa, nella quale l'elemento umano s'intreccia con quello divino: nella forma di una società umana è presente nella storia il Corpo mistico di Cristo; è chiaro che questa verità può essere riconosciuta soltanto mediante la fede. Ma è anche vero che solo alla luce di questa verità i singoli momenti della storia della Chiesa possono essere interpretati in modo adeguato»
(dalla Prefazione del card Brandmüller).
Domande frequenti
Sì, puoi annullare l'abbonamento in qualsiasi momento dalla sezione Abbonamento nelle impostazioni del tuo account sul sito web di Perlego. L'abbonamento rimarrà attivo fino alla fine del periodo di fatturazione in corso. Scopri come annullare l'abbonamento.
No, i libri non possono essere scaricati come file esterni, ad esempio in formato PDF, per essere utilizzati al di fuori di Perlego. Tuttavia, puoi scaricarli nell'app Perlego per leggerli offline su smartphone o tablet. Per maggiori informazioni, clicca qui.
Perlego offre due piani: Essential e Complete
- Essential è l'ideale per studenti e professionisti che amano esplorare un'ampia gamma di argomenti. Accedi alla libreria Essential, che include oltre 800.000 titoli di comprovata qualità e bestseller in vari settori, tra cui business, crescita personale e discipline umanistiche. Include tempo di lettura illimitato e voce standard per la sintesi vocale.
- Complete: perfetto per studenti e ricercatori esperti che necessitano di un accesso completo e illimitato. Accedi a oltre 1,4 milioni di libri su centinaia di argomenti, inclusi titoli accademici e specialistici. Il piano Complete include anche funzionalità avanzate come la sintesi vocale premium e l'assistente di ricerca.
Perlego è un servizio di abbonamento a testi accademici, che ti permette di accedere a un'intera libreria online a un prezzo inferiore rispetto a quello che pagheresti per acquistare un singolo libro al mese. Con oltre 1 milione di testi suddivisi in più di 1.000 categorie, troverai sicuramente ciò che fa per te! Per maggiori informazioni, clicca qui.
Cerca l'icona Sintesi vocale nel prossimo libro che leggerai per verificare se è possibile riprodurre l'audio. Questo strumento permette di leggere il testo a voce alta, evidenziandolo man mano che la lettura procede. Puoi aumentare o diminuire la velocità della sintesi vocale, oppure sospendere la riproduzione. Per maggiori informazioni, clicca qui.
Sì! Puoi utilizzare l'app di Perlego su dispositivi iOS o Android per leggere quando e dove vuoi, anche offline. È perfetta per gli spostamenti quotidiani o quando sei in viaggio.
I dispositivi con iOS 13 e Android 7 o versioni precedenti non sono supportati. Scopri di più su come utilizzare l'app.
I dispositivi con iOS 13 e Android 7 o versioni precedenti non sono supportati. Scopri di più su come utilizzare l'app.
Sì, puoi accedere a Il cammino della Chiesa di Luigi Negri in formato PDF e/o ePub, così come ad altri libri molto apprezzati nelle sezioni relative a Teologia e religione e Storia del cristianesimo. Scopri oltre 1 milione di libri disponibili nel nostro catalogo.
Informazioni
SECONDA PARTE
DUEMILA ANNI IN BREVE
Capitolo quarto
La Chiesa nell’età antica
L’Età antica: esigenza di verità & di giustizia
L’avvenimento cristiano si afferma per la prima volta nella storia degli uomini in un contesto in cui si fronteggiano, senza incontrarsi, due mondi: il mondo greco-romano, il mondo della cultura, e quello ebraico, il mondo della Rivelazione. Successivamente, un terzo mondo, quello dei cosiddetti popoli barbari, nei primi secoli dell’era cristiana, si impone determinando la fine dell’Impero romano.
Il cristianesimo è entrato in contatto con tutti questi mondi, senza sceglierne uno contro gli altri, nonostante essi fossero stati fino a quel momento antitetici, riuscendo a risultare decisivo per ciascuno di essi. Il cristianesimo ha così dimostrato, fin dall’inizio, di essere un fenomeno capace di dialogo con l’umano, in qualsiasi forma questo si esprima. Nella storia non esiste un’altra realtà che sia stata capace di incontrare gli uomini in situazioni così diverse tra loro.
Il dialogo con la tradizione greco-romana, da una parte, e con la tradizione ebraica, dall’altra, sono all’origine di quello straordinario sviluppo che ha portato al costituirsi della nostra civiltà. Dalle parole di san Paolo si può capire come la Chiesa primitiva fosse pienamente consapevole di questo contesto e delle grandi differenze esistenti: «Mentre i giudei chiedono miracoli e i greci cercano la sapienza, noi predichiamo Cristo Crocifisso, scandalo per i giudei, stoltezza per i pagani; ma per coloro che sono chiamati, sia giudei che greci, predichiamo Cristo, potenza di Dio e sapienza di Dio» (1 Cor 1, 22-24).
«I greci cercano la sapienza». Niente è più vicino al cuore del pensiero greco dell’irresistibile desiderio di verità; niente è sentito e vissuto in maniera più forte della ricerca della verità. La cultura greco-romana chiede la verità, cerca le ragioni del vivere. Questo mondo è sostanzialmente fondato sull’idea che la ragione possa scoprire totalmente la verità dell’essere, la verità delle cose, e su questa verità costruire una società nella quale l’uomo possa esprimersi e realizzarsi. I greci si fidano della ragione, del logos, della loro capacità di analizzare, di penetrare la realtà e, quindi, di conoscere e di perseguire il bene.
Grazie alla ricerca della verità, alla domanda sulla natura di Dio, la filosofia greca sviluppa un’autentica religiosità. Essa permette di capire come la vita dell’uomo sia costituita dalle domande sul significato ultimo dell’esistenza e come una vita senza queste ricerche non sia vissuta veramente da uomo, come dice Socrate nell’Apologia. Diventa chiaro che il problema di Dio riguarda la vita, come scrive Marco Aurelio, imperatore e filosofo stoico: «Sarebbe impossibile far bene qualsiasi cosa interessa agli uomini se non la si rapporta alle cose divine e viceversa». I filosofi nell’antica Grecia vivono una religiosità meno formale di quella delle loro religioni tradizionali. Per questo san Giustino sostiene che il logos greco prepara, per i pagani, la Rivelazione, come l’Antico Testamento prepara il mondo giudaico alla venuta di Cristo: «L’Antico Testamento e la filosofia greca sono come le due strade che guidano a Cristo, al Logos. Ecco perché la filosofia greca non può opporsi alla verità evangelica, e i cristiani possono attingervi con fiducia, come a un bene proprio»14.
«I giudei chiedono miracoli». I giudei, soprattutto i giudei al tempo di Gesù Cristo, vivono la propria religiosità basandola sull’idea di giustizia: la ragione umana, certamente illuminata dall’intervento di Dio, può conoscere ciò che è giusto e può sostanzialmente costruire una vita e una società giusta, attraverso l’obbedienza alla Legge. Per i giudei del tempo di Gesù i miracoli non sono tanto le meraviglie che soltanto Dio può compiere, ma la rivoluzione – si potrebbe dire utilizzando una categoria moderna –, ossia il tentativo di costruire sulla terra una giustizia che esprima fino in fondo la dignità e la capacità dell’uomo. Gesù è vissuto, come ebreo, in un’epoca di trapasso tra gli ultimi scampoli di una reale autonomia da Roma e l’acuirsi dell’ostilità contro i romani. Era sempre più forte il desiderio, da parte degli ebrei, di liberarsi dai romani, ed era questa categoria di carattere politico quella con cui spesso si leggevano anche gli avvenimenti religiosi. Gesù Cristo ha dovuto difendersi più di una volta dalla tentazione di considerarlo espressione della corrente zelota, una delle più radicali, che voleva realizzare la rivoluzione contro i romani e recuperare l’indipendenza politica come segno della grandezza religiosa.
Le contraddizioni dell’Età antica
Si potrebbe dire, semplificando quelle che sono profonde dinamiche storiche, che i greci hanno cercato di fondare l’esistenza dell’uomo sulla ragione, e quindi sulla ricerca della verità, e gli ebrei sulla legge, quindi sulla giustizia. Tuttavia, sulla base dell’idea di verità o dell’idea di giustizia, in nessuno di questi contesti si è realizzata la promessa di una nuova e più umana società sulla terra. Per quanto si è diffusa, la filosofia non ha convertito il mondo, come dice Gustave Bardy: «La filosofia non ha convertito gli uomini [...]. La maggior parte dei filosofi non si cura che degli uomini liberi, dei cittadini, dei ricchi. La loro predicazione è aristocratica. [...] La filosofia non apporta il vero rimedio ai mali di cui soffre l’umanità»15. La filosofia, cioè, riguardava una cerchia ristretta di persone, si rivolgeva a un’élite, non all’intera popolazione; soprattutto, essa non riusciva, per quanto si sforzasse, a rispondere ai veri problemi dell’uomo. In qualche modo gli stessi filosofi ne erano consapevoli. La coscienza di questa strutturale sproporzione dell’uomo trova l’espressione più acuta in un brano famosissimo del dialogo platonico del Fedone, dove per colmarla viene addirittura ipotizzata la convenienza per l’uomo di una rivelazione divina: «Infatti, Socrate, io la penso come te, che, cioè, avere una chiara conoscenza di tale questione [il problema della morte e quindi del senso della vita] in questa vita presente, o è impossibile o è molto difficile, ma che, d’altra parte, il non mettere alla prova in tutte le maniere le cose che si dicono al riguardo e il desistere prima che sia esaurito l’esame sotto ogni rispetto, è da uomo veramente vile. Infatti, trattandosi di questi argomenti, non è possibile se non fare una di queste cose: o apprendere da altri come stiano le cose, oppure scoprirlo da sé stessi; ovvero, se ciò è impossibile, accettare, fra i ragionamenti umani, quello migliore e meno facile da confutare, e su quello, come su una zattera, affrontare il rischio della traversata del mare della vita: a meno che non si possa fare il viaggio in modo più sicuro e con minor rischio su più solida nave, cioè affidandosi a una rivelazione divina»16.
La ragione greca tenta continuamente di arrivare alla verità, ma questa verità è sempre oltre. Allo stesso modo, i giudei si sono sforzati di praticare la giustizia, ma questa giustizia è sempre sostanzialmente irraggiungibile. È quindi prevalso, nel mondo sia greco-romano sia giudaico un certo pessimismo: la ragione cerca la verità, ma non la trova, l’uomo cerca la giustizia, ma non riesce a realizzarla.
Credo sia utile cercare di capire meglio questa dinamica, soffermandosi in particolare sul mondo della cultura greco-romana e cercare, sebbene in termini solo essenziali, di mostrarne contraddizioni e limiti costitutivi, così che l’apparire nel mondo del cristianesimo possa risultare ancora più chiaro nella sua originalità.
Esiste, infatti, un punto in cui il pensiero greco tradisce esplicitamente l’istanza religiosa che lo guida, negandone alla radice il movimento ideale e pratico. Sull’impotenza e la sfiducia della ragione di realizzare ciò che desidera (vale a dire il raggiungimento della verità e della giustizia) si è esteso il dominio del potere, della politica, concepita come unica realtà che ha obiettivamente valore. La pienezza della vita non è più, allora, generata dalla ragione o dalla tensione verso la giustizia, ma è concessa da una struttura politica, considerata come assoluta. Con lo Stato si raggiunge «il limite dell’autosufficienza completa» dal momento che «esiste per rendere possibile una vita felice»17, dice Aristotele.
La filosofia greca risulta, in qualche modo, asservita all’assolutizzazione della dimensione politica dell’uomo, cioè all’assolutizzazione dello Stato. La filosofia della libertà, della città degli uomini liberi, ha finito per concepire lo Stato come assoluto. Essa ha teorizzato e poi programmaticamente difeso il predominio della struttura politica sulla persona, creando così le condizioni perché la persona stessa diventasse semplicemente parte della struttura politica statale: «Per natura lo Stato è anteriore alla famiglia e a ciascuno di noi perché il tutto dev’essere necessariamente anteriore alla parte»18.
Il mondo romano, con il suo grande genio giuridico organizzativo, ha rigorizzato e dilatato questo principio, creando uno Stato mondiale, unificato dal culto dell’imperatore, cioè dal riconoscimento della dimensione politica come obiettivamente assoluta. L’imperium di Roma, espressione della sua capacità legislativa e organizzativa, garantiva la pace e la vita. Al tempo di Gesù Cristo e dei primi cristiani pullulavano religioni, forme magiche e superstiziose, insieme ai tentativi politici, dei quali si trova traccia anche nei Vangeli, di rivoluzionare la società. Tuttavia, in questo contesto molto instabile, l’unica realtà che forniva veramente sicurezza sembrava essere la forza di Roma. Sotto il dominio di Roma potevano sopravvivere le religioni e le concezioni più diverse della vita, secondo un modello sincretistico. L’unica condizione posta era l’adorazione dell’imperatore di Roma. Si faceva sicuramente fatica a capire perché si viveva, ma almeno qualcuno garantiva il sostentamento, promuoveva il divertimento e difendeva la vita dalle minacce dei barbari. L’imperatore era colui che assicurava panem et circenses, farina con una certa regolarità e giochi nel circo. È un mondo unificato dal potere: spera nella ragione e nella giustizia, ma è unificato dal potere dello Stato, la cui forza si fonda su alcune sostanziali divisioni che non possono essere, per nessun motivo, discusse: occorre un enorme numero di schiavi, perché i liberi possano vivere adeguatamente; occorre una contrapposizione di razze e di culture perché si imponga l’imperium di Roma.
La salvezza è un avvenimento storico: Gesù di Nazareth
La novità che reca l’avvento del cristianesimo non consiste in un’idea diversa di verità o di giustizia, ma nell’annuncio che la salvezza dell’uomo sussiste in un avvenimento storico: Gesù di Nazareth, uomo nato in circostanze di tempo e di spazio precise. Il cristianesimo è il mistero che si fa presente: «Quello che voi adorate senza conoscere, io ve lo annunzio» (At 17, 23) dice san Paolo all’Areopago di Atene. Quello che era stato variamente identificato dalla grande esperienza delle varie religiosità, quello che aveva rappresentato la certezza ultima della grande storia del popolo d’Israele, si è fatto presente senza veli: Gesù può affermare «chi vede me vede il Padre» (Gv 14, 9).
Il mistero è una Presenza, si afferma in una Presenza. Una presenza storica, reale, concreta, sulla quale si possono appuntare tutte le attese e perfino, come emerge dal racconto dei Vangeli, la disistima di un mondo che non lo capisce: è un mangione e un beone, è l’amico dei pubblicani e delle prostitute.
Il mistero si è posto in un modo storico, concreto, accettando la sfida della storia, e, a sua volta, rivolgendo alla storia questa sfida incredibile: «Io sono Dio». Basta leggere il numero 423 del Catechismo della Chiesa Cattolica per comprendere adeguatamente la storicità dell’avvenimento cristiano: «Noi crediamo e professiamo che Gesù di Nazareth, nato ebreo, da una figlia d’Israele, a Betlemme, al tempo di re Erode il Grande e dell’imperatore Cesare Augusto, di mestiere carpentiere, morto crocifisso a Gerusalemme sotto il procuratore Ponzio Pilato, mentre regnava l’imperatore Tiberio...». Un uomo storico, identificato secondo le categorie di qualsiasi adeguata ricerca archivistica e storica: la madre, l’ambiente in cui è nato, il tempo, il potere politico esercitato in un’epoca di trapasso. Un uomo il cui nome è scritto nelle liste del tempio di Gerusalemme, le quali, fino alla dispersione del popolo ebraico tra le genti, erano l’unico grande archivio della storia d’Israele.
Ebbene, dopo aver detto questo, che cosa aggiunge il Catechismo? Questo stesso uomo è il Figlio eterno di Dio, fattosi uomo. È venuto da Dio, è disceso dal cielo, è venuto nella carne: «il Verbo si fece carne e venne ad abitare in mezzo a noi, e noi vedemmo la sua gloria, gloria come di unigenito dal Padre, pieno di grazia e di verità. [...]. Dalla sua pienezza noi tutti abbiamo ricevuto, grazia su grazia» (Gv 1, 14-16).
Il cristianesimo è l’identificazione del mistero di Dio con l’uomo Gesù di Nazareth, ne è l’identificazione obiettiva. E la Chiesa ha lavorato per secoli per arrivare a una coscienza adeguata di questo mistero: la presenza nell’unica persona di Gesù Cristo delle due nature, quella divina e quella umana, come dice il testo del Concilio di Calcedonia del 451. Ma sono passati quattro secoli dall’inizio della vicenda, non un giorno. È stato necessario, cioè, un cammino per arrivare, attraverso i numerosi Concili ecumenici, alla consapevolezza chiara del mistero di Cristo, quindi del mistero del Padre e dello Spirito, nonché a un’iniziale consapevolezza del mistero della stessa Chiesa.
Il Verbo di Dio si è fatto carne: siamo di fronte a un evento, a un incontro: i dodici hanno incontrato Gesù di Nazareth, quelli che sono venuti dopo hanno incontrato i suoi e l’incontro con i suoi è stato il grande tramite della permanenza della Sua presenza nella storia. Occorre tenere presente bene questo, contro la tentazione – enucleata con estrema chiarezza da Benedetto XVI all’inizio della Deus caritas est – di ridurre il mistero personale di Gesù Cristo allo spunto per delle emozioni di carattere spirituale, o di concepire Cristo come base per un progetto etico e quindi socio-politico.
Il cristianesimo è l’incontro con una persona, la sequela di Cristo, e, nell’esperienza della sequela di Cristo, l’esperienza del cambiamento, cioè del mistero che si comunica all’uomo, che prende possesso della sua vita e la matura secondo le dimensioni nuove e definitive del Cristo risorto, che è l’uomo vero, definitivamente rivelato a sé stesso e messo in grado di attuare pienamente questa identità che gli è stata rivelata. Diceva Giovanni Paolo II: «Cristo Redentore [...] rivela pienamente l’uomo all’uomo stesso»19. Pertanto il cristianesimo è l’incontro tra il mistero che viene ricercato attivamente, appassionatamente, tragicamente dall’uomo e questo stesso mistero che si fa presente e dice: «Quello che voi cercate sono io».
Come affermato al Sinodo per l’evangelizzazione, voluto da Benedetto XVI, nel Messaggio al popolo di Dio, attraverso l’immagine straordinaria della Samaritana, «non c’è uomo o donna che, nella sua vita, non si ritrovi, come la donna di Samaria, accanto a un pozzo con un’anfora vuota, nella speranza di trovare l’esaudimento del desiderio più profondo del cuore, quello che solo può dare significato pieno all’esistenza». Per la Samaritana, nonostante tutto quello che sembrava indurre a una stasi della vita, a una vita puramente reattiva – quante volte sarà andata a prendere l’acqua; quante volte sarà tornata a casa stanca, così che uno dei suoi desideri era: «Dammi quest’acqua di cui parli, così non devo venire più tutti i giorni ad attingerla» –, improvvisamente, in un modo inaspettato, in un modo difficile addirittura da prevedere e che certamente ha determinato la sua coscienza e il suo cuore per tutto il resto della vita, ecco l’incontro con quest’uomo che dialettizza con lei. E accetta di camminare sulla strada indicata da lei, che è addirittura quella delle diatribe teologiche: è una figlia d’Israele, immorale, con tutti i limiti che poteva avere, ma pur sempre una figlia d’Israele, che ha dentro di sé l’eredità del...
Indice dei contenuti
- Prefazione, del card. Walter Brandmüller
- Introduzione
- PRIMA PARTE
- DUEMILA ANNI IN BREVE
- PROBLEMI DI STORIA DELLA CHIESA