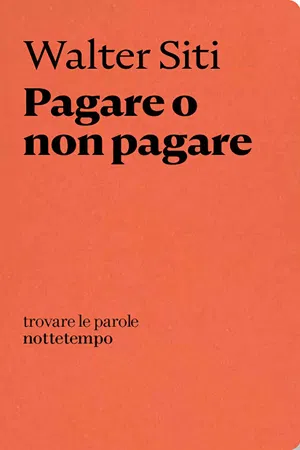
- Italian
- ePUB (disponibile su mobile)
- Disponibile su iOS e Android
eBook - ePub
Pagare o non pagare
Informazioni su questo libro
Come è cambiato il rapporto con i soldi nell'arco di pochi decenni?Rispetto a una generazione che ha conosciuto il "piacere di pagare", il quale definiva l'identità stessa di una persona ("pagare era una sottospecie del pregare"), per "i nativi digitali sono mutati i parametri mentali: pagare (ed essere pagati) è diventato più aleatorio, lavorare per comprare è più una teoria che un fatto, il rapporto stesso con l'economico è diventato più rabbioso, indolente e disperato al tempo stesso".In questo pamphlet di Walter Siti, il concetto di pagare diventa lo spunto per una riflessione critica e un'analisi sociologica e storica di una trasformazione ancora in atto.Pagare o non pagare inaugura la serie di gransassi Trovare le Parole.
Domande frequenti
Sì, puoi annullare l'abbonamento in qualsiasi momento dalla sezione Abbonamento nelle impostazioni del tuo account sul sito web di Perlego. L'abbonamento rimarrà attivo fino alla fine del periodo di fatturazione in corso. Scopri come annullare l'abbonamento.
No, i libri non possono essere scaricati come file esterni, ad esempio in formato PDF, per essere utilizzati al di fuori di Perlego. Tuttavia, puoi scaricarli nell'app Perlego per leggerli offline su smartphone o tablet. Per maggiori informazioni, clicca qui.
Perlego offre due piani: Essential e Complete
- Essential è l'ideale per studenti e professionisti che amano esplorare un'ampia gamma di argomenti. Accedi alla libreria Essential, che include oltre 800.000 titoli di comprovata qualità e bestseller in vari settori, tra cui business, crescita personale e discipline umanistiche. Include tempo di lettura illimitato e voce standard per la sintesi vocale.
- Complete: perfetto per studenti e ricercatori esperti che necessitano di un accesso completo e illimitato. Accedi a oltre 1,4 milioni di libri su centinaia di argomenti, inclusi titoli accademici e specialistici. Il piano Complete include anche funzionalità avanzate come la sintesi vocale premium e l'assistente di ricerca.
Perlego è un servizio di abbonamento a testi accademici, che ti permette di accedere a un'intera libreria online a un prezzo inferiore rispetto a quello che pagheresti per acquistare un singolo libro al mese. Con oltre 1 milione di testi suddivisi in più di 1.000 categorie, troverai sicuramente ciò che fa per te! Per maggiori informazioni, clicca qui.
Cerca l'icona Sintesi vocale nel prossimo libro che leggerai per verificare se è possibile riprodurre l'audio. Questo strumento permette di leggere il testo a voce alta, evidenziandolo man mano che la lettura procede. Puoi aumentare o diminuire la velocità della sintesi vocale, oppure sospendere la riproduzione. Per maggiori informazioni, clicca qui.
Sì! Puoi utilizzare l'app di Perlego su dispositivi iOS o Android per leggere quando e dove vuoi, anche offline. È perfetta per gli spostamenti quotidiani o quando sei in viaggio.
I dispositivi con iOS 13 e Android 7 o versioni precedenti non sono supportati. Scopri di più su come utilizzare l'app.
I dispositivi con iOS 13 e Android 7 o versioni precedenti non sono supportati. Scopri di più su come utilizzare l'app.
Sì, puoi accedere a Pagare o non pagare di Walter Siti in formato PDF e/o ePub, così come ad altri libri molto apprezzati nelle sezioni relative a Business e Comportamento dei consumatori. Scopri oltre 1 milione di libri disponibili nel nostro catalogo.
Informazioni
1. Il piacere di pagare
“E io pago!” – il grido di dolore dell’avarissimo barone Antonio Peletti (interpretato da uno straordinario Totò in 47 morto che parla), quel grido che già era un tormentone nel film lo è diventato molto di piú nei servizi di Striscia la notizia in cui si denunciano gli sprechi di pubblico denaro intorno alle tante incompiute opere pubbliche italiane. Nel 2016 quello stesso grido è diventato il titolo di un libro edito da Chiarelettere e scritto da Daniele Frongia (l’ex vicesindaco della giunta Raggi) con Laura Maragnani; il sottotitolo esplicitava: “Da documenti inediti, tutti i soldi che gli italiani pagano per mantenere la capitale piú corrotta e inefficiente d’Europa”.
“Pagare” è ormai un verbo sotto accusa: pagano sempre gli stessi, loro mangiano e noi paghiamo – indignazione digestiva da talk e telegiornali della sera. Pagare troppe tasse, pagare irragionevoli accise sulla benzina, pagare i privilegi dei politici, pagare imposte occulte o penali non dovute, pagare anche l’aria che respiriamo; si paga, mugugnando, per ciò a cui si avrebbe naturalmente e civilmente diritto: il silenzio, l’acqua pulita, un’ecografia tempestiva, un letto in ospedale o un parcheggio incustodito. Si “unge” un impiegato per non essere scavalcati da qualche prepotente; i gay talvolta pagano per avere figli, le signore ricche pagano per restare eternamente giovani, perfino la morte (dolce) si paga; “pagare” è diventato un sigillo d’ingiustizia, la cicatrice d’uno sviluppo distorto e di un consumismo uscito dai cardini.
Eppure io che ho settant’anni, e provengo da quella che un tempo si chiamava la classe operaia, ricordo il piacere di pagare: una sensazione di trionfo, o almeno di soddisfazione profonda, le prime volte che potevo procurarmi, pagando con soldi guadagnati da me, qualche piccolo lusso. Eravamo nel 1965, nell’estate tra seconda e terza liceo mi impiegai presso un magazzino dell’Enel; si trattava di smistare entrate e uscite del materiale, far firmare ai camionisti (prodighi di birre) bolle e ricevute, tenere la contabilità mediante un sistema di schede perforate. La prima busta paga l’ebbi tra le mani in agosto, gridai la cifra a mia madre dal cortile perché sentissero tutti, e poi con quella cifra le comprai un ventilatore. Meno gratificanti le borse di studio e poi il concorso vinto alla Scuola Normale; il gusto di non pesare sui miei, certo, ma anche una sopravvalutazione della meritocrazia che mi portava a pensieri orgogliosamente idioti quando, facendo i picchetti alla Saint-Gobain, udivo gli operai lamentarsi dei turni (“se fossero stati piú attenti mentre la maestra spiegava…”). La carriera universitaria andò bene e fu piuttosto veloce, l’ascensore sociale funzionava senza intoppi: appena trentanovenne vinsi la cattedra (ruolo di prima fascia, secondo il gergo). Avrei potuto farmi accreditare lo stipendio sul conto corrente ma ogni ventisette mi presentavo invece allo sportello – l’impiegato contava le banconote da cento e cinquantamila, che erano parecchie, e alle mie spalle qualcuno del personale non docente commentava, tra l’ammirato e l’invidioso: “Ma non finiscono mai!” Vanagloria aggressiva di cui non mi vergogno: con quella mazzetta di banconote nella tasca gonfia correvo a comprarmi qualcosa che avevo adocchiato in vetrina nei giorni precedenti, una statuetta ashanti della fertilità o un gilettino dai colori accesi.
Non sempre i miei acquisti erano cosí innocenti. Ma quando Claudio Camarca, senza nessuna intenzione di offendermi, mi apostrofò: “Tu, che hai una lunga esperienza di puttaniere…”, reagii intimamente come se il mondo mi avesse buttato addosso una falsità. Sí, pagavo gli uomini perché venissero a letto con me; alcuni rari uomini portatori di un corpo enfaticamente non comune, sintesi di umano ed extraumano; incontrarli e possederli era cosí sconvolgente che ho mobilitato eserciti di metafore e sporcato per descriverli (e venerarli) centinaia di pagine. Di fronte a un beneficio tanto immenso e immeritato, letteralmente impagabile, dar loro del denaro non era piú soltanto un piacere ma l’obolo necessario deposto ai piedi di un altare sconosciuto; pagare era una sottospecie del pregare, come quando in India si comprano le collane di fiori per Krishna o Ganesh. L’assoluto dell’ossessione è uno strumento che serve per tagliare il nodo scorsoio del Sacro; cosí mi suggeriva la mia inerzia, scontenta della realtà e di quel compromesso che i miei amici si ostinavano a chiamare amore. La manciata di soldi era la garanzia che il rapporto tra me e i Corpi Pneumatici sarebbe rimasto per sempre asimmetrico: un rapporto ossessivo ed estatico da fedele a idolo, mai da persona a persona.
In realtà di loro compravo pochissimo, quasi niente, al massimo li noleggiavo per un’ora o due; ne affittavo l’involucro e poi (semmai) rubavo qualche solecismo linguistico, qualche lampo di disperazione e d’affetto – mai me ne assicuravo un possesso vero, cioè una corresponsione duratura, come tutti loro non mancavano di farmi notare nei momenti piú umilianti e cruciali. Lungo questa vorace e spensierata via crucis sperimentavo però (nella carne) un’equazione decisiva: il sesso diventava per me il modello immaginario del comprare un frammento infinitesimo illudendosi di comprare il Tutto. Interiorizzavo l’idea marxiana della merce come feticcio e l’illusione consumistica per cui, acquistando un singolo prodotto, l’intera rappresentazione di vita simboleggiata da quel prodotto sarebbe stata a mia disposizione. Un paio di scarpe Timberland, un televisore a schermo piatto, una bistecca di manzo Kobe, il Geografo di Vermeer goduto nel museo di Francoforte, esattamente come il pornoattore genovese che veniva a Roma appositamente per me (a un prezzo quasi insostenibile), non valevano soltanto per l’uso che potevo farne ma piú e soprattutto per il loro valore di scambio: uno scambio di me con me stesso, del figlio di operai che si trasvalutava comprando quel che lui credeva fosse desiderato dalle classi superiori (o addirittura dallo spirito del Cosmo).
Molti proletari e piccolo-piccolo-borghesi della mia generazione (noi che ci stavamo faticosamente issando su un malsicuro ballatoio di classe media), anche quelli sessualmente morigerati, furono affascinati dalla magia dell’acquisto – quante cose, sempre piú belle e con un design sempre piú affascinante, si potevano comprare! Già Ortega y Gasset nel 19301 provava a paragonare il “repertorio delle cose in vendita” nel Settecento con quelle disponibili nell’epoca a lui contemporanea, trovando la differenza “quasi mitica”; non solo perché i prezzi in quei duecento anni si erano generalmente molto abbassati, ma anche perché molte piú cose erano diventate “comprabili”. In miniatura, lo stesso era accaduto a noi tra gli anni cinquanta e gli ottanta: le nostre case si riempivano di gadget piú o meno tecnologici, la musica veniva riprodotta sempre piú esattamente, le nostre (le mie poco, a dir la verità) esigenze vestimentarie si moltiplicavano; le serate si affollavano di impegni e biglietti d’ingresso, le estati di viaggi all’estero e festival; le cromature di auto e moto contribuivano alla nostra immagine pubblica, esistevano molte piú protesi e pezzi di ricambio per le nostre insufficienze e malattie – nei lavori faticosi ci soccorrevano sempre piú invenzioni meccaniche e diventava sempre piú semplice assoldare persone (la “servitú!”) che lavassero i nostri pavimenti o accudissero i nostri vecchi. Per avere la stessa comodità di cose e di servizi che aveva un alto-proletario piccolo-borghesizzato negli anni ottanta, duecento anni prima avresti dovuto nascere come minimo visconte o marchese.
Il percorso in salita era facile e gratificante: si trovava un lavoro migliore di quello dei nostri genitori, in qualche scuola o ufficio o come specializzati in fabbrica, si contava sui sindacati per un trattamento salariale decente e coi soldi guadagnati a fine mese si comprava il giusto per fare invidia al vicino. Il lusso relativo, il capriccio, l’esotico: magari comportandoci da ridicoli, con gaffe e cafonerie di cui i veri ricchi si sarebbero vergognati, ma intanto gli orizzonti si allargavano, la competizione sembrava ogni giorno piú aperta e possibile. Quel che non si riusciva a comprare subito si comprava pian piano a rate, o l’anno dopo risparmiando; l’oggetto del desiderio per molti (non per me) era la casa di proprietà – il mutuo in banca spalancava un sentiero al sole (per qualcuno soltanto un corridoio con puzzo di cavoli) in fondo al quale si scorgeva la tanto agognata tranquillità economica dei figli.
Si era tutti spettatori segretamente entusiasti di un fantastico numero di illusionismo, per cui i segni tradizionali della ricchezza (le eredità, le relazioni di potere, i capitali anche culturali generazionalmente radicati) sprofondavano con pudore in una carsica invisibilità, mentre quel che si agitava sul proscenio era l’effimero, l’appariscente, il day by day – e su quella base noi appena usciti dall’ascensore potevamo essere scambiati per coloro che ai piani alti ci abitavano da sempre. Stesso aspetto, stesse speranze (almeno dichiarate), soprattutto stessi argomenti di conversazione. C’erano state le lotte studentesche, gli slogan contro i Padri autoritari, ma anche quello aveva aumentato il tasso di interclassismo: un padre stronzo era un padre stronzo, per il giovane operaio come per il figlio del padrone. Gli estremisti del Maggio francese avevano svaligiato le lussuose vetrine di Fauchon per distribuire gratis ai poveri delle banlieues le terrine di foie-gras tartufato e le cailles en sarcophage, ma sia loro che i suddetti poveri aspiravano seriamente al giorno in cui quelle ghiottonerie avrebbero potuto comprarsele.
Il piacere di pagare era il piacere di sentirsi uguali, era il diritto di pretendere cose grandi; e se questo significava, inconsciamente, tradire la classe di provenienza, mascherarsi da ciò che non si era, rinunciare una volta per tutte a ogni cambiamento radicale che potesse mettere a rischio le nuovissime conquiste, be’ tanto peggio per l’inconscio. “L’impero dei piú forti”, ha scritto Yanis Varoufakis, “sopravvive perché i deboli stessi hanno motivi per difendere il sistema che promuove la loro dipendenza”. Ad abbagliare e convincere, tacitando i sensi di colpa con ragionamenti sempre piú capziosi, c’era la prospettiva onirica e visionaria (mai davvero confessata) di un’espansione infinita di chi fino a ieri era rimasto prigioniero di interdetti sociali e compartimenti stagni; col duro lavoro, col welfare, col sudore di giorno e il cazzeggio di notte (“ma la notte no”, si cantava da Renzo Arbore), anche noi avremmo conquistato quel che due secoli prima soltanto i nobili possedevano, e vent’anni prima soltanto i padroni – saremmo stati anche noi onnipotenti come dèi!
Poi accadde qualcosa, verso la metà degli anni novanta, che rese il meccanismo troppo futile, per non dire oscenamente ipocrita; l’“edonismo reaganiano” e l’“insostenibile leggerezza dell’essere”, di cui sproloquiava con seriosità camp D’Agostino a Quelli della notte, distesero il loro vapore affatturato sugli anni successivi alla Prima Guerra del Golfo. I salari della classe operaia americana avevano cominciato a crollare, l’incerta industrializzazione dei paesi africani si era bloccata e in Africa dilagava l’imperialismo cinese, la FED aumentava i tassi e le nazioni satelliti dell’ex URSS (Jugoslavia, Polonia, Romania) che avevano debiti in dollari scivolavano in default piene d’entusiasmo; in molti paesi arabi le leadership autoritarie che tenevano insieme nazioni fabbricate con lo sputo cominciavano a sgretolarsi, l’Inghilterra post-tatcheriana ce la stava raccontando Ken Loach; eppure le crepe di una crisi ormai mondiale erano nascoste sotto il belletto del credito facile. La pacchia del surplus statunitense reinvestito in Europa era finita, ma la finanza privata ci stava provvisoriamente mettendo una pezza; si continuava a vivere nell’abbondanza ma come in sonno, o in trance. Chi aveva lavorato duro e chi saltava sul carro carnevalesco di un opportunismo di cartapesta si confondevano e si scambiavano le maschere, in una nebbia euforica in cui l’apparenza era piú solida della sostanza. I movimenti di protesta latitavano: i neo-piccolissimi-borghesi, che a vent’anni (prendendo a prestito uno slogan ben piú motivato in America Latina) avevano gridato “yankees go home”, ora galleggia...
Indice dei contenuti
- Copertina
- 1. Il piacere di pagare
- 2. Ma insomma, quanto costa davvero?
- 3. La pubblicità ci affratella?
- 4. Il crollo dei salari e dei diritti
- 5. L’economia del gratis
- 6. Morlock ed Eloi