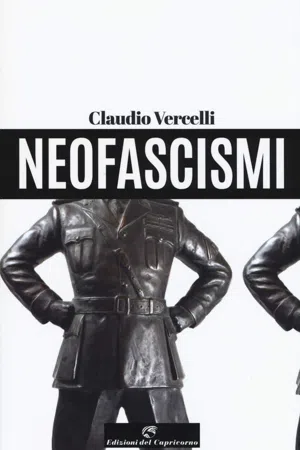![]()
1.
Fascisti senza Mussolini (1945-1947)
1.1.Alla fine della Repubblica Sociale Italiana
Le ultime settimane dell’effimera Repubblica Sociale Italiana, organismo politico neofascista istituito da Mussolini e da una parte dei gerarchi il 22 settembre 1943 in quella zona d’Italia che era ancora occupata dai tedeschi, furono frenetiche. Era chiaro a tutti, anche ai più strenui sostenitori di ciò che restava del fascismo, quale fosse il destino a breve. Per i più fanatici si trattava di celebrare un funereo cupio dissolvi, al limite del proprio personale sacrificio, nella pianura padana, ormai l’ultimo lembo di terra a disposizione. Si trattava di «cercare la bella morte», una sorta di martirio nel nome dell’«idea» fascista, quest’ultima invece destinata a sopravvivere ai suoi apologeti sconfitti. Per il segretario del Partito Fascista Repubblicano, Alessandro Pavolini, prima di cessare qualsiasi residua attività militare occorreva rinserrarsi nel ridotto della Valtellina, una roccaforte collocata per l’appunto tra il Comasco e il Valtellinese. Già presidiata da tre legioni della Guardia Nazionale Repubblicana, quell’area era stata presa in considerazione nel primo autunno del 1944 come alternativa alla fuga in territorio tedesco, qualora gli Alleati, com’era facilmente prevedibile, avessero superato le ultime linee di difesa. Il Ridotto Alpino Repubblicano, com’era stato battezzato, doveva raccogliere almeno cinquantamila «fedelissimi», con le loro famiglie, debitamente armati, trincerati e approvvigionati in un inesistente sistema di fortificazioni. A suggello supremo di quest’ultimo fuoco, i combattenti irriducibili avrebbero portato con sé le ceneri di Dante, da loro intese come la massima espressione dell’identità nazionale. Al pari di tutti i fantasiosi progetti di resistenza (tra gli altri, quelli del generale Farina, che intendeva affidare alla Divisione San Marco, attestata in una specifica posizione appenninica, la protezione delle maggiori autorità repubblicane, o la folle ipotesi di trasformare Milano nella Stalingrado neofascista), all’atto concreto non se ne fece nulla. Diversa era invece l’ipotesi, più verosimile, di trasformare una parte delle strutture della Repubblica Sociale nell’ossatura di un futuro partito neofascista clandestino. Quest’ultimo progetto, caldeggiato soprattutto dal giovane vicesegretario del PFR, Pino Romualdi, si basava in sostanza sulla ramificazione di un’attività clandestina che molteplici nuclei di militi e militanti avrebbero svolto nell’Italia «occupata» dagli Alleati.
Benito Mussolini e il generale Rodolfo Graziani, comandante in capo delle forze armate della RSI (ANSA/S&M Studio).
17 dicembre 1944: Mussolini con Alessandro Pavolini visita la Legione Muti in via Rovello a Milano (ANSA/Farabola).
MUSSOLINI: per il neofascismo è il «duce», una figura che trascende la dimensione storica e quella politica per assumere un connotato mitologico, a tratti sacrale. Così nei «pellegrinaggi» a PREDAPPIO. Se il regime fascista può essere contestato, o addirittura rifiutato in alcune sue manifestazioni, Mussolini è invece il simbolo dell’essenza del fascismo, poiché quest’ultimo s’incarna proprio nell’uomo che gli diede i natali.
In realtà, ciò che stava sulla carta, come nelle parole degli ultimi conciliaboli, franò dinanzi alla repentina evoluzione della situazione. Alla fine di aprile del 1945 era pressoché tutto concluso, con la fucilazione di Mussolini e di una parte dei gerarchi, la disgregazione di ciò che restava delle unità repubblichine, la fuga, perlopiù ingloriosa, dei dirigenti fascisti sopravvissuti, gli scontri armati finali e i successivi regolamenti di conti. Così soprattutto nelle regioni settentrionali del Paese, dove la lotta partigiana era risultata particolarmente accesa. Tuttavia, il clima politico non era uniforme in tutta la Penisola durante la tarda primavera e l’estate del 1945. Nel Mezzogiorno d’Italia, come anche a Roma, dove il ruolo degli antifascisti era risultato di minore incisività e l’occupazione nazista aveva perlopiù lasciato un segno meno drammatico rispetto al Nord del Paese, le occasioni di riparo per i fuggiaschi provenienti dal Settentrione erano assai maggiori. Se una grande parte degli appartenenti ai reparti della RSI di fatto scelse di cessare ogni attività, quanto meno tra coloro che non si erano macchiati dei delitti più efferati, quindi consegnandosi se possibile agli angloamericani, i primi reduci iniziarono invece a raccogliersi nella capitale, dove potevano contare su una rete di connivenze. Non si trattava di un’organizzazione strutturata – il fascismo di Salò non fu comunque capace di costruirla – bensì di un circuito di spontanee complicità e di luoghi protetti, a partire da alcuni istituti religiosi, nei quali i fuggiaschi riparavano, confondendosi con i tanti assistiti, tra sfollati, indigenti, rimpatriati, profughi. Un primo passo compiuto per il ristabilimento di legami, altrimenti a rischio di essere troncati una volta per sempre, fu quindi la tessitura di nuovi rapporti interpersonali tra quanti non intendessero cessare la «lotta». Roma, per l’appunto, costituiva l’ambiente ideale, sia per il suo recente passato di capitale del regime fascista sia per il grande numero di persone che vi confluivano e vi transitavano. Prima ancora che la spinta ideologica, a fare da movente di fondo era il bisogno di procacciarsi di che vivere, senza cadere nelle reti delle nuove autorità, alle quali avrebbero dovuto rendere conto del proprio recente passato. Molti di quei reduci che intendevano continuare a professare i loro convincimenti erano giovani militanti, cresciuti e maturati all’ombra del fascismo, e in particolare di quello di Salò. Non conoscevano altri modelli politici e culturali né intendevano adeguarsi a essi. Nonostante la drammatica sconfitta, che aveva disintegrato tutto il fascismo europeo, coltivavano la convinzione che la loro identità fosse l’unica praticabile. Si trattava semmai di rigenerare le condizioni minime per tornare ad agire in un qualche modo. Come avrebbe detto di quei tempi e di quei luoghi Pino Rauti, futuro dirigente neofascista, la Roma dell’immediato dopoguerra «era un ambiente molto magmatico». Ben presto, a questa generazione di sconfitti che già stava maturando la sindrome dei «proscritti», i reietti dalla società democratica poiché titolari di verità troppo alte per essere comprese dalla parte restante della collettività, si sarebbero uniti quegli adolescenti che non avevano avuto modo e tempo di combattere nella guerra appena conclusasi. Il fascismo, in fondo, non era passato invano, tracciando un lungo solco destinato a pesare anche nel tempo a venire.
PROSCRITTI: sinonimo di esiliati, messi al bando o ai margini della società. Il termine dà il titolo a un importante romanzo di Ernst von Salomon, uscito in Germania nel 1930 ed editato in Italia nel 1943, dove, oltre a raccontare le vicende dei combattenti anticomunisti e antibolscevichi dei CORPI FRANCHI alla fine della prima guerra mondiale, offriva anche una sorta di manifesto generazionale a quanti non volessero adeguarsi alle regole democratiche.
1.2.La «resa dei conti»?
La stessa guerra che aveva attraversato la Penisola, dallo sbarco alleato in Sicilia nel luglio del 1943 in poi, aveva assunto ben presto anche i connotati di una «guerra civile». Era il caso della contrapposizione tra fazioni di donne e uomini appartenenti alla stessa nazione, molto spesso non organizzati in un esercito, ma in milizie paramilitari o in gruppi autorganizzati.
GUERRA CIVILE: conflitto armato, dilacerante e di lunga durata, tra fazioni contrapposte costituite da individui appartenenti alla stessa nazione. In genere la guerra civile chiama in causa non solo le forze armate, legalmente riconosciute come ordinamento militare, ma persone che non vi appartengono e che si organizzano in milizie paramilitari. L’intero periodo che va dall’8 settembre 1943 alla fine dell’aprile 1945 è stato interpretato dal neofascismo come una sola ed esclusiva «guerra civile», che avrebbe visto italiani nazionalisti (i fascisti repubblicani) contrapporsi a italiani traditori o al soldo degli stranieri (il partigianato, in funzione servente del «comunismo» e degli angloamericani).
Sarà però soprattutto la memorialistica neofascista a tematizzare in tali termini la guerra di Liberazione. Lo farà enfatizzando soltanto l’aspetto della divisione tra gli italiani, legandolo al tema del «tradimento» nei confronti del fascismo di quanti, a partire dalla monarchia per poi chiamare in causa la popolazione, fino al 25 luglio 1943 avevano invece condiviso responsabilità e manifestato consenso.
TRADIMENTO: del 25 luglio 1943 e dell’8 settembre dello stesso anno, il primo a causa del voto espresso con il Gran Consiglio del Fascismo che avviava il processo di decadenza di Mussolini, il secondo con l’ufficializzazione dell’armistizio firmato a Cassibile con gli angloamericani. Nella drammaturgia neofascista, poiché era inconcepibile una sconfitta politica e militare per propria insufficienza, si dovevano trovare ragioni esterne al fascismo medesimo. Furono identificate essenzialmente nel ruolo della monarchia e nella condotta di quegli italiani che non scelsero la Repubblica di Salò. Il tema del tradimento è l’equivalente della «pugnalata alle spalle» che i circoli della RIVOLUZIONE CONSERVATRICE tedesca e poi il nazionalsocialismo attribuivano a quanti imputavano di aver causato il tracollo delle armate guglielmine nel novembre del 1918. Tradimento politico altrui, non responsabilità propria, in sostanza.
La conclusione di un conflitto dilacerante, dai connotati fortemente ideologici, poiché così era inteso dalla stessa coalizione nazifascista (la «guerra tra concezioni del mondo», come i tedeschi definivano la loro contrapposizione al comunismo sovietico, al liberalismo euroamericano e al «giudaismo internazionale»), si prestava quindi a una lunga scia di recriminazioni, come anche di violenze a seguire.
In realtà furono più le prime che non le seconde a lasciare il segno. I numeri parlano al riguardo. Secondo i dati del governo (disponibili all’aprile 1946), nella sola lotta di Liberazione, tra i primi giorni di settembre 1943 e il 1° maggio 1945, erano morti 128.505 combattenti, mentre i feriti ammontavano a 29.398. I partigiani caduti risultavano essere 46.747, di cui 20.288 uccisi per rappresaglia o per ragioni politiche, quindi non legate ai combattimenti. Per il ministero degli Interni (dati del medesimo anno) le vittime della «resa dei conti», successiva alla conclusione dei combattimenti, furono complessivamente 9348 (8197 morti e 1167 scomparsi), la grande maggioranza dei quali nelle regioni settentrionali. Di ben altro tenore si è rivelata la memorialistica saloina, schieratasi su unità di grandezza completamente diverse. Giorgio Pisanò, per la sola Emilia-Romagna, fornendo un censimento nominativo, individua 3976 vittime, per poi spingersi alla misura complessiva di 35.000 morti. Altri autori dell’underground neofascista si azzarderanno nell’ipotesi record di circa 300.000 assassinati. Così in un opuscoletto di area, per il quale valgono tuttavia le parole di replica pronunciate da Mario Scelba:
RESA DEI CONTI: è così definito l’insieme delle violenze, a volte culminate nell’assassinio, compiute subito dopo la cessazione ufficiale della guerra combattuta tra opposte fazioni. In Italia si tratta delle ritorsioni e delle vendette che proseguirono ben oltre la fine di aprile 1945, perlopiù ai danni dei vinti. Il neofascismo ha spesso richiamato questo aspetto, ascritto alla natura di GUERRA CIVILE del conflitto tra fascismo repubblicano e partigianato antifascista, per denunciare una gratuita ferocia del secondo ai danni del primo.
In merito ai «trecentomila» assassinati al Nord, devo dire che si tratta di una delle menzogne più spudorate della propaganda del Movimento sociale. Secondo un’inchiesta fatta dal governo sulle persone scomparse dopo la liberazione, e che si potevano presumere uccise per motivi politici, il loro numero è risultato accertato in 1732. E posso dire che non sono forse neppure 1732, perché in quell’elenco sono comprese persone non soppresse, ma squagliatesi per timore di incorrere in rappresaglie.
La cifra dei 300.000 cominciò a comparire sulla carta stampata con l’inizio del 1946. Benché più volte smentita dalle autorità, assunse in alcuni ambienti quella forza che è propria di certe leggende metropolitane, capaci di alimentarsi e reiterarsi da sé. La pubblicistica neofascista l’ha fatta propria in due opere di rilievo, quella di Edmondo Cione, Storia della Repubblica sociale italiana, e il Contromemoriale di Bruno Spampanato. Più verosimilmente, studiosi e ricercatori di area antifascista – che mai hanno negato il fenomeno in sé – si sono attestati intorno alle 15.000-20.000 vittime. Tra il minimalismo di Scelba e le iperboli di alcuni reduci della Repubblica Sociale Italiana esiste quindi una misura intermedia, una proporzione di grandezza, sulla quale ragionevolmente si sono andati riconoscendo gli uni e gli altri. Con tuttavia significativi scarti all’insù o verso il basso. Peraltro alle cifre inflazionate che venivano proposte non seguivano riscontri documentali, di per sé comunque non sempre facili da ottenere, poiché di certe morti non vi era traccia alcuna, se non nella memoria di chi a esse aveva assistito. Il mancato rinvenimento dei corpi poteva essere in concreto qualificato solo in quanto effetto di una scomparsa (non necessariamente un’uccisione, bensì una fuga), rendendo molto problematico il computo degli assassinati. A certe cifre, piuttosto che a «cifre certe», si perveniva quindi per induzione: il riscontro che in determinati luoghi vi fossero stati dei giustiziati, rapportato all’estensione dei territori considerati, portava a una proiezione statistica, per elevato grado di approssimazione, basata sulla pura ipoteticità. Quel che da ciò conseguiva, ovvero una data misura di grandezza, veniva poi offerto dalla pubblicistica d’area come fatto assodato e definitivo. La fantasia e la vocazione polemica colmavano il divario tra immaginazione e realtà. Una nota curiosa, a latere della querelle, è il fatto, più volte riscontrato, che i martirologi repubblichini non sempre distinguono tra caduti della propria parte e quelli partigiani, elencando insieme gli uni e gli altri e attribuendosi, computandoli ai propri, i numeri altrui. Sommando agli assassinati, di cui vi era la certezza della morte, anche gli scomparsi, un Appunto del ministero dell’Interno del 4 novembre 1946 calcola in 8153 le vittime alla data dell’ottobre del medesimo anno, seguendo una scala decrescente che va dal numero massimo attribuito a Torino (1138) alla misura minimale di Ravenna (170). Questo per il Nord d’Italia. Estendendo l’area geografica e comprendendo nel computo tutto il Paese, nel biennio 1945-1946 si arriverebbe a un totale di 9384 persone «politicamente compromesse» uccise o rapite e – presumibilmente – subito dopo assassinate. I valori assolu...