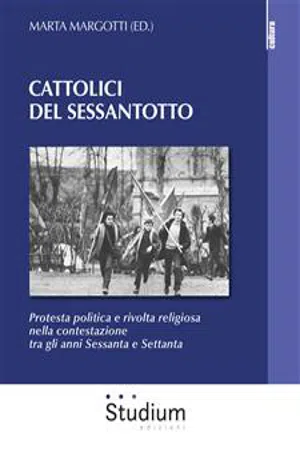Tra il 1967 e il 1969, nella Chiesa di Torino si diffusero tensioni che avevano origine lontane e che si radicalizzarono rapidamente insieme all’intensificarsi delle proteste studentesche e dalle lotte operaie, particolarmente intense in città e nel suo circondario [1] . L’arrivo alla guida della diocesi di Michele Pellegrino nel 1965 aveva favorito la recezione nelle parrocchie e nelle associazioni delle linee di rinnovamento del Concilio vaticano II, nonostante la staticità di molti fedeli, lamentata dai più convinti sostenitori dell’aggiornamento, e le sotterranee opposizioni conservatrici di una minoranza di preti e laici che trovò ascolto anche in alcuni settori della curia [2] . Prima dell’arrivo nel 1965 del nuovo arcivescovo, la Chiesa di Torino si era già segnalata per iniziative e riflessioni che indicavano l’insoddisfazione di una parte del clero e del laicato per le scelte compiute dalla diocesi e dalle parrocchie, considerate inadeguate alla realtà della città industriale. Emblematici erano stati i fatti contrastati che avevano coinvolto, tra la fine degli anni Cinquanta e l’inizio degli anni Sessanta, i cappellani di fabbrica della Fiat e il Movimento lavoratori della Gioventù di Azione cattolica, e, seppur inizialmente con effetti meno dirompenti, le esperienze di impegno sociale dei ragazzi e delle ragazze di Gioventù studentesca: queste tendenze erano il segnale della presenza di credenti orientati verso un cristianesimo evangelicamente ispirato ritenuto in grado di rispondere alle richieste di cambiamento degli ambienti popolari e alle difficoltà della Chiesa nella realtà urbana largamente secolarizzata [3] .
Furono i settori giovanili del cattolicesimo a interpretare in modo più evidente, alla fine degli anni Sessanta, la volontà di cambiamento nella Chiesa torinese. Indicative di tale effervescenza furono le scelte non convenzionali compiute da alcune associazioni laicali, con la prevalenza di posizioni progressiste nelle Acli provinciali [4] , i seminaristi al lavoro, sulle orme dei primi preti operai [5] , la precoce convergenza delle attività della Gioventù femminile e della Gioventù maschile dell’Ac (ancor prima delle modifiche nel 1969 dello Statuto a livello nazionale) e la crescente insofferenza nella Fuci per quelli che erano considerati il moderatismo prevalente nella federazione degli universitari cattolici a livello nazionale e la sua frenante dipendenza dall’autorità ecclesiastica [6] . Dopo il Concilio, alcuni gruppi giovanili parrocchiali si erano intanto allontanati polemicamente dalle linee dettate dall’Azione cattolica per proporre iniziative autonome, ritenute più aderenti alle particolarità locali e alla volontà di protagonismo delle nuove generazioni. Nella seconda metà degli anni Sessanta, soprattutto in città, aumentò dunque il numero dei gruppi spontanei che dentro e – sempre più – fuori delle strutture parrocchiali e delle associazioni cattoliche incrociavano lettura della Bibbia, richieste di riforma della Chiesa e intervento sociale nella realtà operaia. Vi erano, tra questi, due gruppi all’epoca per molti aspetti simili, anche se con percorsi destinati a esiti diversi: la comunità di via Vandalino, creata da militanti di Gioventù studentesca di Azione cattolica, e la comunità di via Piave, dove tra gli altri era presente lo studente di Economia e commercio, Enzo Bianchi, che proseguì poi quella esperienza ecumenica in un cascinale di Bose, sulle colline tra Ivrea e Biella [7] .
Molti giovani cattolici torinesi nati tra il 1940 e il 1955 (che avevano dunque all’epoca tra i 15 e i 30 anni) furono protagonisti del “lungo Sessantotto”, contribuendo attivamente a generarlo e poi a ingrossarlo, in alcuni casi anche fuori dei confini della diocesi [8] . È possibile ricostruire tale stagione del cattolicesimo torinese – per molti versi convulsa – tendendo la trama della ricostruzione tra due eventi o, meglio, tra due processi che nei documenti d’archivio e nella memoria di alcuni protagonisti si mescolano, sino, in alcuni tratti, a coincidere. Vi sono, da un lato, la partecipazione alle proteste studentesche, tra l’autunno del 1967 e l’inizio del 1969, e, dall’altro, la preparazione e lo svolgimento del congresso giovanile di Rivoli, organizzato dalle associazioni giovanili cattoliche nell’aprile 1969. È però questo secondo elemento che nella memoria di molti militanti del cattolicesimo torinese è stato considerato, con il passare del tempo, il punto di svolta di quella stagione, tanto da sopravanzare il primo nel ricordo personale e collettivo.
Si può ipotizzare che la partecipazione di preti e militanti cattolici alle proteste del Sessantotto torinese sia stato l’esito di fermenti che erano già maturati già negli anni precedenti il Concilio vaticano II in alcuni settori della Chiesa torinese e che si radicalizzarono alla prova della contestazione studentesca. Mantenendo questo punto di vista, è possibile così indagare la miscela di motivazioni religiose e sociali all’origine della partecipazione dei cattolici torinesi alla contestazione sessantottina e il ruolo svolto dal cardinal Pellegrino di fronte al montare delle proteste nelle aule universitarie in cui aveva a lungo insegnato, oltre che considerare la pluralità dei percorsi personali e collettivi scaturiti tra preti e militanti in quell’inedita esperienza di mobilitazione politica.
1. La protesta perfetta
A Torino, com’è noto, il Sessantotto iniziò in anticipo rispetto ad altre sedi universitarie italiane, con l’occupazione di Palazzo Campana nel novembre del 1967 e un’ulteriore anticipazione rappresentata dall’effimera presa dell’aula magna delle facoltà umanistiche nel febbraio precedente [9] .
Il 9 febbraio 1967 l’assemblea convocata dagli studenti per discutere del progetto di riforma presentato dal ministro Gui si era infatti conclusa con l’occupazione dell’aula che fu sgombrata nella stessa serata dalla polizia chiamata dal rettore Mario Allara. I dimostranti, che si erano spostati nella vicina Camera del lavoro, ricevettero anche la solidarietà degli studenti dell’Intesa universitaria (tradizionalmente vicina alla Democrazia cristiana) e decisero l’occupazione per il giorno successivo dell’intero Palazzo Campana. Le proteste si diffusero rapidamente in altre sedi universitarie della città, coinvolgendo anche alcuni assistenti e i pochi docenti solidali con i contestatori. Le divisioni emerse tra gli studenti e la fiducia data al rettore dal Senato accademico e dal Consiglio comunale di Torino (di cui era sindaco il democristiano Giuseppe Grosso, preside della Facoltà di legge) contribuirono ad affievolire la spinta della contestazione che però riprese con più vigore nel novembre successivo. La decisione di costruire a Venaria, lontano dal centro della città, un nuovo complesso universitario aveva creato una certa spaccatura nell’ateneo tra docenti di ruolo, da una parte, e alcuni incaricati e assistenti, dall’altra, e soprattutto rinfocolò la protesta degli studenti, che temevano un aumento delle tasse e crescenti difficoltà di accesso dei meno abbienti allo studio universitario. L’occupazione di Palazzo Campana fu decisa il 27 novembre 1967 durante un’assemblea di circa 500 studenti, con l’accordo dei rappresentanti dell’Ugi (sinistre), dei liberali dei Goliardi indipendenti e dei cattolici dell’Intesa universitaria. Come era accaduto pochi giorni prima all’Università cattolica di Milano, gli studenti impedirono l’ingresso dei professori e le lezioni furono sospese in nome di immediate riforme, minore autoritarismo e autogestione. A metà dicembre, anche il Politecnico di Torino fu coinvolto nelle proteste e fu occupata la sede della Facoltà di architettura, al Castello del Valentino. Il 27 dicembre la polizia intervenne per allontanare le poche decine di studenti che erano rimasti durante le vacanze di Natale a presidiare le sedi universitarie. Le occupazioni delle aule ripresero però pochi giorni dopo e si ripeterono per tre volte tra gennaio e febbraio del 1968, con la crescente partecipazione di studenti e studentesse dei licei e degli istituti tecnici e i primi contatti con gli ambienti operai, che erano stati favoriti dall’aumento delle presenze nelle scuole e nelle università di giovani del proletariato urbano, ma anche di studenti lavoratori che contribuirono a inserire nelle proteste temi, linguaggi e obiettivi tipici delle rivendicazioni sindacali [10] .
Le reazioni del cattolicesimo torinese di fronte alle proteste studentesche riflessero, come in uno specchio, ma ancor più nitidamente, l’ampio spettro di posizioni che si erano già manifestate di fronte all’applicazione delle innovazioni del Concilio, dalla disapprovazione allarmata alla perplessa ansietà, dalla prudente osservazione alla convinta partecipazione. I cortei per le strade, le occupazioni delle aule, il blocco delle lezioni, gli slogan sfrontati, gli scontri con la polizia e gli arresti di alcuni contestatori preoccuparono gli ambienti cattolici conservatori e moderati, ancor più inquietati dall’adesione alle proteste di giovani provenienti dalle parrocchie e dalle associazioni. Non mancarono poi preti e laici che, pur avendo accompagnato con favore l’aggiornamento del Concilio, guardarono con crescente apprensione il diffondersi delle proteste, a iniziare da Pellegrino, che aveva insegnato a lungo letteratura cristiana antica all’Università di Torino e che manteneva stretti contatti con alcuni docenti, in particolare con coloro che erano stati coinvolti nel neo-costituito Consiglio pastorale diocesano.
A Torino, la Fuci (che da qualche anno aveva unificato di fatto i rami femminile e maschile e contava una trentina di tesserati e alcune decine di partecipanti alle sue attività [11] ) aveva una lunga tradizione di iniziative culturali e di presenza universitaria. Negli anni immediatamente precedenti, erano emersi ripetuti contrasti interni tra un indirizzo più legato alle iniziative religioso-culturali e un altro più orientato verso scelte di azione sociale diretta, mentre risultava particolarmente difficile il passaggio alla Federazione universitaria dei molti ragazzi e ragazze appartenenti alla Gioventù studentesca di Azione cattolica [12] , di cui era assistente ecclesiastico don Vittorino Merinas che proprio nel 1967 aveva promosso una comunità in via Vandalino, in un quartiere alla periferia ovest di Torino, con l’obiettivo di un deciso inserimento nei quartieri popolari e nel “movimento operaio”. Si trattava di tensioni che si riprodussero nel Centro cattolico universitario, costituito tra il 1966 e il 1967, che intendeva essere punto di incontro e coordinamento di studenti, assistenti e docenti universitari, la cui guida era stata affidata dall’arcivescovo a don Enrico Peyretti, già presidente centrale della Fuci dal 1959 al 1961 e all’epoca insegnante di religione al Liceo classico Cavour [13] . Era riemersa nel Centro (e non risolta completamente) la tradizionale alternativa tra “pastorale d’ambiente” e “pastorale su base territoriale”, che da Torino già dalla fine degli anni Quaranta aveva preoccupato i vertici nazionali dell’Ac di Luigi Gedda per la scelta di Giac e Gf di promuovere localmente movimenti giovanili cristiani in ambiente operaio. Ancor più dopo il Concilio, secondo quanto considerato da Peyretti nel dicembre 1967, non si trattava soltanto della messa in discussione di aspetti organizzativi, ma della più essenziale questione del confronto del cristianesimo con il «mondo moderno» e, concretamente, con quei «“ mondi particolari” in gran parte formatisi fuori e senza la Chiesa» [14] . Partendo dalle associazioni giovanili esistenti (Fuci, Congregazioni mariane dei gesuiti, Giac e Gf, gli scout e le guide di Asci e Agi), il Centro intendeva promuovere la “missione universitaria”, cercando una «linea di unità più larga della Fuci» per definire le «forme di annuncio del Vangelo» e per realizzare l’impegno «di tutta la Chiesa di tradurre nella lingua sempre particolare di ogni esperienza, di ogni tempo, di ogni gruppo umano, di ogni singola persona la fecondissima Parola di Cristo» [15] .
Proprio l’insoddisfazione di alcuni fucini per le scelte giudicate eccessivamente aride della Federazione a livello nazionale, la forte proiezione in campo sociale di Gioventù studentesca e, più in generale, il clima di rinnovamento alimentato dalle iniziative sostenute da Pellegrino, uniti alle proteste che stavano diffondendosi negli atenei, contribuirono dunque alla definizione anche tra gli universitari cattolici di orientamenti decisamente progressisti in campo sociale e religioso. Si profilò sempre più nettamente una contrapposizione tra le diverse posizioni del movimento studentesco dell’Ac diocesana. Come scriveva all’arcivescovo nell’estate del 1967 l’assistente ecclesiastico del ramo maschile della Fuci, don Luigi Pitet, esisteva un’anima, giudicata «attualmente estenuata in Fuci, ma forse viva in alcuni settori giovanili dell’A.C., che sottolinea la scoperta personale del messaggio cristiano e la testimonianza individuale e comunitaria negli ambienti scolastici; l’altra...