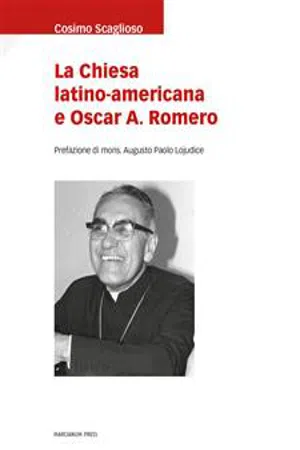
- Italian
- ePUB (disponibile su mobile)
- Disponibile su iOS e Android
eBook - ePub
La Chiesa latino-americana e Oscar A. Romero
Informazioni su questo libro
Il lavoro del professor Scaglioso non può essere considerato solo una nuova biografia di Romero: si presenta anzitutto come una panoramica sulla situazione dell'America Latina nel secolo scorso, panoramica da cui parte per inquadrare il contesto in cui si innesterà il ruolo e si ergerà la voce di Mons. Romero. L'analisi della teologia della Liberazione, il ricordo della formazione delle comunità di base come punto di partenza per una nuova coscienza di popolo, la presentazione di parecchi testi di Romero e il ricordo delle registrazioni che riportano la viva voce del vescovo martire: questi ed altri documenti ci fanno attraversare e rivivere un tempo e un uomo che ha veramente dato la vita per il Vangelo.
Domande frequenti
Sì, puoi annullare l'abbonamento in qualsiasi momento dalla sezione Abbonamento nelle impostazioni del tuo account sul sito web di Perlego. L'abbonamento rimarrà attivo fino alla fine del periodo di fatturazione in corso. Scopri come annullare l'abbonamento.
No, i libri non possono essere scaricati come file esterni, ad esempio in formato PDF, per essere utilizzati al di fuori di Perlego. Tuttavia, puoi scaricarli nell'app Perlego per leggerli offline su smartphone o tablet. Per maggiori informazioni, clicca qui.
Perlego offre due piani: Essential e Complete
- Essential è l'ideale per studenti e professionisti che amano esplorare un'ampia gamma di argomenti. Accedi alla libreria Essential, che include oltre 800.000 titoli di comprovata qualità e bestseller in vari settori, tra cui business, crescita personale e discipline umanistiche. Include tempo di lettura illimitato e voce standard per la sintesi vocale.
- Complete: perfetto per studenti e ricercatori esperti che necessitano di un accesso completo e illimitato. Accedi a oltre 1,4 milioni di libri su centinaia di argomenti, inclusi titoli accademici e specialistici. Il piano Complete include anche funzionalità avanzate come la sintesi vocale premium e l'assistente di ricerca.
Perlego è un servizio di abbonamento a testi accademici, che ti permette di accedere a un'intera libreria online a un prezzo inferiore rispetto a quello che pagheresti per acquistare un singolo libro al mese. Con oltre 1 milione di testi suddivisi in più di 1.000 categorie, troverai sicuramente ciò che fa per te! Per maggiori informazioni, clicca qui.
Cerca l'icona Sintesi vocale nel prossimo libro che leggerai per verificare se è possibile riprodurre l'audio. Questo strumento permette di leggere il testo a voce alta, evidenziandolo man mano che la lettura procede. Puoi aumentare o diminuire la velocità della sintesi vocale, oppure sospendere la riproduzione. Per maggiori informazioni, clicca qui.
Sì! Puoi utilizzare l'app di Perlego su dispositivi iOS o Android per leggere quando e dove vuoi, anche offline. È perfetta per gli spostamenti quotidiani o quando sei in viaggio.
I dispositivi con iOS 13 e Android 7 o versioni precedenti non sono supportati. Scopri di più su come utilizzare l'app.
I dispositivi con iOS 13 e Android 7 o versioni precedenti non sono supportati. Scopri di più su come utilizzare l'app.
Sì, puoi accedere a La Chiesa latino-americana e Oscar A. Romero di Cosimo Scaglioso in formato PDF e/o ePub, così come ad altri libri molto apprezzati nelle sezioni relative a History e Latin American & Caribbean History. Scopri oltre 1 milione di libri disponibili nel nostro catalogo.
Informazioni
1. America Latina, terra di contrasti
L’America latina, nella seconda metà del XX secolo, è terra di
contrasti sul piano economico, politico, sociale e culturale tra la
ricchezza e il potere di pochi e un sottosviluppo cui è legato
l’asservimento delle masse, visti falsamente l’uno e l’altro come
dato di destino piuttosto che conseguenza di scelte interne di
governi non democratici e di politiche di Paesi forti vicini e/o
lontani tesi al controllo e allo sfruttamento di Paesi
deboli.
I Paesi dell’America latina, infatti, solo marginalmente toccati
dagli avvenimenti della seconda mondiale, nella seconda metà del XX
secolo cominciarono ben presto ad avvertire momenti di crisi
economica e culturale alla presenza di una accelerata
urbanizzazione che svuotò in un certo senso le zone rurali, cui si
accompagnò uno sviluppo industriale non produttivo data
l’incapacità di trasferire le monoculture in atto in una produzione
di beni più vari, con conseguenti abborracciate, e fallimentari,
riforme agrarie per altro sempre a vantaggio dei ricchi proprietari
terrieri. Ne derivarono pesanti inquietudini sociali sfocianti in
vere e proprie rivendicazioni popolari represse con la violenza,
dato anche lo scarso aiuto dei tentativi di due o più Stati
impegnati a dar vita a organizzazioni di tipo cooperativo. Senza
dimenticare che governi e dittature sorretti o meno da forze
militari erano fondati sulla “dottrina della sicurezza nazionale”
nei confronti di un comunismo politicamente presente e socialmente
attivo con richiami diretti all’Unione delle Repubbliche Socialiste
Sovietiche in chiave d’opposizione agli Stati Uniti e alla loro
politica
[1]
.
Se sono giuste le linee generali delle condizioni dell’America
latina, qualche dato concreto non è un esercizio retorico, ma aiuta
a capire le scelte di coloro che, in qualche caso anche con la
guerriglia, cercarono di operare a difesa degli oppressi, dei
poveri e degli emarginati.
«Si tratta di un continente in cui», scrive P. Gheddo
[2]
, «la degradazione politica è sconfortante. Nel 1954 dodici
delle repubbliche latino-americane erano amministrate da generali
saliti al potere con la forza, sette anni dopo, nel 1961, uno solo
di questi dittatori resisteva al potere, Stroessner nel Paraguay:
al momento in cui Kennedy lanciava l’
Alleanza per il Progresso vi era motivo di essere
ottimisti sul futuro politico ed economico dell’America latina.
Ebbene da allora sono trascorsi solo sei anni e la situazione si è
nuovamente capovolta; in seguito anche le disillusioni causate
dall’Alleanza per il Progresso, che non è riuscita a far decollare
i Paesi latino-americani, rivolte e colpi di stato si sono
succeduti a ritmo continuo ed oggi, dopo solo sei anni, ripetiamo,
i Paesi rimasti con lo stesso regime democratico di sei anni fa
sono solo quattro: Cile, Messico, Uruguay e Costa Rica: gli altri
sono tutti dominati da militari o da dittature personali».
Solo qualche dato per supportare il quadro di sintesi delineato
da P. Gheddo, che, al di là di più precise annotazioni storiche, si
può dire presenti nelle sue dinamiche di base anche al di là del
limite cronologicamente fissato, nello spazio temporale compreso
negli anni della “guerra fredda” con la cesura segnata dalla caduta
del muro di Berlino (1989), ma anche dopo.
Sono gli anni:
- in Argentina, del generale J. D. Peron, Presidente della Repubblica dal 1946 al 1955 dal rigido controllo statale, responsabile di alcune riforme sociali, ma già nel 1955 costretto ad andare in esilio per una rivolta interna, ma di nuovo al potere, nel biennio 1973-1974 grazie al trionfo del peronista Campora da lui destituito. Gli succede la seconda moglie Maria Estela Martinez (Isabelita) nel 1974, rovesciata nel 1976 da una giunta militare che portò J. R. Videla alla Presidenza della Repubblica;
- di G. Vargas, Presidente della Repubblica del Brasile dal 1934 (era già nel governo provvisorio del 1930) al 1955, con governo autoritario schierato contro la destra e la sinistra, impegnato con misure sociali a sviluppare l’economia. Deposto nel 1945 ritornò al potere nel 1950, facendo assassinare membri dell’opposizione e favorendo il diffondersi della corruzione. Attaccato dalla stampa e costretto alle dimissioni dai suoi ufficiali, morì suicida nel 1954. Dopo la Presidenza di J. Kubitschek (1956-1961) cui si deve la nuova capitale Brasilia, c’è stato un lungo periodo di instabilità seguito da un golpe di militari che instaurarono un regime autoritario e poliziesco, sviluppando l’economia con l’aiuto degli USA. Con l’arrivo del generale Geisel ci fu nel 1974 un ritorno al regime costituzionale;
- di Anastasio Somoza che da capo della guardia nazionale con un colpo di stato dette vita ad un regime dinastico in Nicaragua a partire dal 1937. Assassinato nel 1956 venne sostituito prima dal figlio Luis (1957-1963), poi dal fratello di quest’ultimo Anastasio detto Tachito nel 1967. Il Nicaragua venne liberato nel 1979 da una rivolta sandinista;
- di Alfredo Stroessner dal 1954 al 1989 Presidente del Paraguay grazie al un colpo di stato militare.
- del dittatore Ubico (1931-1944) in Guatemala Stato controllato dagli Stati Uniti, i quali nel 1954 favorirono il colpo di stato del colonnello Carlos Castillo Armas contro il dittatore Arbenz che nel 1952 aveva avviato una riforma agraria;
- del colpo di Stato del 1993 del generale A. Pinochet contro S. Allende che nel 1970 aveva vinto le elezioni alla testa dell’ Union popolare dei socialisti senza ricorrere alla violenza, sostituendo il democristiano E. Frei al potere dal 1964 e avviando riforme agrarie e processi di nazionalizzazione non graditi agli USA. Allende, armi alla mano, venne ucciso nel palazzo presidenziale e Pinochet dette vita ad un regime di forte repressione annullando tutte le riforme in atto;
- della dittatura di Batista a Cuba (1933-1940; 1944-1959), regime economicamente e politicamente controllato dagli USA e rovesciato dall’azione di Fidel Castro e dei suoi guerriglieri avviata nel 1953.
[1]
R. Nocera,
Stati Uniti e America latina dal 1945 ad oggi, Carocci,
Roma 2005; A. Rouquié,
L’America latina, Bruno Mondadori, Milano 2000.
[2]
In
La Documentazione scientifica dei problemi trattati dalla
Populorum Progressio, in aa. vv.,
Commento all’enciclica, Massimo, Milano 1967, pp. 91-92.
2. La Chiesa latino-americana nella prima e nella seconda metà del XX secolo: la nascita dell’America latina
Le battute conclusive del precedente paragrafo legato ad una breve presentazione dell’America latina come terra di contrasti ci portano più propriamente nel contesto della seconda metà del secolo XX quando, sulla base di una nuova e più matura consapevolezza della portata del messaggio della Buona Novella, la Chiesa latino-americana, nella sua maggioranza, aveva assunto posizioni nette, a difesa dei diritti della persona in termini di giustizia sociale, contro poteri costituiti responsabili delle condizioni di povertà, di miseria di sfruttamento, di emarginazione in cui viveva la maggioranza della popolazione. Non mancarono, tuttavia, rappresentanti del clero, – anche dell’alto clero –, e religiosi, in più occasioni schierati per varie ragioni con il potere a difesa dello status quo. Ma erano una minoranza a differenza di quanto era accaduto nella prima parte del secolo.
All’indomani, infatti, delle guerre di indipendenza e dell’instaurazione dei regimi liberali (siamo nel secolo XIX, a partire da 1810), mutarono anche ruolo e modalità di governo della Chiesa. La Chiesa latino-americana, libera dal controllo esercitato dai re di Portogallo e di Spagna sulla vita ecclesiastica (ne derivava un debole potere del Vaticano, a partire dal non pieno rispetto delle conclusioni del Concilio di Trento), insieme ai rapporti con i poteri locali, aveva favorito anche più strette relazioni con il Vaticano, avviando un processo di “romanizzazione”, confermato dal Concilio plenario dei vescovi del continente sud-americano che si tenne a Roma nel 1899. Ne derivò una clerizzazione della vita della Chiesa locale anche con l’arrivo di sacerdoti e di religiosi dell’area europea, data la scarsa presenza del clero locale e di nuove vocazioni.
La Chiesa latino-americana, «arrestata al mito della cristianità edificata ai tempi della conquista», senza rinunciare alla «difesa dei privilegi annessi a questa situazione», conservava ancora «i suoi antichi edifici in prossimità della capitaneria del governo coloniale, chiese Rinascimento o barocchi palazzi episcopali», ma soprattutto «la sua potenza» e «i suoi legami con il potere» [1] che mostrava di favorire gli interessi cattolici, pur basato su valori antiliberali e nazionalisti. Come nel caso di Vargas in Brasile o Peron in Argentina, in particolare nel corso del XX secolo con la diffusione del protestantesimo che sosteneva posizioni liberali e valori democratici.
Ma già in questa fase, tuttavia, non sempre i rapporti tra Chiesa locale e potere erano pacifici.
Basti pensare allo scontro tra il presidente del Messico Plutarco Elias Calles e l’episcopato cattolico. Di forti ambizioni autoritarie, volendo esercitare il pieno controllo del Paese, il Presidente aveva messo in atto l’art. 130 della Costituzione fatto approvare nel 1917, e con la legge Calles del 1952 aveva privato la Chiesa di entità giuridica e i sacerdoti – che per altro dovevano essere messicani per nascita – del diritto di voto; aveva fatto chiudere Chiese, scuole e seminari, confiscato i beni della Chiesa; aveva espulso i sacerdoti non messicani, costringendo quelli messicani all’inattività in quanto aveva affidato ad autorità federali la gestione delle attività di culto. Fu abolita anche ogni libertà di espressione. Quanti si dichiaravano contrari vennero incarcerati, torturati e uccisi.
Non poteva non esserci una ribellione di popolo: nacque la Liga Nacional difusora de la Libertad Religiosa e dal 1926 al 1929 si sviluppò quella guerra che dal nome dei ribelli, i Cristeros (viva Cristo re), ebbe nome guerra cristera o Cristiada. Ai ribelli si unirono alcuni militari come Enrique Gorostieta Velarde. Dopo sanguinosi combattimenti (negli scontri persero la vita 85.000 civili messicani), i ribelli ebbero la meglio, malgrado le forze governative avessero ricevuto cospicui aiuti militari da parte degli Stati Uniti interessati alle ricchezze petrolifere del Messico: questa pagina di storia rivive nel film Cristiada, 1982, di Dean Wright, prodotto dalla Dominus Production.
Il nuovo presidente del Messico, Portes Gil, per evitare il peggio nel giugno del 1929 si piegò ad un accordo con la Chiesa, autorizzando la ripresa del culto cattolico. Il modus vivendi, tuttavia, che aveva aperto alla pace, fu più volte violato, tanto che il Vaticano emanò direttive finalizzate dando alla Azione cattolica locale compiti per difendere il cattolicesimo del Paese (Pio XI con l’ Enciclica Acerba animi, 29.9.1932, denunciò il non rispetto dell’accordo, e in seguito con la Firmissimam Constantiam, 28.3.1937, legittimò in qualche modo l’eventuale ripresa della lotta armata, pur non impegnando direttamente il clero e l’Azione cattolica).
Nella seconda metà del XX secolo l’America latina, in particolare dopo gli anni ’60, è nel pieno dell’instabilità più profonda alla presenza, come emerge dal primo paragrafo ( America latina, terra di contrasti), dei vari regimi militari che si susseguono, magari alternati ai frequenti colpi di stato ( golpe de Estado). La base comune è data dalla convinzione delle classi dirigenti o dei rappresentanti delle classi più agiate o dai militari che la difesa dei propri interessi fosse possibile solo grazie alla restrizione e/o alla sospensione – nell’illusione che potesse essere transitoria – delle libertà democratiche.
Potere politico a forte dipendenza dagli Stati Uniti d’America in riferimento all’imperativo dettato negli anni ’40 dall’influente geografo statunitense Isaiah Borman, secondo cui “Nessuna linea può essere fissata nel mondo a confinare gli interessi degli Stati Uniti” (più tardi, negli anni ’60 J. F. Kennedy affermerà: “Oggi le nostre frontiere sono in ogni continente”). Ma più ancora, in regime di “guerra fredda”, per la minaccia interna al continente costituita da gruppi molto attivi di guerriglieri di ispirazione marxista impegnati contro governi militari o dittatoriali filostatunitensi: il pensiero va ai monteneros operanti in Argentina, ai tupamaros dell’Uruguay, ma soprattutto ai seguaci di Fidel Castro che aveva liberato Cuba (1959) con la morte del dittatore Batista (senza dimenticare che la morte di Che Guevara, solidale di Castro, era avvenuta nella Bolivia controllata da forze militari). Cuba, in fondo, non è molto lontana dalla Florida.
Allo sfruttamento delle risorse latino-americane – e non solo di natura agricolo-alimentare – si univa anche una ragione di natura politica che prese il nome di “dottrina della sicurezza nazionale” per la difesa dal comunismo dei vari Paesi, ma più ancora dagli stessi Stati Uniti d’America, come la crisi del 1962 ebbe, poi, a dimostrare.
A farne le spese, a pagare il conto furono i poveri “cristi”, contadini in primis, gli sfruttati e gli emarginati.
La Chiesa latino-americana nell’immediato periodo del secondo dopoguerra non poteva continuare ad essere quella nata dal Concilio plenario latino-americano di Roma del 1899 e legata ai documenti elaborati in quella sede e alle concessioni di Leone XIII, anche se alcuni, ancora dalla parte del potere, potevano riconoscersi nelle note di mons. Montes de Oca, segretario del Concilio: «Mentre la rivoluzione percorreva l’Europa, rovesciando gli altari, infrangendo i troni, tutta la Chiesa d’America, ignorando questi torbidi, serviva Dio e godeva del beneficio della pace. Non era più il mondo sconosciuto agli antichi e imbrattato di sacrifici umani. Da un mare all’altro, dal settentrione al mezzogiorno, si alzavano città e fortezze che, per il numero degli abitanti, la magnificenza dei palazzi, gareggiavano con le città di Spagna, di Francia e d’Italia. Le basiliche lucevano dello splendore dell’oro e dell’argento, udivano risuonare nelle navate il nome soave del vero Dio. Santuari insigni dedicati alla Regina del Cielo testimoniavano ovunque la pietà degli abitanti. Collegi numerosi, accademie, scuole, ospedali, monasteri, attestavano la liberalità dei pastori e del gregge. Le costosissime strade aperte in mezzo alle montagne alte e impervie dimostravano la vigilanza dei capi di Stato, molti dei quali furono vescovi. Ma un’opera più bella s’era compiuta: Cristo aveva vinto. Cristo regnava, Cristo governava. L’eresia era stata scacciata, l’idolatria quasi completamente spenta: a stento, fra tante centinaia di migliaia di abitati, se ne trovava qualcuno che non si dichiarasse cristiano e cattolico». [2]
Magari una Chiesa tutta tesa a frenare la spinta del socialismo, della massoneria, del protestantesimo, e a difendere fede e ortodossia con attenzione ai “benefici ecclesiastici”. Ormai, pur senza percorrere la strada dei Cristeros per rovesciare futuri poteri, dittature e forze militari capaci soltanto di tenere le popolazioni in permanente stato di miseria e di sottosviluppo, servendosi di sistemi oppressivi di sfruttamento basati sull’ingiustizia sociale e la violenza.
Cominciava ad emergere, a partire dalle “strutture sociali di base”, a sostegno degli oppressi, degli sfruttati, dei poveri,...
Indice dei contenuti
- Copertina
- La chiesa latino-americana e Oscar A. Romero
- Indice dei contenuti
- Prefazione
- Introduzione
- Parte I La Chiesa latino-americana. Nascita dell’America latina
- 1. America Latina, terra di contrasti
- 2. La Chiesa latino-americana nella prima e nella seconda metà del XX secolo: la nascita dell’America latina
- 3. La comunità ecclesiale di base, punto di riferimento per la catechesi, l’impegno sociale, un modo nuovo di essere Chiesa
- 4. La Chiesa latino-americana per la costruzione nell’America latina di una nuova società
- Parte II La Chiesa latino-americana prima di Romero I. Seconda Conferenza episcopale dell’America latina e dei Caraibi (Medellin, Colombia, 1968)
- 1. Verso Medellin, 1. La Chiesa e la questione sociale
- 2. Verso Medellin, 2. Per un equilibrio tra Nord e Sud del mondo
- 3. Verso Medellin, 3. Concilio Vaticano II, l’affaccio all’America latina
- 4. Verso Medellin, 4. Paolo VI, il Papa dell’America latina tra attese, speranze e interventi di moderazione
- 5. Medellin 1968. La II Conferenza episcopale
- 6. Il dopo Medellin di Paolo VI
- Parte III La Chiesa latino-americana prima di Romero II. La teologia della liberazione
- 1. Una riflessione a partire dall’esperienza
- 2. Rottura tra popolo e potere, processo di liberazione in tre livelli
- 3. Presa di coscienza della realtà latino-americana e “uomini nuovi”
- 4. “Salvezza dell’uomo” e “processo di liberazione”
- 5. Dalla “nulla salus extra Ecclesiam” alla “Chiesa sacramento visibile”
- 6. Fraternità e ricerca della giustizia oltre la lotta di classe
- 7. La teologia della liberazione tra provocazioni e compiti attuali
- Parte IV La Chiesa latino americana. O. A. Romero: la mediazione come destino e il martirio come testimonianza
- 1. Il parroco (1944-1967) San Miguel; (1967-1970), San Salvador, Segretario CEDES: vasto impegno pastorale e di servizio
- 2. Il vescovo (1970-1974), ausiliario del vescovo; San Salvador (1974-1977), vescovo di Santiago De Maria: due tempi, sempre fedele alla chiesa apostolica romana
- 3. L’arcivescovo (1977-1980). Tra difesa dei diritti umani, dimensione sacerdotale, approccio pedagogico
- 4. Il tempo di Puebla
- Parte V La Chiesa dell’America latina dopo Romero I tra criminalità (con morti, violenza e repressioni) e il magistero romano ostile alla teologia della liberazione
- Premessa
- 1. Gli anni che seguirono in El Salvador, e non solo
- 2. Il processo di canonizzazione di Romero e il magistero romano ostile alla teologia della liberazione
- Parte VI La Chiesa latino americana dopo Romero II. Nuova evangelizzazione
- 1. America latina, un continente sempre in fibrillazione
- 2. La IV Conferenza episcopale dell’America latina
- 3. La V Conferenza dell’episcopato latino americano. Aparecida: discepoli e missionari di Gesù Cristo affinché in lui abbiamo vita
- Appendice Romero, la voce di chi non ha voce messa a tacere nel sangue
- 1. Liberazione personale, comunitaria, trascendente. Omelia 23.3.1980
- 2. Il sangue per la nostra salvezza. Omelia 24.3.1980
- 3. La dimensione politica della fede in base all’opzione per i poveri. Un’esperienza ecclesiale nel Salvador, Lectio Magistralis, Università di Lovanio
- Bibliografia
- Indice dei nomi
- Collana il Calamo - La Storia