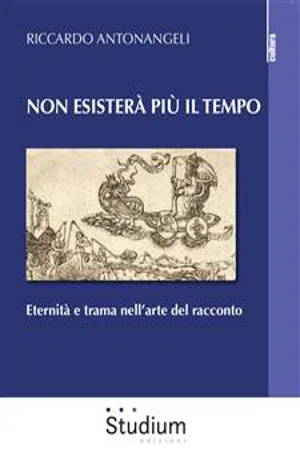La terza novella della decima giornata, quella di Natan e Mitridanes, non sembra aver mai posto particolari difficoltà interpretative. La sua esemplarità è disarmante, il messaggio morale evidente: donare la propria vita a chi la reclama è segno di una liberalità grandiosa e senza pari. Anche la trama ha la semplicità di una sentenza e si svolge lineare come una parabola. Protagonista della storia è un nobile del Cattaio – il Nord dell’attuale Cina – di nome Natan, il quale, «ricco senza comparazione» [1] , decide di farsi costruire un enorme e magnifico palazzo esattamente al crocevia tra Oriente e Occidente, affinché la sua generosità e la sua cortesia fossero conosciuti, nei fatti, dal maggior numero possibile di persone. Natan trascorre, così, gli anni a onorare e ospitare ogni viaggiatore bisognoso. Finché, un giorno, la fama della sua liberalità, ormai leggendaria in tutto il Levante e in quasi tutto il Ponente, non giunse all’orecchio del giovane Mitridanes. Invidioso che il vecchio fosse considerato più magnanimo di lui, Mitridanes inizia a fare «le più smisurate cortesie» [2] e in brevissimo tempo diventa anch’egli famoso. Senonché, un piccolo episodio, non conferma la superiorità di Natan in questa particolarissima gara a distanza. Una vecchia mendicante, infatti, si presenta al palazzo di Mitridanes e ottiene da questi l’elemosina per tredici volte. La stessa vecchiarella rinfaccerà poi a Mitridanes di essere avaro in confronto a Natan che, invece, le aveva fatto l’elemosina per ben trentadue volte. Non più capace di contenere l’invidia, il giovane decide, in un impeto d’ira, di recarsi da Natan e di toglierlo di mezzo con le proprie mani, una volta per tutte. Giunto in prossimità della sontuosa reggia, incontra, senza poterlo ovviamente ancora riconoscere, Natan in persona, e proprio a lui chiede indicazioni su come arrivare al palazzo. Natan, allora, lo accompagna verso casa e di nascosto raccomanda a tutti i suoi familiari di non chiamarlo mai per nome, continuando così a tenere nascosta la propria identità a Mitridanes, il quale a sua volta gli aveva chiesto di non far sapere a Natan del suo arrivo. I due entrano ben presto in confidenza e Mitridanes decide di rivelare, a quello che crede essere un semplice servitore, il suo «perverso intendimento» [3] . Non lasciando trapelare nessun segno d’emozione o sorpresa, Natan lo accompagna alla finestra e gli indica il boschetto poco lontano dove ogni mattina egli è solito passeggiare in solitudine e dove Mitridanes avrebbe potuto ucciderlo e poi dileguarsi non visto e indisturbato. L’indomani Mitridanes prende l’arco, si reca al boschetto, vi trova come previsto Natan, ma, proprio quando è sul punto di ucciderlo, riconosce la voce e il viso del servitore che l’aveva aiutato il giorno prima e allora lascia cadere il pugnale, ammettendo la grandezza irraggiungibile della liberalità di Natan e, allo stesso tempo, la colpevolezza della sua invidia. Natan non ha nessuna intenzione di vendicarsi e anzi offre comunque a Mitridanes la propria vita, questa volta in una forma diversa. Il vecchio infatti propone al giovane un curioso scambio d’identità: Mitridanes avrebbe vissuto al posto di Natan al palazzo, e quest’ultimo si sarebbe trasferito da Mitridanes, prendendone il nome. Riconoscendosi incapace di continuare nel solco dell’esempio di Natan e della sua liberalità, Mitridanes, sconfitto ma più saggio, rifiuta il dono e torna a casa.
In molti hanno notato una certa ambiguità nel personaggio di Natan, nella sua liberalità macchiata in fondo da una certa vanità e orgoglio [4] . Quel desiderio che la sua generosità venga ovunque riconosciuta fa venire il sospetto legittimo che il suo altruismo non sia altro che una strategia di potere, e l’autodisciplina e la generosità un modo sottile per rendere chi riceve proprio schiavo e debitore. D’altro canto, il desiderio di emulazione di Mitridanes, renderebbe Natan una sorta di figura Christi il cui esempio è ispirazione per un innalzamento spirituale verso la virtus assoluta. La sottomissione a Natan ha così un valore duplice: controllo delle passioni da parte dell’intelletto, certo, ma anche mantenimento dello status quo con l’allievo che non supera il maestro. La fama di Natan è un exemplum ambiguo perché ispira simultaneamente alla salvezza e alla perdizione, alla liberalità e all’invidia, a dare in dono la propria vita e a sottrarre quella altrui.
Tutto questo è senz’altro vero, tuttavia, credo che la novella contenga un paio di punti che invitano a un’indagine ulteriore, lungo vie per ora poco, o per niente, battute dalla critica. Oltre che avere radici nella narrativa d’area arabo-semitico-indiana, la novella ha ambientazione, respiro e protagonisti orientali. È seguendo a ritroso la traccia di queste origini che un senso ulteriore della storia potrà essere trovato. L’ambientazione, infatti, non è semplice sfondo o mera ispirazione della materia trattata, ma è segno di una determinata interpretazione del mondo che nel corso della ‘rinascita’ del XII secolo arrivò in Occidente insieme alle prime traduzioni dall’arabo al latino del corpus aristotelico, di trattati scientifici, matematici, astronomici e anche di raccolte di racconti e sentenze. La trama di Natan e Mitridanes è un esempio del dialogo intessuto tra questo sapere dissepolto dal passato e giunto da terre lontane e il sistema del mondo occidentale cristiano. Il tema centrale della novella è, difatti, non tanto la liberalità di Natan, quanto il Tempo e la coscienza che Natan e Mitridanes ne hanno. Il loro diverso modo di intendere la generosità e la cortesia è il segno di un diverso intendere il tempo, e il rapporto tra l’uomo e il divenire, la morte, la vanità delle cose subì un profondo rinnovamento proprio in seguito all’opera di traduzione del sapere astronomico e astrologico dall’arabo in latino, e successivamente in volgare. Insieme alla sapienza fisica e matematica, arrivarono per la prima volta nel Medioevo latino anche raccolte di racconti, sentenze, exempla che influenzarono in maniera decisiva la storia del romanzo europeo, funzionando da fonte, sia di argomenti che di strutture narrative, per il Decameron. È nell’ambito di questa vera e propria rivoluzione che scienza, narrazione, teologia e metafisica s’intrecceranno – in modo ancora nuovo rispetto all’epoca classica e alla tarda antichità dei padri della chiesa – proprio intorno ai misteri del tempo, dell’eternità, della creazione, della fortuna e del libero arbitrio. Nei racconti d’ispirazione araba del Decameron si potrà, pertanto, trovare autore, eroe e trama legati secondo configurazioni e leggi nuove, in un sistema narrativo che imita il rinnovato porsi e inquadrarsi dell’uomo all’interno dell’universo, il rapporto tra individuo e astri, microcosmo e macrocosmo, volontà umana e divina, necessità e contingenza, causa ed effetto. Con le storie l’uomo misura il tempo, e la coscienza e la definizione del tempo dopo il XII secolo subiranno profondi mutamenti anche con il graduale affermarsi della società mercantile e della logica temporale che va di pari passo sviluppandosi con essa in alternativa al tempo scandito dalla Chiesa e dai suoi campanili [5] .
Il tempo nella novella di Natan e Mitridanes compare innanzitutto nella forma del rapporto padre-figlio che si instaura tra i due. Natan si rivolge a Mitridanes con «figlioul mio» [6] mentre più avanti il narratore sottolineerà che Mitridanes riverisce Natan «come padre» [7] e poi ancora «carissimo padre» [8] . I due appartengono a età e generazioni diverse, tant’è che mentre Natan è «d’anni pieno» [9] , Mitridanes è «giovane» [10] . La differenza generazionale si riflette anche nell’istintività che contraddistingue l’agire di Mitridanes. In quanto giovane egli è letteralmente sottomesso ai capricci delle passioni che pervertono la via della rettitudine segnalata invece dalla ragione. Così, dopo aver scoperto di aver perso trentadue a tredici la partita dell’elemosina, Mitridanes è preso da «rabbiosa ira» [11] , e poi «senza alcuno indugio» [12] sarà preda di un «impeto» [13] di vendetta omicida. Il suo desiderio di uccidere Natan è un «perverso intendimento» perché Mitridanes ha fretta, non vuole perder tempo. Al contrario Natan agisce «cautamente» [14] e «con fermo viso» [15] sarà capace di mascherare e soffocare il moto delle passioni quando Mitridanes gli confesserà il desiderio occulto di ucciderlo. A un livello ulteriore il rapporto tra i due è, oltre che padre-figlio e vecchio-giovane, anche quello tra un maestro e un suo allievo, un elemento quest’ultimo che, come vedremo, rimanda alla provenienza arabo-indiana della novella. Se in ciascuna di queste tre combinazioni Natan si dimostra superiore a Mitridanes, ovvero per magnificenza, temperanza e sapienza, oltre a sopravanzarlo in quanto padre putativo, in una cosa Mitridanes batte Natan: è più giovane, per natura più lontano del vecchio dalla morte. Bisogna tenere questa considerazione, tanto banale quanto decisiva, bene a mente perché è partendo da essa che una nuova lettura della novella sarà ora possibile. Il centro del racconto è rappresentato da una scena di riconoscimento che è una delle forme estetiche che l’uomo ha dato all’enigma del tempo, cercando così di renderlo percepibile e in qualche modo rappresentabile. L’ anagnorisis infatti è il punto in corrispondenza del quale il passato si rivela come presente e ciò che era morto sembra risorgere [16] . La scena, in questo caso, è preceduta da un altro episodio, quello dell’incontro per strada, che non è un vero e proprio riconoscimento tragico, ma un misconoscimento se vogliamo, proprio perché i due non si sono mai visti prima e solo Mitridanes conosce l’altro, se non di persona, almeno per fama. Non lo riconosce perché Natan non sfoggia la sua ricchezza ma, al contrario, va in giro come il più umile dei servitori. Il giovane si dimostra incapace di vedere oltre le apparenze, lasciandosi ingannare dalle sensazioni. Infatti, uno degli insegnamenti che ricaverà da tutta questa storia, sarà il saper guardare le cose con l’occhio dell’intelletto. L’ anagnorisis vera e propria avverrà più avanti, quando, questa volta sì, Mitridanes riconoscerà nell’umile servo il suo padrone. La trama, però, non finisce qui, non si esaurisce dopo l’anagnorisis e dopo che Mitridanes lascia cadere il coltello rinunciando così alla vita di Natan, ma continua, e al primo tentativo di ‘dono’ della vita se ne aggiunge un altro, a dir poco strano, nella forma del cambio d’identità. Ma andiamo con ordine.
Innanzitutto, bisogna chiedersi perché Natan non si faccia uccidere subito, immediatamente, da Mitridanes una volta che questi gli ha rivelato l’intenzione di ucciderlo. Il motivo è presto detto: perché altrimenti la storia finirebbe lì, la trama arriverebbe alla sua fine prima del tempo, con un impeto e una perversità che rifletterebbero, perciò, la precipitazione con cui Mitridanes vuole esaudire il suo desiderio. La prosecuzione della trama diventa, allora, ancora più importante di quella che, in quanto anagnorisis tragica, dovrebbe essere il climax di tutta la breve narrazione. Il ritardo e la rinuncia di Natan a dimostrare lì per lì, subito, sul momento, la sua liberalità sono segni che il dono che egli intende fare a Mitridanes va al di là della sua vita, altrimenti non si farebbe sfuggire l’occasione propizia che il caso gli presenta anzitempo. C’è qualcosa che lo frena, che gli viene meno e tutto lo fa cambiare in quegli istanti subito successivi alla confessione del segreto di Mitridanes. L’atroce dilemma interiore si risolve in pochi attimi e, «senza troppo stare» [17] , Natan decide di non donare subito la propria vita ma di aspettare il giorno dopo. A questo punto fa un gesto in apparenza trascurabile: mostra attraverso una finestra dove l’indomani l’agguato potrà consumarsi liscio e senza impedimenti. Il luogo è un parco poco lontano dove Natan, ogni mattina, «va tutto solo prendendo diporto per ben lungo spazio» [18] . La mattina dopo Natan, non cambia idea e «se n’andò al boschetto a dover morire» [19] . I paragrafi dal 20 al 25 sono compresi tra l’occasione decisiva che sfugge a Natan dopo la confessione e questo «dover morire»in quel boschetto dove «per lungo spazio»egli, ogni giorno, è solito passeggiare. Si potrebbe quasi dire che nel breve arco di questi paragrafi Natan scelga tra la morte immediata e il morire, tramuti cioè l’istante in un lasso di tempo più lungo, spazializzando così il momento della verità, il kairós dell’opportunità non colta al volo. Per di più Natan mostra il luogo attraverso una finestra: il passaggio dalla morte al morire è raffigurato dallo spartiacque della finestra, attraverso cui l’attimo si trasforma in spazio, il tempo da qualità diviene quantità, proprio grazie a una messa in prospettiva che mette nuova distanza tra Natan e la morte, dilata e differisce la crisi. Il boschetto è un locus amœnus, un luogo tradizionalmente distaccato dal mondo e dallo scorrere del suo tempo. Si può dire che in miniatura esso rispecchi il giardino della cornice dove, per l’appunto, la brigata si è rifugiata per sfuggire alla peste e dunque alla propria mortalità. Ma sui rapporti stretti tra questo racconto, e anche, in generale, tra tutti quelli dell’ultima giornata, e la cornice del Decameron, torneremo più avanti. Per il momento basterà trattenere l’immagine di un morire che ritarda e calma l’impeto repentino di Mitridanes. È questo anche il signif...