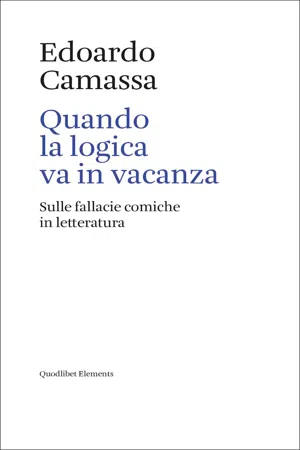III.
Piccola antologia portatile
D’ora in poi esaminerò e commenterò una rosa di fallacie comiche in letteratura. La scelta sarà guidata dal principio di varietà: sia nel senso che i ragionamenti ridicoli saranno tratti da epoche, generi, lingue e culture differenti (anche se con una certa prevalenza della narrativa e del teatro europei moderni e contemporanei); sia nel senso che cercherò di offrire almeno un esempio per ogni fallacia tra quelle menzionate nel precedente capitolo. Naturalmente, per ragioni di economia del discorso, mi soffermerò su brevi campioni testuali e limiterò il commento a poche osservazioni. Soprattutto rinuncerò alla pretesa di rendere conto dell’enorme bibliografia esistente sui testi di cui mi accingo a parlare. Ma cominciamo.
1. Nel secondo agone delle Nuvole di Aristofane (423 a.C., ma la redazione della commedia che noi leggiamo è databile intorno al 420 a.C.), Fidippide prende a botte il vecchio padre Strepsiade dopo aver avuto con lui una piccola querelle sugli antichi e i moderni. Non contento, si adopera per convincerlo di aver fatto la cosa giusta nel picchiarlo, sfruttando le armi dialettiche che ha appreso alla scuola di Socrate. Tra i vari sofismi pronunciati da Fidippide il più celebre è senz’altro questo: «tu dirai che è consuetudine, le botte toccano ai bambini; al che io risponderò così: “I vecchi? Due volte bambini”» (vv. 1416-1417). Proviamo a riscrivere l’argomentazione di Fidippide sotto forma di sillogismo. Premessa maggiore: «si è soliti picchiare i bambini». Premessa minore: «ma, stando al detto, i vecchi sono due volte bambini». Conclusione (implicita): «dunque è più che mai giusto prendere a botte i vecchi». Ci troviamo di fronte a una fallacia informale, di rilevanza; la premessa minore non ha infatti nessuna attinenza col resto del ragionamento. Più in particolare, abbiamo una fallacia che sta a metà strada tra l’argumentum ad verecundiam e quello ad antiquitatem: «un motto tramandato vuole che le cose stanno così, pertanto stanno così». Si sente che l’atteggiamento di Aristofane nei confronti di questa fallacia è ambiguo, tanto più in quanto essa gli consente di esprimere la propria posizione ancipite rispetto al passato e all’attualità. Da un lato l’argomentazione di Fidippide suona come una giustificazione posticcia al piacere di aggredire e umiliare Strepsiade, richiama la proverbiale “pezza peggiore del buco”. È insomma inequivocabilmente illogica e finisce col trascinare con sé nel ridicolo sia la tradizione cui la massima antica appartiene (nel suo commento al passo, Dover nota che formule molto simili a «δὶς παῖδες οἱ γέροντες» ricorrono in drammaturghi anteriori ad Aristofane), sia quel relativismo filosofico che si finge à la page ma non disdegna di far leva all’occorrenza sui relitti del passato pur di portar acqua al proprio mulino. Dall’altro lato, però, il ragionamento di Fidippide è rappresentato come a conti fatti trionfante e la sua vittoriosa affermazione permette ad Aristofane di fornire un’immagine mitico-utopica del mondo, in cui il tempo anziché scorrere in modo lineare può andare felicemente all’indietro, circolarmente (il vecchio, come accade anche per esempio nei Cavalieri e nelle Vespe, può ringiovanire; il giovane può svolgere le funzioni del vecchio). Ma c’è di più. Nel sancire il successo del Discorso Peggiore, Aristofane in fondo strizza l’occhio agli esponenti delle nuove élite intellettuali – i filosofi naturalisti, i sofisti, Socrate –, con cui il poeta condivide il disprezzo per l’Ateniese medio, ignorante e meschino, perfettamente rappresentato da Strepsiade. In questa prospettiva, si può e si deve dire che il vecchio padre sciocco sotto sotto si merita di subire oltre al danno la beffa.
2. Esaminiamo ora l’atto quarto, scena seconda, dell’Epidicus di Plauto (190 a.C. circa). Il vecchio Perifane ha appena scoperto di essere stato imbrogliato dal servo Epidico: Acropolistide non è veramente propria figlia, come gli era stato fatto invece credere. A questa altezza Perifane chiede una spiegazione alla ragazza: «perché mi hai ingannato chiamandomi padre?». E Acropolistide, per tutta risposta: «Perché non ti dovrei chiamare padre, se tu mi definisci come figlia?» (v. 588). Come in Aristofane, anche in Plauto si incontra una fallacia informale di rilevanza. Sennonché stavolta ad essere mobilitati non sono gli argumenta ad verecundiam e ad antiquitatem, bensì l’argumentum ad hominem nella forma tu quoque. Ecco in cosa consiste questa fallacia: rispedire la critica al mittente, visto che anche lui in passato ha commesso lo sbaglio che biasima, senza considerare il fatto che due errori non fanno una cosa giusta. Al di là della facciata logica, la premessa di Acropolistide («ma sei tu che mi hai chiamato figlia!») può sembrare un paralogismo, una svista dialettica dettata dall’ingenuità. La ragazza però finge di non saper maneggiare la logica, di prendere lucciole per lanterne. In realtà il suo è un sofisma bello e buono; a fortiori perché viene pronunciato da una meretrice, che per giunta solo sedici versi dopo sarà paragonata a Circe, l’ingannatrice par excellence. Ma dietro lo schermo della comicità e della finta inesperienza dialettica si affaccia una verità solo apparentemente scontata: per i rapporti familiari vale tanto il principio che nomina sunt consequentia rerum quanto il simmetrico per cui res sunt consequentia nominum. In altri termini, la parentela si definisce non solo su base biologica, ma anche su base culturale-linguistica. Anzi, sembra suggerire Acropolistide, le parole contano persino più del nudo fatto biologico in quanto creano ex nihilo legami parentali: «Il fatto stesso che tu mi abbia chiamata “figlia” fa di me tua figlia, sicché è giusto che io ti chiami e riconosca come padre». Da questa angolatura, il riso si ritorce contro Perifane e il suo pragmatismo, la sua incapacità di andare oltre i rapporti di sangue. «Le parole sono importanti!», verrebbe da dire, prendendo a prestito una celebre battuta di Moretti. Non è dunque un caso se il verso di Plauto ha per baricentro simbolico il parallelismo fra te nominem e me appelles.
3. Nella sesta novella della sesta giornata del Decameron (scritto intorno al 1350), Boccaccio cede la voce a Fiammetta, che a sua volta racconta di come un tale Michele Scalza sbaraglia tutti gli avversari in una gara dialettica. Alcuni giovani maremmani stanno discutendo su quale sia la famiglia nobiliare più antica di Firenze: gli Ubaldi? i Lamberti? o altri ancora? A questo punto interviene Scalza: «la famiglia nobiliare più antica, non solo di Firenze ma di tutto il mondo, sono i Baronci». Per dimostrare la propria tesi, Scalza assume dapprima che «quanto gli uomini son più antichi, più son gentili». Quindi chiede ai suoi interlocutori di ripensare ai visi dei Baronci: non sono forse così sproporzionati e deformi da ricordare degli scarabocchi? «Per che […] assai bene appare che Domenedio gli fece quando apparava a dipignere, sì che essi son più antichi che gli altri e così più gentili». L’argomentazione è assurda da cima a fondo, perché si regge su due fallacie formali, induttive in senso debole, analogiche. In senso figurato gli uomini possono essere disegni divini, così come Dio può essere un pittore nel linguaggio metaforico; prendere alla lettera, e nel modo più grossolano possibile, questi paragoni (equiparare cioè i Baronci a degli sgorbi, ma soprattutto confrontare l’entità per definizione massimamente perfetta con un apprendista pittore un po’ incompetente) significa però incorrere ripetutamente nell’analogia debole. A tutta prima si ride del ragionamento che non regge e della leggerezza con cui vengono pronunciate malignità così taglienti. Tuttavia, nel proporre questa fallacia e presentarla come vincente, Boccaccio coglie pure il destro per fare i conti – attraverso il proprio personaggio e servendosi dei mezzi del comico – con i temi della volontà divina, della fortuna e dell’ingegno umano. In primo luogo, è falso che la fortuna dipende dalla Provvidenza e ha perciò un disegno preciso (come sostiene invece Virgilio in Inferno, VII, vv. 67-96). Vale semmai il contrario: la mano del Dio creatore, lungi dal governare il corso degli eventi è in realtà soggetta – come avviene per un qualsiasi artigiano – alle leggi dell’apprendimento artistico (il miglioramento progressivo, graduale); quindi le grazie e disgrazie degli uomini riflettono il grado di competenza artistica – del tutto accidentale – raggiunto da Dio, sono in definitiva frutto del caso. In secondo luogo, solo l’ingegno può elevarsi al di sopra della fortuna. Prova ne è che Scalza può farsi beffe dei pasticci di Dio e della sorte, oltre che ribaltare la contesa a proprio vantaggio guadagnandosi una cena gratis, perché ha escogitato appunto un sofisma sottile e brillante.
4. L’Epicureus (1533) è l’ultimo dei Colloquia di Erasmo, e Edonio cerca di dimostrare a Spudeo che il buon cristiano è in assoluto il miglior seguace di Epicuro. Peccato solo che, per sostenerlo, si serva di una caterva di argomentazioni scorrette. Limitiamoci a queste due: «Non c’è cosa più misera della cattiva coscienza»; «Se non c’è cosa più misera della cattiva coscienza, ne segue che non c’è cosa più felice della buona coscienza». La prima è una fallacia informale di rilevanza e per la precisione un argumentum ad verecundiam: la premessa maggiore del ragionamento è tratta da Plauto («nihil est miserius quam animus hominis conscius»: Mostellaria, atto terzo, scena prima, v. 544), benché questi non abbia alcuna autorità in materia di filosofia o di religione. La seconda è invece una fallacia formale deduttiva, nota come negazione dell’antecedente: ammesso e non concesso che avere una cattiva coscienza renda miseri, ne conseguirà che se si è felici si ha una buona coscienza (per modus tollens) e non che una buona coscienza rende felici. È evidente, qui come altrove, che Edonio fa un pessimo uso della dialettica e si copre perciò stesso di ridicolo; meglio: che si muove nei meandri della logica come fa un elefante in una cristalleria. Ma è altrettanto chiaro che è proprio con Edonio che Erasmo e i suoi lettori in fondo si identificano. Come si spiega questo fatto? Perché Edonio non convince appieno, però conquista lo stesso? Probabilmente perché nonostante i propri errori, e anzi in virtù di essi, si fa portavoce di due istanze contrastanti ma legittime. Da una parte canzona – proprio lui, l’epicureo! – i cristiani, troppo presi dai piaceri carnali per dedicarsi alla vita spirituale e all’imitatio Christi (tra i vari paralogismi di Edonio ce n’è uno in cui si afferma che i cristiani letteralmente sguazzano nei piaceri e vivono più beati di Sardanapalo). Dall’altra rivendica – un po’ come fa Vegio nel De vero bono di Valla, anche se in modo non altrettanto serio –, sempre contro i cristiani, un qualche diritto dell’uomo al piacere e alla felicità terreni (all’inizio del dialogo, vedendo che Spudeo sta leggendo il trattato ciceroniano De finibus bonorum, Edonio se ne esce con questa boutade: «Non sarebbe meglio cercare l’inizio dei beni, anziché la fine?»).
5. Spostiamoci adesso alla prima parte dell’Henry the ivth di Shakespeare (composto tra il 1596 e il 1597) e per l’esattezza all’atto...