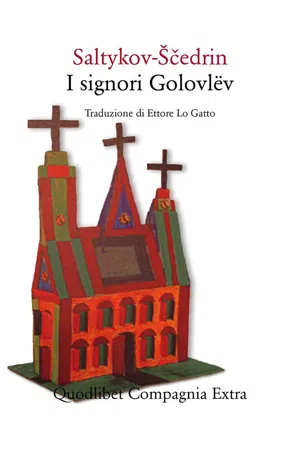I.
Consiglio di famiglia
Un giorno l’amministratore di una lontana tenuta, Anton Vasil’ev, aveva terminato di riferire alla padrona, Arina Petrovna Golovlëva, sul suo viaggio a Mosca, fatto per riscuotere i canoni dai suoi contadini che vivevano là con passaporto speciale, e aveva già avuto da lei il permesso di ritirarsi, quando a un tratto si fermò dubbioso, come se avesse ancora qualche cosa da riferire e non si decidesse.
Arina Petrovna, che capiva a perfezione non solo i più piccoli movimenti, ma anche i segreti pensieri della gente che le era vicina, si turbò subito.
– Che c’è ancora? – domandò guardando fisso il suo podestà.
– È tutto, signora – tentò di sganciarsi Anton Vasil’ev.
– Non mentire, c’è qualcosa d’altro! Te lo leggo negli occhi.
Anton Vasil’ev tuttavia non si decideva a rispondere e continuava a poggiarsi ora su un piede ora sull’altro.
– Su, che cosa ancora hai da dire? – gridò Arina Petrovna con voce decisa. – Parla, non confonderti… bisaccia di imbrogli!
Arina Petrovna amava appiccicar soprannomi ai componenti il suo personale amministrativo e domestico. Ad Anton Vasil’ev aveva dato quel soprannome di «bisaccia di imbrogli» non perché egli si fosse realmente macchiato di imbrogli, ma perché era facile alle chiacchiere. La tenuta da lui amministrata aveva come centro un importante villaggio sede di mercato nel quale c’era gran numero di trattorie. Ad Anton Vasil’ev piaceva molto andare a prendere il tè in trattoria, e di vantare l’onnipotenza della sua padrona, e durante le sue fanfaronate, senza accorgersene, finiva col mentire. E, poiché Arina Petrovna aveva sempre in corso diverse cause giudiziarie, accadeva spesso che le chiacchiere del suo uomo di fiducia scoprissero le astuzie strategiche della padrona, prima ancora che potessero essere realizzate.
– C’è, difatti… – balbettò finalmente Anton Vasil’ev.
– Che cosa? Che cosa c’è? – incalzò Arina Petrovna.
Donna autoritaria e dotata per di più di una forte immaginazione si era sull’istante rappresentata il quadro delle varie contrarietà e contraddizioni e si era di colpo fermata su questa idea con tale violenza da impallidire e sobbalzare perfino sulla poltrona.
– Stepan Vladimiryč ha venduto la casa a Mosca… – riferì l’amministratore, trascinando le parole.
– Davvero?
– L’ha venduta, signora.
– Perché? Come? Non impappinarti, racconta!
– Per i debiti… bisogna ritenere che sia così! Non si vende mica quando le cose vanno bene.
– Vuoi dire che gliel’ha venduta la polizia? Il tribunale?
– Pare che sia così. Dicono che la casa è andata all’asta per ottomila rubli.
Arina Petrovna cadde pesantemente nella poltrona e volse gli occhi alla finestra. Evidentemente, sul primo momento, questa notizia le aveva tolto la coscienza. Se le avessero detto che Stepan Vladimiryč, il suo figlio maggiore, aveva ucciso qualcuno, che i contadini di Golovlëvo si erano ribellati rifiutando di dare il loro lavoro o che la servitù della gleba era stata abrogata, non sarebbe rimasta più sbigottita. Le tremavano le labbra, gli occhi guardavano chissà dove in lontananza, senza vedere nulla. Non aveva nemmeno notato che in quello stesso momento la giovane serva Dunjaša era entrata e, nascondendo qualcosa sotto il grembiule, era corsa impetuosamente davanti alla finestra, ma accortasi della presenza della padrona, si era rigirata sul posto tornando senza rumore indietro (fatto che in altri momenti sarebbe bastato a provocare una minuziosa inchiesta). Alla fine però si riprese e mormorò:
– Che consolazione davvero!
Dopo di che trascorsero alcuni minuti di minaccioso silenzio.
– Dunque tu dici che la polizia ha fatto vendere la casa per ottomila? – domandò.
– Sì, signora.
– Ed era la benedizione paterna… Un bel… mascalzone!
Arina Petrovna sentiva che in considerazione della notizia avuta doveva prendere una decisione immediata, ma non riusciva a concepire un’idea precisa; i pensieri le si confondevano muovendosi in direzioni opposte. Da una parte pensava: «Ha venduto la polizia! Però non l’ha venduta da un momento all’altro! Vuol dire che c’è stato il sequestro, la stima e poi hanno pubblicato il bando. Ha venduto per ottomila, mentre io due anni fa per la stessa casa, con le mie proprie mani, ne ho sborsati dodicimila come fosse una copeca! Se l’avessi saputo avrei potuto acquistarla io all’asta per ottomila!». D’altra parte le veniva in mente anche questo: «Ha venduto la polizia per ottomila! Ed era la benedizione paterna! Farabutto! Ha mollato la benedizione paterna per ottomila!».
– Da chi l’hai sentito? – domandò poi, fermandosi definitivamente sul pensiero che la casa fosse già stata venduta e che per conseguenza la speranza di riacquistarla a buon prezzo fosse ormai perduta per sempre.
– L’ha detto l’oste Ivan Michajlov.
– E perché non mi ha avvertita in tempo?
– Si vede che aveva paura.
– Aveva paura! Ecco, gliela faccio vedere io, «aveva paura»! Fallo venir da Mosca e quando si presenterà mandalo subito all’ufficio di reclutamento e fagli radere i capelli! Aveva paura!
La servitù della gleba, per quanto fosse agli estremi, esisteva ancora. Spesso capitava ad Anton Vasil’ev di udire dalla padrona gli ordini più originali, ma l’attuale decisione era così inaspettata che fece rimanere perplesso perfino lui. L’appellativo di «bisaccia di imbrogli» gli tornò involontariamente alla memoria. Ivan Michajlov era un contadino assennato, a proposito del quale non poteva nemmeno pensarsi che potesse accadergli una disgrazia. Inoltre era suo amico e compare; improvvisamente, proprio lui doveva essere arruolato, solo perché lui, Anton Vasil’ev, come «bisaccia di imbrogli», non era riuscito a trattener la lingua.
– Vogliate perdonare… Ivan Michajlov! – cercò di intercedere Anton Vasil’ev.
– Vattene… manutengolo – gli gridò Arina Petrovna con tale voce che egli non tentò neppure di insistere sull’ulteriore difesa di Ivan Michajlov.
Ma, prima di continuare il mio racconto, prego il lettore di fare una più stretta conoscenza di Arina Petrovna Golovlëva e della sua situazione familiare.
Arina Petrovna era una donna sulla sessantina, ma ancora in gamba e abituata a vivere con tutta la sua libertà. Aveva sempre un’aria minacciosa; amministrava dispoticamente e senza controllo l’immensa tenuta di Golovlëvo; viveva appartata, economizzando, quasi con avarizia; non manteneva rapporti coi vicini; cercava la benevolenza delle autorità locali, e dai suoi figli esigeva una tale obbedienza da indurli a chiedersi in tutto quel che facevano: «Che cosa ne dirà la mammina?». In generale aveva un carattere indipendente, inflessibile e quasi aggressivo, il che dipendeva in parte dal fatto che in tutta la famiglia dei Golovlëv non v’era nessuno che potesse contraddirla. Suo marito era un uomo leggero, ubriacone (Arina Petrovna diceva volentieri che lei non era né vedova né donna maritata); i figli in parte erano impiegati a Pietroburgo e in parte avevano seguito le orme del padre e, nella loro qualità di «svergognati», non avevan voce nelle faccende familiari. In tali condizioni, Arina Petrovna si era sentita assai presto sola e, a dire il vero, si era ormai disabituata dalla vita familiare, sebbene la parola «famiglia» fosse sempre sulla sua lingua e in apparenza tutte le sue azioni fossero rivolte, con ostinata cura, solo all’arrangiamento delle faccende familiari.
Il capo famiglia, Vladimir Michajlyč Golovlëv, era noto già dalla giovinezza per il carattere scioperato e stravagante e non aveva mai rappresentato nulla di simpatico per Arina Petrovna, che si distingueva sempre per la sua serietà e attività. Viveva una vita vuota ed oziosa: di solito si chiudeva nel suo studio e imitava il canto dell’allodola, del gallo e di altri uccelli, applicandosi poi alla composizione dei cosiddetti «versi liberi». Nei momenti di intimità soleva vantarsi di essere stato amico di Barkov, il quale lo aveva addirittura benedetto sul letto di morte. Arina Petrovna non aveva mai ammirato i versi di suo marito: li chiamava porcherie e pagliacciate; e, poiché Vladimir Michajlyč si era sposato appunto per aver sempre sottomano un’ascoltatrice dei suoi versi, si capisce che i dissapori non si erano fatti aspettare a lungo. Le discussioni, che si erano fatte sempre più prolungate e violente, si concludevano, da parte della moglie, con una assoluta e sprezzante indifferenza per il marito buffone; da parte di quest’ultimo invece, con un sincero odio in cui entrava una buona dose di pusillanimità verso la moglie. Il marito chiamava la moglie «strega e demonio»; questa chiamava lui «mulino a vento» e «balalajka senza corde». In tali rapporti avevano trascorso e trascorrevano la loro vita comune che durava da oltre quarant’anni, e mai, né all’una né all’altro, era venuto in mente che una simile vita aveva in sé qualcosa che andava contro natura. Col passar del tempo, la sfrontatezza di Vladimir Michajlyč non era diminuita, aveva anzi acquistato un carattere più volgare. Indipendentemente dalle esercitazioni in versi nello spirito di Barkov, egli aveva cominciato a bere e a dar volentieri la caccia lungo i corridoi alle ragazze di servizio. Dapprima Arina Petrovna aveva considerato questa nuova occupazione del marito sprezzantemente e perfino con turbamento (nel quale, comunque, l’abitudine al potere rappresentava una parte molto più importante della gelosia); ma poi, con un gesto d’indifferenza, l’aveva lasciato fare, badando solo a che le ragazze non gli portassero l’infusione d’acquavite per eccitarlo. Da allora, convintasi una volta per sempre che suo marito non era per lei un compagno, ella a...