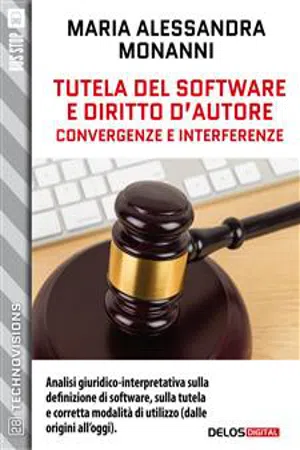
Tutela del software e diritto d'autore. Convergenze e interferenze
- Italian
- ePUB (disponibile su mobile)
- Disponibile su iOS e Android
Tutela del software e diritto d'autore. Convergenze e interferenze
Informazioni su questo libro
Tecnologia - saggio (317 pagine) - L'obiettivo del presente testo è quello di comprendere, in un avvicendarsi di interferenze e convergenze, come agire e come proteggere il software in funzione della sua peculiare struttura costituita da due elementi, tecnologico (che ne definisce la sua applicazione pratica) e descrittivo (che ne definisce la sua forma espressiva), assumendo quindi un articolato dibattito dottrinale sulla dicotomia diritto d'autore/brevetto rispetto al dualismo forma/contenuto
Lo sviluppo delle nuove tecnologie informatiche e la loro diffusione hanno condotto dottrina e giurisprudenza a dover misurarsi con nuovi istituti e categorie giuridiche, a dover trovare una propria collocazione giuridica al fine di poter sviluppare un'adeguata disciplina di protezione nell'ambito della Proprietà intellettuale. Oggetto dell'analisi è il software, ossia quella "creazione intellettuale" che in quanto tale per essere giuridicamente protetta dovrebbe essere sottoposta ad una tutela ben definita. L'obiettivo del presente testo è quello di comprendere, in un avvicendarsi di interferenze e convergenze, come agire e come proteggere il software in funzione della sua peculiare struttura costituita da due elementi, tecnologico (che ne definisce la sua applicazione pratica) e descrittivo (che ne definisce la sua forma espressiva), assumendo quindi un articolato dibattito sulla dicotomia diritto d'autore/brevetto rispetto al dualismo forma/contenuto: è possibile una "complementarietà" delle due tutele?
Abbiamo assistito sino ad oggi ad un cambiamento della tecnologia e dell'utilizzo del software che ha comportato il passaggio graduale da una tecnologia analogica ad una tecnologia digitale, secondo diverse modalità di distribuzione delle opere dell'ingegno e diverse forme di controllo ed esecuzione. In seguito quindi allo sviluppo sempre crescente della tecnologia informatica (che comprende gli apparecchi digitali e i programmi software) e telematica (che si esprime nelle reti telematiche), il cui compito è di adempiere alla crescita della conoscenza e allo sviluppo delle capacità umane, la dottrina si è assunta l'incarico di studiare ed interpretare il tema del software, di Internet e della Rete. Le nuove tecnologie informatiche e di telecomunicazione costituiscono i due pilastri su cui si regge la cosiddetta Società dell'Informazione.
Maria Alessandra Monanni: Legal Specialist in Proprietà Intellettuale, Copywriter e Blogger – Laurea magistrale in Scienze Politiche e Laurea triennale in Giurisprudenza, con master di specializzazione in Diritto della Proprietà Intellettuale, dopo anni di lavoro dipendente – durante il quale si è occupata in particolare di Proprietà industriale e intellettuale nel settore dei brevetti e ha vissuto un'esperienza anche nel settore dei marchi – ha voluto unire la sua passione per la comunicazione e il marketing con il patrimonio di esperienza e conoscenza professionale acquisita nel tempo, al suo amore per la scrittura. La vera espressione di questa creatività è il suo blog www.sandyeilweb.com dove condivide emozioni e importanti spunti di riflessione sul mondo del web e delle nuove tecnologie allo scopo di tutelare i nostri diritti e sfruttare al meglio le potenzialità. Collabora come autore con SPRINT – Sistema di Proprietà Intellettuale – una banca dati giuridica e portale di informazione quotidiana sulla Proprietà Industriale e Intellettuale e con FAIRPLAY – Antitrust, Mercato, Consumatori – una banca dati giuridica e portale di informazione quotidiana.
Tools to learn more effectively

Saving Books

Keyword Search

Annotating Text

Listen to it instead
Informazioni
1. La nozione giuridica del software
Indice dei contenuti
- Copertina
- Technovisions
- Tutela del software e diritto d'autore. Convergenze e interferenze
- Colophon
- Indice
- Il libro
- L'autrice
- Citazione
- Introduzione
- I. Premesse definitorie
- 1. La nozione giuridica del software
- 2. Il contratto di licenza d’uso del software e il contratto di compravendita
- 2.1. Il contratto di licenza d’uso e la relativa disciplina contrattuale
- 2.2. Le Licenze libere
- 2.3. La compravendita
- 2.4. Le altre tipologie di contratti legati al software
- 3. Il principio di esaurimento del diritto e sua applicazione
- II. Tutela giuridica del software
- 1. I profili legislativi sulla tutela del software nell’ordinamento internazionale, comunitario e nazionale.
- 1.1. L’evoluzione normativa internazionale: «jus conventionis»
- 1.2. L’evoluzione normativa comunitaria e nazionale sul diritto d’autore
- 2. Il software nella dottrina e nella giurisprudenza.
- 2.1. La tutela del software nella dottrina
- 2.2. La tutela giuridica del software nella giurisprudenza.
- 3. L’inquadramento giuridico del software
- 3.1. Il brevetto e il diritto d’autore messi a confronto
- 3.2. L’ipotesi per una «tutela giuridica complementare»
- III. Principio dell’esaurimento del diritto
- 1. La tutela del software nell’Unione Europea: causa C-128/11 Oracle/UsedSoft (CGUE Sentenza 3 luglio 2012) e principio dell’esaurimento del diritto.
- 1.1. La sentenza 3 luglio 2012, causa n. C-128/11: concetti chiave.
- 1.2. Il principio di esaurimento del diritto: interpretazione restrittiva o estensiva
- 1.3. Applicazione del principio di esaurimento del diritto
- 2. Trasferibilità del software: figure contrattuali di cessione o licenza d’uso
- 2.1. I diritti morali e diritti patrimoniali a confronto
- 2.2. I diritti di utilizzazione economica (diritti esclusivi)
- 2.3. La concessione del software: cessione o licenza?
- 3. Diritto di commercializzazione e diritti esclusivi verso il principio di esaurimento del diritto.
- 3.1. I diritti di esclusiva attribuiti al titolare
- 3.2. Il regime delle garanzie, vizi, eccezioni e limitazioni
- 3.3. I contratti di assistenza e di manutenzione
- 3.4. I diritti dell’utilizzatore
- 4. La «prima vendita» e licenze di «seconda mano»: supporti fisici e download
- 4.1. Il potenziamento del diritto di esclusiva e applicazione del principio di esaurimento alle opere digitali
- 4.2. La nozione di «prima vendita» e la legittimità della «rivendita»
- 5. Download ed esaurimento
- IV. La società dell’informazione e la digitalizzazione: affermazione del mercato dell’“usato” nelle imprese
- 1. Il mercato dell’«usato»: legittimità e vantaggi per l’impresa
- 2. Il software nella Società dell’informazione: le misure di protezione e l’importanza dell’innovazione.
- 3. Società dell’informazione, conoscenza e digitalizzazione.
- 3.1. Internet e la Rete
- 3.2. Il diritto di accesso nella Società dell’informazione e della conoscenza
- 4. Conclusioni
- Bibliografia
- Sitografia
- Normativa
- Giurisprudenza
- In questa collana
- Tutti gli ebook Bus Stop
Domande frequenti
- Essential è l'ideale per studenti e professionisti che amano esplorare un'ampia gamma di argomenti. Accedi alla libreria Essential, che include oltre 800.000 titoli di comprovata qualità e bestseller in vari settori, tra cui business, crescita personale e discipline umanistiche. Include tempo di lettura illimitato e voce standard per la sintesi vocale.
- Complete: perfetto per studenti e ricercatori esperti che necessitano di un accesso completo e illimitato. Accedi a oltre 1,4 milioni di libri su centinaia di argomenti, inclusi titoli accademici e specialistici. Il piano Complete include anche funzionalità avanzate come la sintesi vocale premium e l'assistente di ricerca.
I dispositivi con iOS 13 e Android 7 o versioni precedenti non sono supportati. Scopri di più su come utilizzare l'app