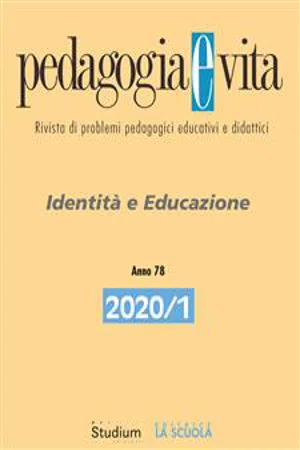Nota al titolo : Il contributo è stato integralmente condiviso dagli Autori. Nello specifico la Premessa, il paragrafo 4 e la Conclusione sono stati scritti da Giuseppe Elia e i paragrafi 1 e 2 da Anna Daniela Savino.
Premessa
Edgar Morin [1] , in un dialogo sull’identità umana e la sfida della convivenza, richiama la via Francigena: essa costituiva, anche ad insaputa dei protagonisti stessi, un vero interscambio culturale di idee, un laboratorio di concetti e di creatività semplicemente unico e originalissimo; religione, dimensione culturale e commerciale erano l’humus multiculturale da cui quel terreno assolutamente generativo faceva germogliare il nuovo. Anche la civilizzazione ellenistica costituisce l’evento del nuovo fondata com’era sul mètissage che, a parere di Morin, incarna una delle prospettive fondamentali per abitare la Terra oggi: «[…] la comprensione umana ha bisogno della cultura delle persone, e questa idea dà il senso della pace» [2] .
La cultura della persona e la necessità della sua comprensione richiama immediatamente il concetto di identità, legato alla sua radice, ontologicamente, a quello di alterità: è questo, nella società liquida in cui viviamo, che silenziosamente risiedendo al fondo di ogni discorso pedagogico chiede di essere nuovamente messo a tema. Ma paradossalmente è proprio approfondendo il tema dell’integrazione che si può incontrare il profilo, in senso filosofico e pedagogico, dell’identità. È l’alterità che come contraltare definisce l’identità; è proprio l’altro da sé che fornisce la possibilità di definire ciò che è invece l’identico, è solo in presenza di un tu che possiamo definire un io. Ciò che è sempre stato problema è, appunto, il loro rapporto che si traduce infine nei termini della convivenza.
Il presente contributo intende ripensare e mettere a fuoco il tema dell’identità, nel suo rapporto con l’alterità, come fondante quello dell’integrazione e della convivenza nella società liquida e cercare di approfondire il legame che il discorso educativo può avere con la valorizzazione e la promozione di ogni identità che incontra un’altra identità.
«Ognuno di noi è un soggetto singolo ma è anche appartenenza ad un gruppo, abbiamo un nome e cognome, siamo inseriti in una storia famigliare, in un paese, in una cultura, riceviamo un’eredità culturale che assumiamo e viviamo secondo la nostra specifica singolarità» [3] , così Luisa Santelli Beccegato sintetizza l’itinerario di ciascun essere umano che ha il compito di attraversare la propria vita alla scoperta e anche alla costruzione della propria identità, della propria unicità e irripetibilità della propria persona, pur inseriti come si è in una comunità da cui si riceve un’eredità con cui fare i conti; la storia della nostra vita diventa la storia della nostra educazione.
1. L’identità nel processo di integrazione
Nell’orizzonte del multiculturalismo, i termini assimilazione e integrazione richiedono un riapprofondimento, un ritorno all’origine teoretica e fondativa dei loro stessi concetti: prima ancora che parlare di quel terreno, da cui può nascere una cultura nuova, generato dal reale incontro di un’identità e un’alterità, occorre ripensare proprio a quale sia il centro del discorso pedagogico che può portare alla fruttificazione della vera convivenza delle diversità: «il centro della costellazione, dei significati qualificanti il discorso pedagogico, la sua essenzialità, si ritrova non nell’assimilazione né nell’integrazione ma nel principio e nel valore dell’identità » [4] . Dopo anni di riflessione sul concetto di integrazione, infatti si è giunti ad elaborare una concezione positiva dell’integrazione stessa perché essa costituisce per ogni identità in gioco un arricchimento in termini sociali, relazionali, affettivi e cognitivi: anche la stessa concezione dell’accomodamento in senso cognitivo che compare sulla scena chiamata dall’assimilazione, nell’integrazione risulta potenziata in termini di competenze: mentre infatti l’assimilazione della nuova cultura in cui si viene immersi provoca un abbandono dell’identità originaria, nell’integrazione accade l’inverso.
In un processo di integrazione, l’identità originaria non solo non viene persa ma ne esce arricchita perché approfondisce sé stessa nel gioco di rispecchiamento nell’altra identità, proprio perché è l’alterità che provoca “domande” sul proprio sé. Se non ci fosse l’integrazione non ci sarebbe nuova cultura, l’identità resterebbe appiattita, uguale a sé stessa, chiusa narcisisticamente su sé stessa invece che aperta all’essere, all’evento, al cambiamento e quindi all’evoluzione.
Come Mounier [5] afferma, il gruppo, la comunità, le società hanno il compito di suscitare la persona e ogni compito educativo ha come fine ultimo quello di fondare, sostenere, promuovere e migliorare la persona. E perché la persona possa elaborare la propria Weltanshaaung, la propria visione del mondo e scoprire la propria funzione in esso, occorre un sostegno, una direzione data amorosamente, occorre che qualcuno educhi a questo. Occorre, come educatori, aiutare l’altro a scoprire innanzitutto e poi elaborare la propria unica identità ed è in questo che risiede il punto di maggior spessore pedagogico in senso personalistico: riuscire a convivere e collaborare con chi è diverso rispettando le reciproche identità, la realizzazione di questo sarebbe la maturazione del discorso pedagogico che porta come frutto ultimo l’assoluta valorizzazione dell’identità [6] .
L’integrazione di identità diverse che possa fruttificare in una generazione del nuovo, di una nuova cultura, pacificamente, necessità però di identità solide e probabilmente la vera sfida dei nostri giorni è proprio quella di solidificare le identità che poi vengono a contatto: la percezione che i giovani hanno di sé e del proprio presente e futuro, infatti, è frammentata; «essi assumono modelli di riferimento identitari flessibili, accettano canali di doppia moralità, la vita è tendenzialmente vissuta oscillando continuamente tra evasione e impegno, le norme vengono soggettivate, le scelte sono sempre rinegoziabili, le mete sono ridotte a significati minimali e l’idea di vocazione è in crisi» [7] .
Probabilmente ci si chiede, in questo scenario, se non sia urgente rifondare il discorso dell’identità e quindi della persona, dal momento che, in questo ordine di pensiero, parlare di persona vorrebbe dire, innanzitutto, mettere a tema l’identità della persona stessa; occorrerebbe allora ripensare il discorso sull’identità poggiandola sul concetto di coscienza, coscienza di sé, del proprio esserci e del senso ultimo della stessa esistenza. In una sorta di circolo ermeneutico, per sostenere e solidificare l’identità, che chiederebbe in seconda battuta la convivenza e l’integrazione con altre identità, senza le quali però non potrebbe neanche scoprire e costruire sè stessa, sarebbe necessario ripensare ed educare a pensare il concetto di coscienza e bene [8] , intesi come preliminari, precedenti allo stesso concetto di identità: Romano Guardini conosceva bene la precedenza ontologica di questo approfondimento che probabilmente aiuterebbe l’educatore a schiarire un pò la nebbia dell’epoca contemporanea e a fissare dei punti di riferimento stabili e aperti, non rigidi e chiusi, sulla necessaria scoperta e costruzione dell’identità, punto originario e centro del discorso fin qui intrapreso. Leghiamo, dunque, la nostra riflessione sul concetto di identità non a quello inaugurato nel dibattito moderno da Locke sull’identità personale [9] che ha acquisito un taglio e destato l’interesse nei secoli di autori afferenti più alla filosofia, scienza della mente e alla logica che ad una riflessione di tipo filosofico-pedagogico; qui si vuol parlare di identità e correlarla all’educazione, poiché ciò che intimamente ci interessa è di poter sollevare, far scaturire riflessioni e poter in ultima analisi pervenire ad una definizione più chiara del tema in questione che porti la persona a prendere coscienza delle proprie strutture onto-gnoseologiche e morali come delineate dalla metafisica cristiana e del personalismo, al fine di rintracciare il legame originario dell’io con l’altro.
Tema, questo, molto caro a Martin Buber [10] ma lo diceva, del resto, ancor prima, Agostino d’Ippona, un autore paradossalmente lontanissimo dai nostri tempi, il quale affermava, lungo tutto il corso delle sue opere e non solo dei Dialoghi di Cassiciaco [11] , che cercando sé stessi si scopre un Altro che ci abita [12] . E l’ abissus humanae conscientiae agostiniano non suggerisce proprio il fatto che la prima alterità con cui veniamo a contatto è la nostra stessa identità? Buber afferma che l’uomo «[…] diventa io a contatto con il tu. Ciò che sta di fronte viene e si dilegua, eventi di relazione si condensano e si disperdono, e in questo scambio, ogni volta accresciuta, si fa chiara la coscienza di quell’elemento che rimane uguale fra i due, la coscienza dell’io. Certo, essa appare ancora solo nella trama del rapporto, nella relazione con il tu, […] per prendere subito possesso di sé e da allora in poi entrare consapevolmente nelle relazioni» [13] . Siamo dunque di fronte ad un concetto, quello di coscienza, che precede ontologicamente e gnoseologicamente quello di identità ed esso, come ha suggerito Gua...