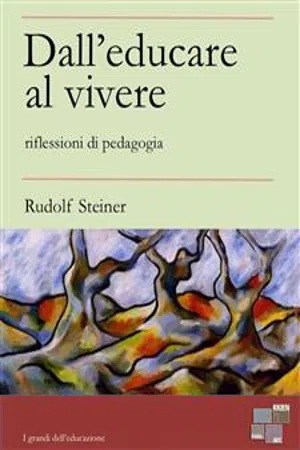![]()
Educazione pratica del pensiero
Karlsruhe, 18 gennaio 1909
Miei cari amici!
Può sembrar strano che l’antroposofia si senta chiamata a parlare di educazione pratica del pensiero; le persone estranee, infatti, hanno assai spesso l’idea che l’antroposofia sia qualcosa di eminentemente non pratico e che non abbia nulla a che fare con la vita. Una simile opinione può sussistere però solo se si considerano le cose superficialmente da un punto di vista esteriore. In realtà si tratta invece, nell’antroposofia, di una norma per la vita di tutti i giorni; in ogni momento l’antroposofia deve potersi convertire, per noi, in sensibilità e in sentimenti atti a farci affrontare la vita con sicurezza, e a farci attenere saldamente ad essa.
Le persone che si dichiarano pratiche credono di agire secondo i princìpi più pratici. Ma se si guardan le cose più da vicino, si scoprirà che il cosiddetto «pensiero pratico» spesso non è affatto un pensiero, ma solo un persistere in giudizi tradizionali e in abitudini di pensiero. Se si osserva del tutto oggettivamente il pensiero delle persone pratiche, se si esamina quello che abitualmente si chiama un pensiero pratico, vi si troverà spesso ben poca vera pratica; quella che si chiama pratica consiste spesso solo nell’aver appreso come la pensasse il maestro, o come la pensasse chi, in pre cedenza, sia stato inventore di questo o quello, e come ci si debba di conseguenza orientare. E chi pensa diversamente, vien considerato una persona non pratica; ché il pensiero non sempre concorda con quanto è stato una volta inculcato nella gente.
Ma se realmente, una volta, qualcosa di pratico è stato inventato, non è affatto detto che lo sia stato da una persona effettivamente pratica. Prendiamo per esempio i nostri francobolli. La cosa più ovvia sarebbe di pensare che essi siano stati inventati da una persona pratica della posta. Ma non è così. All’inizio del secolo scorso la spedizione di una lettera era ancora un vero cerimoniale. Se si voleva mandare una lettera, si doveva andare in un luogo apposito dove le lettere venivano consegnate; li poi si dovevano consultare molti libri, attenendosi a un complicato cerimoniale. Solo da circa sessant’anni siamo abituati, per la spedizione delle lettere, a una tariffa unitaria. E il nostro attuale francobollo, che rende possibile ciò, non è stato inventato da un uomo prati o del servizio postale, ma da un uomo che ne era lontano, dall’inglese Hill. Quando fu inventato il francobollo, il ministro che allora era addetto alle poste dichiarò al parlamento inglese che in primo luogo non si poteva supporre, con questa semplificazione, che il traffico sarebbe realmente aumentato come quel Hill, mancante di ogni senso pratico, se lo figurava; e che in secondo luogo, supposto che così fosse, l’ufficio postale di Londra non sarebbe stato certo sufficiente per un tal traffico.
Ma a quel grande uomo pratico non veniva neanche lontanamente in mente che l’edificio della posta dovesse regolarsi sul traffico, e non il traffico sull’edificio della posta. Ora, in un periodo di tempo relativamente brevissimo, quel che allora dovette essere strappato a fatica ad un pratico da un non pratico, entrò nell’uso; e oggi è assolutamente ovvio spedir le lettere coi francobolli.
Similmente per quanto riguarda la ferrovia. Nel 1835, quando in Germania si trattava di costruire la prima ferrovia da Norimberga a Flirth, l’associazione medica bavarese, interpellata, dichiarò in una perizia che non era consigliabile costruire ferrovie; se tuttavia se ne aveva l’intenzione, allora per lo meno si doveva erigere un’alta staccionata a destra e a sinistra della ferrovia, affinché i passanti non avessero a patire choc nervosi e commozioni cerebrali. Quando poi si doveva costruire la linea ferroviaria Potsdam-Berlino, il direttore generale delle poste Nagler disse: «Ogni giorno partono per Potsdam due diligenze postali e non sono mai complete; se si vuole assolutamente buttare il denaro dalla finestra, tanto vale, allora, farlo direttamente». I fatti reali della vita percorrono strade diverse da quelle della cosiddetta gente pratica, della gente che crede di essere pratica. Bisogna distinguere quello che è il vero pensare dal cosiddetto pensare pratico, che è solo un giudicare secondo abitudini di pensiero inculcate.
Racconterò un fatterello, capitato proprio a me, col quale inizierò queste nostre considerazioni. Quando ero studente, venne un giorno da me un mio giovane collega, tutto allegro, come capita a chi abbia avuto un’idea molto astuta, e mi disse: «Devo andare subito dal professor X (che teneva allora la cattedra universitaria di costruzione di macchine) perché ho fatto una grande scoperta: ho scoperto che con l’impiego di una quantità minima di forza di vapore trasformata si può eseguire, con una macchina, una straordinaria quantità di lavoro». Di più non poté dirmi, perché aveva una gran fretta di andarsene. Non trovò però il professore che cercava; tornò indietro e mi spiegò tutto quanto. Il ragionamento mi sembrava puzzare un po’ – per così dire - di moto perpetuo; tuttavia, una cosa del genere non avrebbe potuto, dopo tutto, anche attuarsi un giorno? Dopo che mi ebbe spiegato ogni cosa, non potei fare a meno di dirgli: «La faccenda, vedi, è bensì acutamente escogitata, ma in pratica in questa condizione le cose stanno come se qualcuno si mettesse in un vagone ferroviario, spingesse terribilmente dall’interno, e pensasse poi di esser stato lui a far partire il vagone. Altrettanto poco valido è il principio su cui si fonda la tua pretesa scoperta». Anche lui si rese poi conto della cosa; e non tornò più dal professore.
In tal modo ci si può per così dire incapsulare col proprio pensiero. Questo incapsulamento si rende anche evidente in certi casi specialissimi; ma nella vita molti uomini si incapsulano in modo simile e non sempre questo salta all’occhio come nel nostro esempio. Chi però è in grado di osservare le cose più profondamente, sa che molte e molte volte, negli uomini, il procedimento di pensiero si svolge così; e spesso vede che gli uomini stanno sempre, per così dire, in un vagone, spingono dall’interno, credendo poi di esser loro a far muovere il vagone. Molto di quanto avviene nella vita andrebbe in modo ben diverso, se gli uomini non fossero appunto come quelli che stanno in un vagone e che credono di muoverlo, spingendo sulla parete interna.
Una vera prassi del pensiero presuppone che si abbia verso di esso il giusto atteggiamento, il giusto sentimento. E come si può conseguire una giusta posizione verso il pensiero? Non si può avere un giusto senso del pensiero se si crede che il pensiero sia qualcosa che si svolge solo dentro l’uomo, dentro il suo capo o dentro la sua anima. A chi ha quest’opinione, un falso sentimento impedirà sempre di ricercare una corretta prassi del pensiero, e di pretendere dal proprio pensiero che esso risponda alle necessarie esigenze. Chi voglia conseguire il giusto sentimento rispetto al pensiero, dovrà dirsi: se sono in grado di farmi dei pensieri intorno alle cose, se con pensieri io posso stabilire qualcosa intorno alle cose, questi pensieri devono pur esserci, prima, nelle cose. Le cose devono essere state costruite secondo i pensieri, e solo allora io potrò anche estrarre i pensieri dalle cose.
L’uomo deve immaginarsi che gli oggetti del mondo esterno sono paragonabili, in un certo senso, a un orologio. Si è usato assai spesso questo paragone dell’orologio per l’organismo umano; ma la gente per lo più dimentica il più importante, ossia che esiste anche un orologiaio. Bisogna rendersi conto chiaramente che le ruote non si sono radunate, non si sono combinate da sole per far andare l’orologio; ma che prima è esistito un orologiaio che ha composto l’orologio. Non si può dimenticare l’orologiaio. L’orologio è stato creato mediante pensieri, i pensieri sono per così dire fluiti nell’orologio, nelle cose. Bisogna rappresentarsi in un modo simile anche tutte le opere, tutti i fatti di natura. Nell’opera dell’uomo la cosa è subito evidente, ma nelle opere di natura non la si può tanto facilmente osservare; eppure anch’esse sono effetto di attività spirituali e dietro ad esse stanno entità spirituali. Quando pensa intorno alle cose, l’uomo riflette solo su ciò che prima è stato riposto in esse. Solo l’opinione che il mondo sia stato prodotto da pensieri e venga ancora in tal modo continuamente prodotto, rende feconda la vera pratica interiore del pensiero.
L’incredulità rispetto alla spiritualità del mondo produce sempre, anche su terreno scientifico, il pensiero praticamente peggiore. Se per esempio si dice che il nostro sistema planetario è sorto così: che prima c’era una nebulosa primordiale che ha cominciato a roteare e si è contratta in un corpo centrale; che da questo poi si sono separati anelli e sfere e così è sorto meccanicamente l’intero nostro sistema planetario - se si dice così, si commette un grave errore di pensiero. La cosa è presentata agli uomini, oggi, in modo assai leggiadro; in ogni scuola si fa questo bell’esperimento: si mette in un bicchier d’acqua una goccia di grasso; si fa passare un ago in questa goccia di grasso e si fa rotare il tutto. Allora dalla grossa goccia si separano piccole gocce; si ottiene un piccolo sistema planetario; e si è mostrato con evidenza allo scolaro - così almeno si crede - come un sistema planetario si possa formare in modo puramente meccanico. Soltanto un pensiero inesperto potrà, da questo bell’esperimento, trarre tali conclusioni; chi infatti trasferisce la cosa al nostro grande sistema planetario, dimentica per lo più qualcosa che forse - di solito - è assai bene dimenticare: dimentica se stesso, dimentica di essere stato lui stesso a porre il tutto in rotazione! Se non ci fosse stato lui a compiere tutto l’esperimento, la suddivisione della goccia di grasso in tante goccioline non si sarebbe mai verificata. Se l’uomo osservasse anche questo e lo riportasse al sistema planetario, allora sì il ragionamento sarebbe perfetto. Tali errori di pensiero hanno oggi una parte straordinariamente grande; anche, specialmente, in quella che oggi chiamiamo scienza. Sono assai più importanti di’ quanto abitualmente non si creda.
Se si vuol parlare di vera praticità del pensiero, bisogna riconoscere che i pensieri possono essere estratti solo da un mondo in cui essi già siano presenti realmente. Come si può attingere acqua solo da un vaso che veramente già la contenga, così si possono attingere pensieri solo da cose in cui essi già siano. Il mondo è costruito su pensieri; solo perciò dal mondo si possono anche estrarre pensieri. Se non fosse così, una prassi del pensiero non potrebbe in genere neppure compiersi. Quando l’uomo finalmente comprenderà quanto abbiamo detto ora, allora gli sarà facile distogliersi da ogni pensare astratto; quando l’uomo avrà la piena fiducia che dietro alle cose stanno pensieri, che i fatti reali della vita si svolgono secondo pensieri, quando sarà pervaso da questo sentimento, allora facilmente si convertirà a un esercizio del pensiero fondato sulla realtà.
Presenteremo ora qualche esempio di prassi del pensiero, importante specialmente per chi stia su un terreno antroposofico. Chi è persuaso che il mondo dei fatti reali si svolge secondo pensieri, riconoscerà l’importanza di un’educazione al retto pensare. Supponiamo che qualcuno si dica: io voglio fecondare il mio pensiero in modo che esso riesca sempre veramente a orientarsi nella vita. Quel tale dovrà allora attenersi a quello che diremo ora. E le cose che addurremo sono da intendersi come princìpi concreti, come princìpi pratici; sono da intendersi come princìpi che, se vengono usati sempre di nuovo, se dànno la direzione al nostro pensare, producono determinati effetti; cosicché il pensiero diventerà pratico, anche se ciò forse in principio non apparirà. Se si attuano tali princìpi, si presentano al pensiero esperienze del tutto nuove.
Supponiamo che qualcuno og...