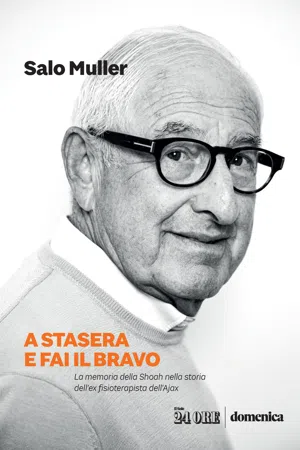![]()
— 1 —
Ignorati dal mondo
Giovedì 29 ottobre 1929, una data che preannunciava sciagura. La Borsa di New York crollò a picco e nel giro di ore moltissimi investitori persero tutti i loro soldi.
La mattina in abiti firmati, la sera in mutande. Gli scambi economici internazionali e il commercio andarono in tilt, il denaro non valeva più nulla. Le imprese edili e le fabbriche dichiararono bancarotta, i negozi chiusero i battenti e per la moltitudine di operai e semplici cittadini iniziarono tempi bui. Lo Stato introdusse misure per porre un freno all’aumento incontrollato dei prezzi. L’intera linea politica era volta a fermare il “crash”, la “crisi”, concetti che sarebbero diventati noti in tutto il mondo. Centinaia di migliaia di persone persero il lavoro e si misero in coda per ricevere i sussidi di disoccupazione. Lo storico Lou de Jong in seguito scrive: «La disoccupazione di massa divenne forse il fattore più importante nella realtà sociale degli anni Trenta e durante l’occupazione tedesca fu uno dei principali elementi a occupare i pensieri di molti: uno spettro che, una volta evocato, si era annidato nella coscienza popolare».
Per dare un’idea di quella realtà: se nel dicembre 1930 i Paesi Bassi contavano ufficialmente 136mila disoccupati, nel 1933 raggiunsero quota 380mila, una cifra spaventosa, dei quali solo 135mila avevano accesso a forme di sostegno economico. Un anno prima dello scoppio della guerra, nei Paesi Bassi i disoccupati ammontavano a circa 406mila.
Per la petite histoire della mia famiglia è opportuno ricordare quei tempi difficili. I disoccupati erano abbandonati a loro stessi, ogni giorno tiravano a campare. Mancavano i soldi per qualsiasi cosa, figurarsi per un bene di lusso come un giornale. E di conseguenza si sapeva a malapena cosa stesse accadendo nel mondo. Sempre nelle parole di Lou de Jong: «Ignorata dal mondo, la gente iniziò a ignorare il mondo».
Malgrado la disoccupazione di massa e il rischio della guerra, era la lotta quotidiana per la sopravvivenza ad avere la priorità. Nessuno riusciva a stimare correttamente la gravità della situazione, anche perché si credeva che i Paesi Bassi sarebbero rimasti neutrali anche in caso di guerra.
In Germania gli sviluppi politici e sociali si susseguirono a tutta velocità. Nel novembre 1918 i tedeschi pacifisti piantarono la bandiera della repubblica sulle macerie della Prima guerra mondiale. L’imperatore Guglielmo II subì una sconfitta schiacciante e fu esiliato nei neutrali Paesi Bassi. Ma il Paese aveva anche pagato un conto salatissimo: oltre due milioni di morti, il 13% del territorio andato perso, divieto di riarmo e isolamento internazionale. Nell’inverno tra il 1918 e il 1919 il vento cambiò di nuovo. Gruppi estremisti di destra e sinistra presero d’assalto i già precari accordi di pace e generarono un caos ancora più diffuso. Per motivi strategici il giovane Partito Comunista di Germania si appropriò di obiettivi dell’estrema destra. Uno dei suoi leader fece leva sull’antisemitismo che animava parte della fazione opposta. Il 9 novembre 1923 Adolf Hitler diede la prima scossa al Paese tentando un colpo di Stato (Putsch) a Monaco con le sue squadre d’assalto. Fu il primo membro del cosiddetto Partito Nazionalsocialista Tedesco dei Lavoratori (Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei, NSDAP). Su quella figura ancora relativamente sconosciuta, De Jong avrebbe poi commentato: «Della gioventù di Hitler e in particolare della sua infanzia si sa troppo poco per poter tracciare un profilo psicologico approfondito della sua ossessione monomane, dell’urgenza di dominazione sconfinante nella follia, della pressoché incessante goduria che trovava nei sentimenti d’odio. Si tratta di elementi che, come ha dimostrato in vita e in carriera, erano caratteristici della sua personalità».
L’ascesa di Hitler può essere soltanto vista come «l’anticipazione del dramma della Seconda guerra mondiale e, nello specifico, dell’uccisione premeditata di milioni di ebrei». Gli eventi della sua vita hanno un valore significativo nel racconto del declino della gente comune. Hitler nacque il 20 aprile 1889 a Braunau, sul confine tra Germania e Austria. Suo padre era un figlio illegittimo della domestica Maria Anna Schicklgruber. Tale Johann Georg Hiedler riconobbe Aloïs Schicklgruber come suo figlio e cambiò il cognome da Hiedler a Hitler. A 48 anni Aloïs si sposò per la terza volta. La nuova moglie si chiamava Klara Pölzl e il loro quarto figlio fu battezzato Adolf. I primi tre erano morti in tenera età, mentre dopo di lui arrivarono un fratellino, Edmund, e una sorellina, Paula.
Si hanno poche notizie sull’infanzia di Hitler. Sembra che sua madre fosse una donna dolce, mentre il giovane Adolf era inquieto, irascibile e cocciuto. Sognava di diventare un pittore famoso.
![]()
— 2 —
L’eliminazione totale degli ebrei
Nel 1906 Hitler conobbe la sua prima grande delusione: non superò l’esame di ammissione all’Accademia delle Belle Arti di Vienna, cosa che lo mandò su tutte le furie. Si trattenne tuttavia nella capitale austriaca, dove iniziarono a manifestarsi i primi tratti della sua vera indole. Odiava il padre e i comuni lavoratori, considerava gli ebrei dei buoni a nulla, per non parlare delle persone più agiate di lui. Adorava invece la madre. Quando le fu diagnosticato il cancro, lui le rimase accanto fino all’ultimo insieme al medico di famiglia ebreo, sul quale non ebbe mai nulla da ridire.
Disprezzava la monarchia austroungarica e detestava cechi, slovacchi e croati. Lasciò Vienna «da convinto antisemita, nemico giurato della visione del mondo marxista, ma da sciovinista tedesco», queste le sue parole.
Nel febbraio 1914, a Salisburgo, l’esercito lo dichiarò non idoneo al servizio, nemmeno in qualità di ausiliario. Infuriato, Hitler si sarebbe poi arruolato da volontario in Baviera. Le sconfitte subite dalla Germania durante la Prima guerra mondiale furono a suo parere evitabili. Ne imputava la colpa a ebrei, socialisti, politici e stranieri, fomentando le accuse in discorsi acclamati e lunghe arringhe che gli sarebbero valsi il comando dell’NSDAP. In un memorandum del 1919 scrisse: «Un antisemitismo assennato deve partire dal declassamento degli ebrei, tuttavia il fine ultimo non può che essere la loro eliminazione totale».
Il già citato Putsch organizzato con l’aiuto dei suoi sodali andò a vuoto. Hitler finì in carcere, dove con l’aiuto del segretario Rudolf Hess scrisse la prima parte del suo manifesto politico, il Mein Kampf.
Uscì di prigione cinque anni dopo e assunse presto il comando del Partito Nazionalsocialista, un movimento in forte ascesa, con servizi d’ordine privati e un gruppo paramilitare – le Sturmabteilungen o SA (“reparti d’assalto”) capeggiati anche da Hermann Göring. Nel 1932 in Germania si contavano sei milioni di disoccupati, una situazione che portò alla diffusione di povertà e irrequietezza, nonché a una svalutazione vertiginosa del marco. Le regole della società civile saltarono ed emersero così le condizioni per cui il cancelliere del Reich von Hindenburg nominò la futura guida del popolo Hitler come suo successore. Era il 30 gennaio 1933.
I conservatori del Reichstag, il parlamento tedesco, non riuscirono ad arginare Hitler, che non si accontentava delle mezze misure e spinse la Germania verso il baratro. Dispose subito la costruzione di campi di concentramento, in cui erano destinati a scomparire per sempre gli oppositori politici, i giornalisti avversari e i sindacalisti. La società tedesca subì una repentina metamorfosi e sprofondò in un abisso di terrore e angoscia. Nel mentre i nazisti fomentavano l’ammirazione per il Führer, alimentando le false aspettative di un popolo scontento.
Gran parte dei tedeschi cercò rifugio nel nuovo leader. Hitler collocò milioni di disoccupati nell’industria degli armamenti e nell’edilizia stradale, cosicché le divisioni del futuro esercito si potessero muovere rapidamente. Nel 1933 la Germania era un Paese sotto stretta sorveglianza e contava soltanto sei divisioni militari. Nel 1939, allo scoppio della Seconda guerra mondiale, lungo l’Autobahn ne transitavano e marciavano ben cinquantuno. Nel frattempo Hitler estese il potere e l’influenza oltre i vecchi confini. Nel 1935 sciolse il Territorio del bacino della Saar dallo stato-cuscinetto imposto dal Trattato di Versailles e l’anno seguente occupò la Renania. Nel 1937 e nel 1938 rivolse lo sguardo sulla natia Austria per realizzare l’Anschluss, dopodiché riversò la sua aggressività su Cecoslovacchia e Territorio dei Sudeti. Il 1° settembre 1939 invase la Polonia. Qualche giorno dopo, Regno Unito e Francia dichiararono ufficialmente guerra alla Germania.
Nei Paesi Bassi regnava l’incredulità. Si sperava che la tanto amata neutralità mantenesse il Paese ancora una volta fuori dal conflitto mondiale. Dopotutto le ultime vere imprese di guerra risalivano ai tempi del Duca d’Alba, l’inquisitore spagnolo del sedicesimo secolo nemico giurato di Guglielmo d’Orange. Nei Paesi Bassi moderni, a differenza delle nazioni confinanti, il concetto di guerra era pertanto sconosciuto.
In un primo momento i giornali olandesi dedicarono molta attenzione alla presa di potere di Hitler e osservavano l’evolversi della situazione tedesca con crescente preoccupazione. In seguito, inspiegabilmente, tornarono a occuparsi della cronaca quotidiana, nella probabile convinzione che tutto si sarebbe risolto per il meglio.
Lo stesso si può dire per la maggior parte degli ebrei olandesi. Geert Mak, in Un’idea di libertà. Biografia di Amsterdam, scrive: «Nemmeno gli ebrei che vivevano qui in pace da generazioni si potevano figurare quanto fosse grave la situazione in Germania».
È un dato di fatto che nei Paesi Bassi non si sapeva ancora che cosa fosse successo in Germania negli anni Trenta. A titolo di esempio, il 15 settembre 1935 il Reichstag aveva approvato all’unanimità le Leggi di Norimberga, che includevano una serie di provvedimenti contro gli ebrei, leggi che avrebbero cambiato la vita quotidiana di molte persone. Agli ebrei non era più permesso sposarsi con non ebrei né avere alle dipendenze domestiche non ebree. La cittadinanza fu loro revocata. Non erano più concittadini, non erano più esseri umani. Non erano più nessuno: Untermenschen.
Ciò avvenne da un giorno all’altro. Nei documenti degli uomini il nome doveva essere preceduto da “Israël”, in quelli delle donne da “Sara”, così da poter capire all’istante che si aveva a che fare con ebrei. In tutta la Germania comparvero insegne con su scritto: «Vietato agli ebrei». Cominciò nel 1936, il mio anno di nascita. Una manciata di anni dopo, tutte quelle disposizioni e proibizioni sarebbero state adottate indiscriminatamente anche nei Paesi Bassi.
Fu soprattutto la notte tra il 9 e il 10 novembre 1938 a restare impressa nella mia memoria, quando si verificò il primo pogrom completamente organizzato dal governo, la Kristallnacht. Furono appiccati incendi nelle sinagoghe, devastate botteghe e distrutte case. Molti ebrei vennero arrestati e deportati nei campi di concentramento, novantadue furono uccisi. Tutto ciò è descritto con dolore straziante in Confrontatie met het noodlot (“Faccia a faccia con il destino”), una testimonianza di quegli eventi narrata dal mio amico Werner Bloch.
![]()
— 3 —
L’Amsterdam ebraica
Come trascorsero quel periodo gli ebrei nei Paesi Bassi e soprattutto ad Amsterdam, che ospitava la comunità più numerosa? Intorno al 1940 il Paese ne contava all’incirca 140mila, registrati presso un comune o una comunità religiosa; circa 80mila vivevano nella capitale e più di 10mila non possedevano la cittadinanza olandese. La composizione delle comunità ebraiche era variegata. Nella capitale vivevano principalmente ebrei spagnoli e portoghesi, mentre gli ashkenaziti, discendenti degli ebrei che nel XVII secolo avevano trovato rifugio nei Paesi Bassi, erano sparsi per il Paese. Nel 1796 l’Assemblea nazionale aveva riconosciuto tutti gli ebrei residenti nel nostro Paese come cittadini olandesi. Per sottolineare le cifre: secondo un censimento del 1797 ad Amsterdam vivevano circa 20mila ebrei ashkenaziti e 2.800 ebrei portoghesi su una popolazione complessiva di 200mila anime. Si parla di cittadini che per generazioni avevano vissuto in pace nel Paese. Lo Stato non aveva ancora tracciato la linea tra ebrei e non ebrei, sarebbe successo solo con la cosiddetta Ariërverklaring, la «dichiarazione di non appartenenza alla razza ebraica» imposta dall’invasore.
I cambiamenti sociali avvenivano molto lentamente. Molti ebrei di Amsterdam campavano di elemosina e abitavano insieme nella zona di Waterlooplein, mescolati tra molti non ebrei. Nonostante la maggioranza vivesse in condizioni di povertà, sempre più ebrei si interessarono alle professioni di medico, avvocato e giornalista. Si assistette a un vero e proprio cambiamento culturale: nelle scuole ebraiche il nederlandese sostituì lo yiddish, e gradualmente gli ebrei si iscrissero alle scuole cittadine per i meno abbienti – un evento fortemente voluto dallo Stato, perché si riteneva potesse facilitare l’assimilazione con gli altri olandesi. Dal 1850 il nederlandese divenne la lingua parlata principale degli ebrei di Amsterdam, anche se diverse parole ed espressioni yiddish rimasero in uso.
Grazie agli ammodernamenti dell’industria e all’allargamento delle possibilità commerciali, molti di loro riuscirono a diventare importanti uomini d’affari. Un esempio arriva da Abraham Asscher, che permise a centinaia di persone di guadagnarsi la pagnotta nella sua azienda di diamanti. E un piccolo negozio tessile in Nieuwendijk, il Bijenkorf, con gli anni sarebbe diventato un’importante catena di grandi magazzini. Settori quali il tessile, ma anche l’antiquariato, erano dominati da imprenditori ebrei. Solo una minoranza aveva accesso a queste possibilità, ma lentamente le condizioni migliorarono. Nel 1914 più della metà degli ebrei aveva trovato lavoro nel settore del diamante, e il benessere interiore e sociale degli ebrei divenne un tema di interesse anche al di fuori dalle comunità religiose. Le barriere tra ebrei e non ebrei si stavano visibilmente assottigliando – i matrimoni misti aumentarono, gli ebrei della capitale si sentivano in gran parte Amsterdammers a tutti gli effetti, e così fu fino al 1940. In città, nei neutrali Paesi Bassi, ci si sentiva al sicuro. Cosa mai sarebbe potuto succedere?
I racconti di ebrei e altri profughi che avevano lasciato Germania e Austria venivano accolti di buon grado, ma al tempo stesso etichettati in genere come poco credibili. Che esagerazione! La situazione era davvero così pericolosa come la si descriveva? Forse anche questo atteggiamento aiuta a spiegare la percentuale di ebrei olandesi eliminati dai tedeschi, quasi l’80% del totale, la più alta nell’intera Europa occidentale. Anche loro come tutti gli altri olandesi nel 1940 si trovarono assolutamente impreparati di fronte all’invasione tedesca.
Per tratteggiare il dualismo dei Paesi Bassi nel periodo interbellico, presento brevemente il Movimento Nazionalsocialista (Nationaal-Socialistische Beweging, NSB), fondato nel 1931 e guidato da Anton Mussert, ingegnere presso l’ente per la gestione delle risorse idriche della provincia di Utrecht. Il suo programma, come nel caso di Hitler, faceva leva sulla diffusa disoccupazione e sulla povertà. Alle elezioni provinciali del 1935 l’NSB ottenne ben quarantaquattro seggi, 50mila olandesi si lasciarono tentare e si iscrissero al partito.
Tuttavia c’era anche chi invitava la popolazione a distanziarsi dall’atteggiamento pericoloso dell’NSB, una campagna che si rivelò efficace, visto che alle successive elezioni generali l’NSB perse metà dei seggi.
Il 10 maggio 1940, un giorno cruciale. Paesi Bassi, Belgio, Lussemburgo e Francia dovettero aprire gli occhi: i tedeschi invasero i Paesi confinanti a ovest. In seguito si scoprì da un documento segreto che già nel 1939 i preparativi per l’attacco erano in uno stadio molto avanzato. Nei primi giorni di conflitto 105 divisioni francesi, 9 britanniche, 22 belghe e 10 olandesi si opposero a 136 divisioni tedesche, ma non poterono nulla di fronte alla supremazia della Germania.
![]()
— 4 —
La fuga della regina Guglielmina
Sono dell’idea che la fuga nel Regno Unito della regina Guglielmina e di alcuni suoi ministri abbia contribuito alla repentina caduta del nostro Paese. In occasione dell’insediamento nel 1898, aveva parlato di «vocazione», «missione della vita» e «dovere», affermando che la casata degli Orange non avrebbe mai potuto fare abbastanza per i Paesi Bassi. Fece tutto il possibile per proteggere e aiutare i sudditi ebrei? Dal mio resoconto risulterà evidente che furono in pochi a venire in loro soccorso. Tengo tuttavia a fare una precisazione su Guglielmina: era risoluta, appassionata, intelligente e forse anche coraggiosa. Figlia unica, fu educata nel rigore, circondata da governanti. Una volta incoronata, la sua vita divenne puro protocollo. Non era possibile rivolgerle la parola, men che meno contraddirla. Era molto devota, con la Bibbia a farle da sostegno e rifugio. Conosceva la Germania e i tedeschi molto bene sia da parte materna che paterna, e inoltre visitava spesso il Paese.
Vorrei citare nuovamente Lou de Jong: «Secondo la Costituzione il re gode della piena autorità a esercitare la sua influenza entro i limiti della responsabilità ministeriale. Può diventare un burattino, ma nulla lo costringe a esserlo. Non è tenuto a firmare in automati...