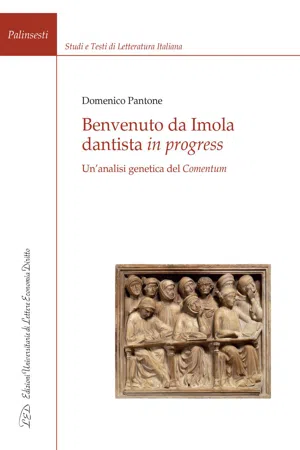Lungo il resoconto del suo travagliato itinerario oltremondano, più volte Dante-auctor sospende la narrazione e si rivolge al suo lettore, esortandolo a penetrare oltre la dura corteccia della lettera, o comunicandogli le sensazioni di meraviglia, angoscia e turbamento provate durante il viaggio 1. È noto che tali appelli al lettore, sostanzialmente estranei alla cultura classica, sono stati recisamente differenziati, sin dall’Auerbach, dal modello retorico dell’apostrofe (in quanto essi non avrebbero «funzione di diversione ma di captatio») 2 per essere studiati come stilemi peculiarmente danteschi. Gli antecedenti di tale mossa sono stati rintracciati nella tradizione esegetica e apologetica cristiana, e contestualizzati, pur dando atto della sorprendente originalità dantesca, «nell’urgenza dialettica e didascalica» che «nasceva dalla nuova visione simbolica e cristiana del mondo» 3. Rivolgendosi direttamente al lettore e captandone l’attenzione e l’applicazione, il poeta assumerebbe il ruolo di «vàs d’elezione» che racconta, secondo un collaudato habitus profetico, la sua esemplare esperienza di viaggio nell’oltretomba, e il resoconto dell’avventura dantesca verrebbe così condotto in una dimensione corale di conversione, in cui l’«io» e il «tu» tendono a ricongiungersi nel «noi»; ove si coglie un destino comune, illuminato da un mortale che riceve l’arduo compito di risollevare i propri fratelli, con i quali intesse un dialogo drammatico e umanissimo: «lo scrivente o parlante», per dirla con l’Auerbach, «è tutt’uno con quelli ai quali si rivolge» 4. Lo Spitzer, da parte sua, piuttosto che di urgenza profetica, preferiva parlare di «familiarità» tra i due protagonisti della comunicazione, mentre Paolo De Ventura ha notato come l’assenza dell’introduzione «O» per i vocativi che richiamano l’attenzione del lettore, nonché la posizione sintattica di tipo incidentale, non marcata, del vocativo stesso («lettor»), e più in generale il tono della maggior parte degli appelli, sostanzierebbero l’idea che «sia proprio il lettore il referente costante del discorso» 5. Tale dialogismo implicito troverebbe ulteriore conferma, sempre secondo De Ventura, nella prevenzione, da parte del poeta, di eventuali domande o obiezioni del lettore, come nel caso di Inf. XXXIV, 22-24 («Com’io divenni allor gelato e fioco, / nol dimandar, lettor, ch’i’ non lo scrivo»). Quanto allo spettro semantico del termine, d’altra parte, esso pare contemplare, in genere nella cultura medievale e in particolare nei seguenti luoghi danteschi (corsivi miei), una inequivocabile accezione didattica:
Lo terzo senso si chiama morale, e questo è quello che li lettori deono intentamente andare apostando per le scritture ad utilitade di loro e di loro discenti. (Convivio II, I, 5)
Itaque, formula consumata epistole, ad introductionem oblati operis aliquid sub lectoris officio compendiose aggrediar. (Epistole XIII)
Usanza me n’à fatta sì savietta / Ched i’ non dotterei nessun lettore / Che di ciò mi facesse desinore, / Ma’ ched i’ fosse bella e giovanetta. (Fiore CXLVIII, 5-8)
essa è la luce etterna di Sigieri, / che, leggendo nel Vico de li Strami, / silogizzò invidïosi veri. (Par. X, 136-138)
Ma perché ’n terra per le vostre scole / si legge che l’angelica natura / è tal, che ’ntende e si ricorda e vole. (Par. XXIX, 70-72)
Se dunque lettore, nell’opera dantesca come nella coeva cultura medievale, equivale sovente a ‘maestro’, ‘insegnante’, ‘professore’, è possibile perlomeno ipotizzarne una doppia valenza semantica, quasi che il poeta, nei suoi appelli, invochi contemporaneamente due figure ben distinte ma correlate: il semplice lettore, quel ‘cristiano qualunque’ di cui parlava l’Auerbach (o meglio quei «principi, baroni, cavalieri e molt’altra nobile gente», come rettificava il Petronio), e allo stesso tempo il dotto, o più precisamente un magister che sappia mediare tra il difficoltoso dettato dantesco e il lettore in «piccioletta barca», vale a dire il «professionista a cui, secondo la pratica letteraria del tempo, poteva essere affidato il compito di trasmettere il testo mediante letture pubbliche», come opina il De Ventura 6. D’altronde, come peraltro ribadito di recente da Saverio Bellomo, è evidente che la Commedia è opera tale da postulare, per sua stessa natura, l’ausilio del commento 7: in virtù dell’ardua tessitura stilistica e linguistica, come per la natura di summa enciclopedica che attraversa tutti i campi del sapere e l’onnipresenza del senso allegorico, il poema richiede l’indispensabile esplicitazione (secondo la memorabile definizione boccacciana) dell’«artificioso testo», della «moltitudine delle storie» e della «sublimità de’ sensi nascosi sotto il poetico velo» 8.
Nell’ambito della inedita e massiccia redazione e diffusione di commenti alla Commedia, che ha visto la luce sin dai primi anni immediatamente successivi alla morte del poeta, va senz’altro annoverato, tra i mediatori culturali più reattivi nel rispondere all’appello dantesco, proprio Benvenuto da Imola, mirabile interprete delle esigenze didascaliche postulate dal poema e dichiarate dal poeta, e perfettamente in grado di assolvere al doppio ruolo di allievo attento e di premuroso maestro. Per verificare tale intenso e continuo colloquio fra l’auctor ed il lector, evidente nell’intero Comentum, basterà additarne alcuni loci esemplari 9. Come il poeta esorta il suo lettore professionista a penetrare l’«artificioso testo», per ricavarne la «sublimità de’ sensi nascosi» («O voi ch’avete li ’ntelletti sani, / mirate la dottrina che s’asconde / sotto ’l velame de li versi strani», Inf. IX, 61-63), così l’esegeta, canto dopo canto, spesso si premura di interrompere l’expositio per avvertire i suoi lettori della densità polisema, e quindi dell’obscuritas della «littera», che dopo l’accorta mediazione del magister «de se obscura satis faciliter […] declaratur». Laddove poi l’auctor decide, per «lo fren de l’arte», di non sparger più rime o di lasciare il lettore «sovra ’l suo banco» («Or ti riman, lettor, sovra ’l tuo banco, / dietro pensando a ciò che si preliba, / s’esser vuoi lieto assai prima che stanco. / Messo t’ho innanzi; omai per te ti ciba; / ché a sé torce tutta la mia cura / quella materia ond’io son fatto scriba», Par. X, 22-27), magari rinviandolo ad altre speculazioni e solitarie letture («A descriver lor forme più non spargo / rime, lettor; ch’altra spesa mi strigne, / tanto ch’a questa non posso esser largo; / ma leggi Ezechïel», Purg. XXIX, 97-100); allo stesso modo il magister imolese sa dispensare agli allievi più volonterosi aggiornatissimi suggerimenti bibliografici, preziose specole per un più approfondito percorso conoscitivo: «sed si velis copiosam materiam, vide luculentissimum speculum quo poteris clarius et plenius speculari, scilicet librum de Casibus virorum illustrium, quem eleganter edidit Boccaccius de Certaldo vir humillimus hominum» 10.
Senz’altro non sfugge a Benvenuto la novitas dell’«alta phantasia» dantesca, rivendicata a più riprese dall’autore che preannunzia a chi legge il «nuovo ludo» (Inf. XXII, 118) o varca cantando l’acqua che «già mai non si corse» (Par. II, 7); sicché il magister si sbraccia nel rilevare, verso dopo verso, le invenzioni «mirabiles» e «inauditas» del suo artista prediletto, che «quasi semper facit novas fictiones in omni materia» (Comentum III, 246), sino a non battere ciglio persino dinanzi al vanto dantesco della doppia transmutatio di Inf. XXV, 94-102 («Taccia Lucano […]. Taccia di Cadmo e d’Aretusa Ovidio»), invitando il lettore a non meravigliarsi (poiché «pro certo numquam facta fuit similis fictio, nec tam artificiosa transmutatio»), e comunque convertendo, da buon maestro, l’intentio autoris in una sorta di autocelebrazione a fini didattici, intesa, anche in questo caso, a catturare l’attenzione del lettore:
Nec mireris, lector, si Dantes praesumpsit imponere silentium duobus magnis poetis, quia pro certo numquam facta fuit similis fictio, nec tam artificiosa transmutatio, sicut ipsemet testatur. Credo tamen quod hoc fecerit non tantum ad suam laudem, quantum ut redderet auditorem attentum ad rem novam, inauditam et inexcogitatam. (Comentum II, 249)
Così anche la precedente confessione dantesca di meraviglia, sempre nella bolgia dei ladri («Se tu se’ or, lettore, a creder lento / ciò ch’io dirò, non sarà maraviglia, / ché io che ’l vidi, a pena il mi consento»,Inf. XXV, 46-48), veniva riqualificata da Benvenuto quale ulteriore strategica richiesta di attentio («per hoc non vult aliud dicere nisi, ergo stes bene attentus»), rivolta dal poeta ai propri lettori, alla cui legittima incredulità egli paragona la propria di spettatore d’una così mirabile visione:
Et ideo facto Virgilio attento facit auditorem attentum valde artificiose; unde apostrophat ad lectorem, dicens: o lettor, non serà meraviglia, se tu se’ or lento a creder ciò ch’io dirò […] ché io, che ’l vidi, appena mel consento. Et in hoc vide, lector, quod autor extollit suam fictionem. Aliquando enim contingit homini magni ingenii, quod miratur de se ipso de sua aliqua inventione subtili, et dicit sibi ipsi: Ah Deus, quid fecisti! Certe numquam scirem facere similem fictionem; et per hoc non vult aliud dicere nisi, ergo stes bene attentus. (Comentum II, 235-236)
Il magister non esita quindi a far proprio tale espediente retorico dantesco 11, sempre palesando le difficoltà del suo travaglio esegetico, con il calcolato obiettivo di acuire l’attenzione dell’ascoltatore/lettore. Tale proposito è, ad esempio, evidente nell’esegesi dei primi versi del Purgatorio, ove, lasciata alle spalle la caligine infernale, la «navicella» dell’ingegno del poeta «alza le vele» (Purg. I, 1-3); anche Benvenuto così conferma, per parte sua, l’innalzamento della materia poetica, a cui non potrà che corrispondere un maggiore onere esegetico: «Ego vero exoneratus expositione libri primi, velut ipse in parte laboris fuerim cum autore, alacrius accedo ad declarationem secundi, qui plus difficultatis videtur habere ratione materiae altioris et ignotioris» (Comentum III, 1). Ed ecco come egli risponde ai celebri versi paradisiaci che intimano ai lettori in «piccioletta barca» di non avventurarsi oltre, ma di tornare a «riveder» i propri «liti» (Par. II, 1-18), riaffermando la maggiore difficoltà del testo dantesco, a comprendere il quale occorre più sottile ingegno che scienza, come egli stesso aveva sperimentato nella sua prima lectura bolognese: «et vere plus est opus magno ingenio, quam magna scientia ad intelligentiam huius libri, sicut ego expertus sum dum legerem librum istum Bononiae» (Comentum IV, 335-336). Benvenuto applica quindi tale metodo nell’intero suo commento, interrompendo ad arte, di volta in volta, l’esegesi, per ammonire il lettore riguardo alla difficoltà del passo da esplicitare («obscu-rus et male expositus a plurimis»), e renderlo così più attento ad esso e più benevolente verso le glosse del magister:
Ad intelligentiam cuius volo te scire, quod istud capitulum est valde forte, et habet multos passus difficiles sicut aliquis textus Virgilii vel alterius poetae. (Comentum I, 302)
Sed antequam ulterius procedam, lector, volo te scire, quod praesens capitulum non est minus artificiosum et obscurum, quam praecedens, ut patet ex dictis et dicendis. (Comentum I, 462)
unde attende quod istud capitulum est valde difficile et subtile, ideo poteris videre si Dantes fuit mirab...