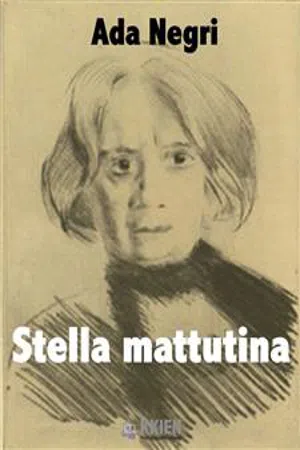![]()
STELLA MATTUTINA
A te Biancolina
gioia mia
![]()
STORIA DI DONNA AUGUSTA
Rimasto vedovo con una figliuola di quindici anni, educanda in un convento, il conte Giorgione Dàuli aveva, per tardo capriccio d’amore, già rovinando sulla cinquantina, sposata una giovine maestra di quel convento.
Novizia senza fede, destinata al chiostro dalla boriosa povertà della famiglia, la giovine maestra trovò gran ventura lasciare il soggòlo per la contea.
Femmina di carnale magnificenza: con una nera testa dal profilo d’imperatrice romana, racchiudente un cervello di passera. Nei primi tempi del matrimonio, il conte portò la sposa nell’avito palazzo di Lodi.
E fu un gaudioso spendere e spandere, una fantasmagoria di ricevimenti e di balli, un passar da splendore a splendore: erano i tempi delle feste per l’incoronazione del Bonaparte, Primo Console, divenuto imperatore; e l’aristocrazia lombarda pareva invasa dalla follia della danza, del lusso e del piacere.
La contessa Francesca divenne incinta; ma non per questo (docile in apparenza alla volontà del marito) ella rinunziò a una festa sola.
Accadde talvolta che, scendendo in gran pompa di vesti lo scalone marmoreo del palazzo, mentre la berlina l’attendeva alla porta, ella fosse assalita dagli urti di stomaco naturali in ogni principio di gravidanza; e cercasse di curvarsi in avanti, per difendere il lussuoso camice bianco di moda, costellato di diamanti. Ma il conte marito, implacabile, dall’alto della pancia boccaccesca, reggendola per un hraccio, gridava:
«Diritta! Diritta! Per san Giorgio! Diritta, contessa! il conte Dàuli ha denaro per altre vesti; ma il contino ha da nascer ben fatto. Alta la testa, donna Francesca!»
E donna Francesca, obbedendo, vomitava nobilmente sul camice di raso bianco, costellato di diamanti.
Nacque, a suo tempo, un figlio che subito morì, con disperazione d’entrambi. Nacque, alcuni anni più tardi, Augusta.
La madre non l’amava. Amava, per inconcepibile anomalia, il figlio morto: lui soltanto. Un sordo rancore, pure inconcepibile, l’arrovellava contro il marito; quasi in lui fosse la causa della perdita del primogenito.
Augusta crebbe fra i pettegolezzi delle cameriere: fra la guardaroba, la cucina e la scuderia.
A sette anni fu posta in collegio; mentre la figliuola di primo letto del conte Giorgione, donna Sandra, andava sposa a un gentiluomo dei dintorni di Cremona.
E il conte e la contessa, con le sostanze dissanguate dal pazzo sperpero durato circa due lustri, si ritiravano in una villa cinta di poderi, a loro rimasta.
Essi ancora davano in buona fede il nome d’amore al più appassionato odio coniugale che potesse tenere avvinti una donna e un uomo.
Rabbiose dispute, a intervalli, scoppiavano fra i due; specie per questioni d’interesse. Alla fine di ognuna, assordato dalle isteriche invettive della moglie, il conte Giorgione andava disperatamente trascinando la sferica mole sulle corte gambe, per sale e corridoi; annodandosi sul capo, come a difesa, un fazzolettone di seta a scacchi gialli e rossi. La contessa Francesca si precipitava in giardino, scarmigliata; e, brandito un paio di cesoie da potatura, le agitava sui fiori e sui rami, gridando:
«Taglio! Taglio! Taglio il matrimonio!»
Scene che non cessarono quando, compiuti i diciotto anni, donna Augusta tornò dal collegio.
Sarebbe poco dire che donna Augusta era bella.
Tante donne son belle. Donna Augusta era la stessa bellezza.
Aveva ereditato la plasticità della madre e i suoi lucenti capelli turchinicci; la carne perlacea e il lungo ovale dei Dàuli; ma il segreto della sua malia non era in questo; e nemmeno negli occhi troppo grandi, nella bocca troppo piccola.
Forse portava un anello incantato, al pari di certe principesse della favola.
Poco parlava: poco sorrideva.
Ignorante. Nell’istituto Garnier di Milano, il più aristocratico e il più di moda a’ quei tempi, ella non aveva, a dir vero, imparato che a danzare, a strisciare elegantissime riverenze, a movere il capo e il passo con la grazia d’una dea. Tanto che il conte padre tratto tratto esclamava, levando al cielo le tozze braccia:
«Ah, madame Garnier, i mèe danée!»
Ignorante. Ma chi la vedeva una volta, non la scordava più.
In fretta la fidanzarono al barone Otto di Lowenthal, ufficiale austriaco, di guarnigione a Cremona: ricchissimo.
Nessuno si domandò s’ella gli volesse veramente bene.
Si lasciò mettere al dito l’anello di promessa, festeggiare, coprire di preziosi doni, senza dir nulla, senza mai perdere quell’atteggiamento d’impassibile idolo che tanto s’addiceva alla sua bellezza.
Egli sì; egli impazziva d’amore.
E quando l’improvvisa morte del padre lo richiamò a Vienna per regolare le complicazioni d’un’eredità quasi principesca, nel dire addio alla fidanzata senti che il cuore gli si rompeva; ma, corretto fino allo scrupolo, nulla del suo affanno lasciò travedere.
Sarebbe ritornato fra sei o sette mesi. Scriveva tutti i giorni. Sognava e soffriva di lei tutte le notti.
Donna Augusta intanto, a scacciare la tristezza, fu mandata dai genitori, come allora era costume, in “visita” per qualche settimana in una casa amica: del marchese Savelli, a Pontevico.
Era costui un gentiluomo, ammogliato e padre d’un grappolo di forti bambini: ancor giovine d’anni, prestante della persona e di modi cavallereschi. Si chiamava Arnoldo: schermidore e cacciatore formidabile. La sua villa era in quel tempo colma d’ospiti.
Quand’egli per caso si trovava accanto a donna Augusta, l’uguale impressione colpiva tutti i presenti: sembravano fratelli.
Più che fratelli. Si può esserlo? V’è un legame di consanguineità più stretto, più misteriosamente tirannico? Fra quei due, certo esisteva. Se vicini l’uno all’altra, si trovassero pur fra mezzo a una folla di gente, un muro invisibile li separava da ognuno. Un muro d’aria.
L’armonia tutta pienezza e calore delle forme di lei, il ritmo delle sue mosse, il significato delle sue poche parole e de’ suoi lunghi silenzi si adattavano a lui, si compenetravano e riposavano in lui, secondo una legge di natura più forte della ragione e della volontà.
A caccia, egli su un cavallo nero, ella su un cavallo bianco, audaci ambedue sino al più folle rischio, facevano pensare che, presa la via dei boschi, non sarebbero più tornati indietro; e nessuno li avrebbe rivisti mai più. Il marchese Savelli aveva la disgrazia di possedere una piccola moglie malata d’itterizia e di gelosia; e donna Augusta era fidanzata al barone di Lowenthal.
Ma nessuno dei due poteva ricordarsene, se gli accadeva di fissar gli occhi sull’altro.
Una notte furono uditi nella villa Savelli urli e pianti di donna subito soffocati, sbattere di porte e strisciar di passi ne’ corridoi. Poscia, silenzio pesante: sospensione di vita, sino all’alba.
All’alba, una carrozza chiusa, carica delle valigie di donna Augusta, riconduceva la contessina, accompagnata dalla sua cameriera, ai genitori.
Minute spiegazioni sul ritorno precipitato non chiesero costoro alla figliuola; si accontentarono di qualche pretesto inventato lì per lì, e che sapeva di pretesto un miglio lontano. Non ebbero, probabilmente, il coraggio di toccare il fondo, di pretendere la verità, dinanzi a quell’impassibile faccia di marmo.
Il rimorso, nella sua forma più oscura, più rudimentale, addentò forse loro, per un momento, la coscienza: trovarono più facile annullarlo col silenzio.
E proseguirono nella loro esistenza crepuscolare, rotta dai soliti rumorosi litigi, dopo i quali il vecchio conte correva a ravvolgersi, bofonchiando, il calvo capo nel fazzolettone di seta a scacchi gialli e rossi, che la servitù chiamava il fazzoletto delle baruffe: la contessa Francesca si gettava a zig-zag, scarmigliati e cadenti sulle spalle i capelli ancor neri, attraverso i viali del giardino; e gridava, con un paio di cesoie da potatura brandito nella mano:
«Taglio! Taglio! Taglio il matrimonio!»
Spesso, in giardino, scendeva anche la fanciulla; ma sola, e quando era certa che nessuno la seguisse.
Penetrava nel folto dei gruppi d’alberi e dei cespugli, e sceglieva e coglieva con ogni cura erbe delle quali, nella propria camera, componeva poi strane mescolanze, che inghiottiva di soppiatto, a ore fisse, mormorando giaculatorie e facendosi il segno della croce. E andava diventando del verde colore di quelle erbe, e il suo sguardo si smarriva sempre nel vuoto; ma non si lagnava mai; e a chi le chiedeva come si sentisse, rispondeva, aprendo di scatto la bocca a un largo sorriso, suscitato dal tocco d’una molla interna: «Io? Benissimo».
Ma lo splendore dei denti spariva dietro le labbra subito risigillate.
Dei Savelli più nulla si sapeva, e nessuno più in casa ne parlava. A intervalli regolari giungevano appassionate lettere da Vienna, del barone di Lowenthal; due, tre insieme, talvolta: a più radi intervalli partivano per Vienna lettere di donna Augusta, brevi, quasi infantili, infiorate di qualche sgrammaticatura, simili a compitini di scuola.
Così trascorsero alcuni mesi. Ma la cameriera di donna Augusta, aiutandola a vestirsi il mattino, a svestirsi la sera, cominciò a dirle con sommesso rispetto, che a fatica nascondeva un’inquieta pietà:
«Contessina, bisogna far allargare le cinture degli abiti. Diventiamo grasse, lo sa?»
Al che donna Augusta invariabilmente rispondeva, senza guardarla:
«Ma nemmeno per sogno! Tu sei matta, Marianì». Non era matta, no, la fedele Marianì: ruminava tra sé, sospirando:
“Lo fossi davvero! Ma se la contessina avesse un poco più di confidenza in questa povera scema che l’ha vista nascere, tante cose si potrebbero forse rimediare a tempo».
Ma quando la figlia maggiore del conte Giorgione diede in Cremona, il sabato grasso, un grandioso ballo, per assistere al quale donna Augusta giunse appositamente dalla campagna con Marianì, la vecchia seguace tentò invano, due ore prima che s’aprissero le danze, d’allacciare in vita alla fanciulla i ganci della veste.
Un sogno era la veste: leggerissima, di velo rosa, a innumerevoli volanti, sparsi di capelvenere.
«Contessina, non si ...