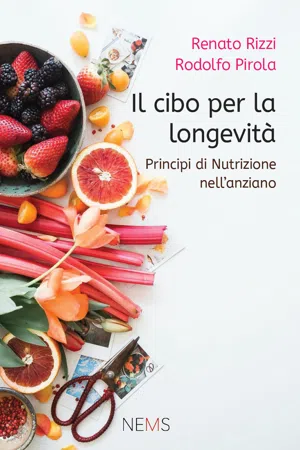![]()
INVECCHIAMENTO E LONGEVITÀ
Il significato emotivo e simbolico dell’alimentazione, come atto primario della cura di sé, atto di socializzazione, atto elettivo per festeggiamenti di fasi importanti della vita, atto di piacere per il palato, va preservato all’interno delle strutture per anziani come elemento di forte valore assistenziale. Mantenere più a lungo possibile la capacità di alimentarsi è di per sé garanzia di buona salute.
L’età avanzata presenta alterazioni fisiologiche che limitano il piacere del pasto, tuttavia la cura dell’ambiente e del rito del pasto può aiutare a preservare la funzione naturale, mantenendo più a lungo possibile l’autonomia stessa della persona. L’assistenza apportata dal personale delle strutture agli anziani durante l’alimentazione, si basa sulla conoscenza delle persone, dei loro problemi e del Piano Assistenziale Individualizzato (PAI), strumento cardine dell’integrazione professionale.
Valutazione stato nutrizionale dell’anziano
Numerosi studi confermano come l’istituzionalizzazione possa essere un importante fattore di rischio nutrizionale per l’anziano e sottolineano l’importanza di realizzare interventi di sorveglianza nutrizionale. La forza di queste raccomandazioni è ancora più significativa se si considera che lo stato nutrizionale può condizionare l’intero stato di salute della persona e la sua condizione di non autosufficienza. Un’adeguata valutazione dello stato nutrizionale è fondamentale per individuare i soggetti a rischio di malnutrizione o malnutriti.
La malnutrizione
Secondo la definizione del Council on Food and Nutrition dell’American Medical Association, la malnutrizione costituisce “uno stato di alterazione funzionale strutturale e di sviluppo dell’organismo conseguente alla discrepanza tra fabbisogni nutrizionali specifici ed introito o utilizzazione dei nutrienti essenziali”.
Le cause di malnutrizione sono molteplici: la solitudine, la disabilità fisica, le errate abitudini alimentari con assunzione monotona del cibo, le alterazioni cognitive e i disturbi mentali oltre alla depressione del tono dell’umore. Non vanno dimenticate la difficile masticazione, l’inappetenza, il ridotto assorbimento di nutrienti e l’interferenza dei farmaci. Le conseguenze dello stato di malnutrizione includono la riduzione delle difese immunitarie, il peggioramento della patologia di base, la maggiore incidenza e la ritardata guarigione di ulcere da pressione e da insufficienza venosa degli arti inferiori, il maggior rischio di sindrome ipocinetica e l’allungamento di tempi riabilitativi in caso di eventi acuti; tutte situazioni che peggiorano lo stato di salute dell’anziano favorendo l’aumento della mortalità.
La diagnosi di malnutrizione è basata su una valutazione: clinica (comprendente l’anamnesi e l’esame obiettivo), antropometrica, bioumorale, alimentare e funzionale. I segni di una malnutrizione possono essere: diminuzione del peso corporeo, comparsa di edemi, desquamazione e secchezza della cute, atrofia ungueale, rarefazione e caduta dei capelli. A livello delle mucose orali frequenti la secchezza e le screpolature labiali oltre ad atrofia papillare della lingua. Questi segni sono altresì poco specifici nel soggetto anziano.
Le alterazioni degli indici bio-umorali precedono il danno cellulare e la malnutrizione conclamata per cui è importante coglierle per tempo. Specifiche sono il dosaggio dell’albuminemia, della prealbuminemia, della transferrinemia e della proteina legante il retinolo (RBP). Il dato di albumina e in parte di prealbumina è inficiato dallo stato infiammatorio spesso presente a livello subclinico e clinico nel soggetto anziano, tanto da dover considerare l’ipoalbuminemia più un indice prognostico negativo che un vero indice nutrizionale. Generica informazione sul sistema immunitario è fornita dalla conta dei linfociti/mm3. L’albumina è espressione di carente assunzione di nutrienti da molto tempo, data la sua lunga emivita (21 giorni). Le altre proteine, per la loro breve emivita, rilevano variazioni dello stato nutrizionale insorte più recentemente e sono da considerare utili al fine di valutare l’efficacia di una terapia nutrizionale. Tra i parametri antropometrici, la determinazione del peso corporeo è fondamentale specie se raffrontata con il peso abituale. Quando la perdita di peso negli ultimi 6 mesi supera il 10% del peso abituale, fenomeno noto come cachessia, è espressione di malnutrizione. Variante è la perdita del 5% del peso corporeo in tre mesi rispetto a quello iniziale. L’Indice di Massa Corporea (IMC) fornisce indicazioni sulla funzionalità e composizione corporea (% di massa grassa e di massa magra), ma per un dato IMC la composizione corporea varia per sesso (> % di grasso nelle femmine), età (> % di grasso negli anziani rispetto ai giovani, specialmente uomini), muscolatura (< % di grasso negli individui muscolosi) e stato d’idratazione (edema, disidratazione). Anche se nell’anziano è molto indaginosa, l’anamnesi alimentare condotta con attenzione da parte del dietista, o laddove assente da parte di un operatore sanitario esperto di nutrizione è utile nel definire qualità e quantità dell’assunzione calorico-proteica. Può essere eseguita sulle 24 ore, ed è più completa su tre giorni. La valutazione della forza di prensione della mano (handgrip strength) è considerata uno dei più semplici e importanti test per la valutazione della funzionalità e del tono muscolare. La sua applicazione è determinante anche per la facile esecuzione in soggetti allettati.
La presenza di alterazioni delle performance cognitive e di malattie neurodegenerative (demenze, Parkinson e Parkinsonismi) rappresentano un ulteriore fattore di rischio di disfagia e malnutrizione per difetto nell’anziano istituzionalizzato, e ridotta idratazione. Il percorso valutativo dello stato nutrizionale deve essere avviato con una valutazione di base, effettuabile in modo rapido, semplice, ripetibile e poco costosa: lo screening nutrizionale. Tale strumento dovrebbe essere adottato dall’infermiere, dal dietista o dal medico alla presa in carico del soggetto e nella sua rivalutazione periodica. Per l’anziano il test maggiormente validato in ambito extraospedaliero è il Mini Nutritional Assessment (MNA).
La malnutrizione dell’anziano istituzionalizzato può essere contrastata o almeno contenuta attraverso una continua attività di prevenzione, che richiede una specifica e costante formazione del personale di cucina, del personale infermieristico specializzato e del personale assistenziale generico (OSS, ecc.) in tema di fisiopatologia e prevenzione nutrizionale e di nursing della malnutrizione.
Malnutrizione calorico-proteica
Inquadramento del problema
L’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) definisce la malnutrizione come lo stato di alterazione funzionale, strutturale e di sviluppo dell’organismo conseguente alla discrepanza tra fabbisogni e introiti o utilizzazione dei nutrienti, tali da comportare eccesso di morbilità o mortalità o un’alterazione della qualità della vita. Nello specifico la malnutrizione proteico energetica (PEM, Protein Energy Malnutrition) è da intendersi come una sindrome carenziale determinata dall’insufficiente apporto o dal malassorbimento dei macronutrienti che forniscono energia e proteine all’organismo. La rilevanza clinica della malnutrizione è data dal fatto che rappresenta un fattore di comorbilità, in grado di condizionare negativamente la prognosi della malattia di base qualunque essa sia, attraverso la depressione della risposta immunitaria, la riduzione della cicatrizzazione, l’alterazione funzionale di tutti gli organi, la qualità della vita del paziente, oltre ad esporlo ad un maggior rischio di morte.
Cause di malnutrizione in ospedale
• Cattive abitudini ospedaliere.
• Non formazione del personale in merito all’aspetto nutrizionale.
• Non utilizzo del diario alimentare come strumento di indagine.
• Ritardo nella richiesta di intervento
• Mancata prescrizione di supporti nutrizionali o ritardo.
• Digiuni prolungati per indagini diagnostiche.
• Prolungata terapia infusionale.
Cause di malnutrizione in strutture territoriali
• Cibi poco appetibili per aspetto, presentazione, sapore.
• Monotonia e ripetitività dei menu.
• Scarsa flessibilità/disponibilità del servizio cucina.
• Scarsa qualità delle materie prime (convenienza economica vs qualità nutrizionale).
• Eccessiva proposta di piatti freddi (soprattutto a cena).
• Orari dei pasti che tengono conto più delle esigenze organizzative della struttura e degli operatori che di quelle degli ospiti (esempio tipico l’eccessiva anticipazione del pasto serale).
• Scarsa comunicazione/collaborazione fra nuclei e cucina.
• Scarsa conoscenza dei gusti e delle richieste dei pazienti.
• Scarse occasioni di convivialità.
• Cibi serviti a temperature inappropriate .
• Presentazione dei piatti, in tavola, poco curata.
• Scarsa qualità ambientale (illuminazione, arredo, rumorosità, ecc.) delle sale da pranzo.
• Mancata o insufficiente assistenza al momento del pasto.
• Mancato rispetto dei tempi del paziente.
La malnutrizione considerata oggi come una “malattia nella malattia”, è un problema frequente e grave negli anziani, in grado di condizionare la patologia di base e inficiare la prognosi del paziente. La malnutrizione può essere: o tipo marasma: deficit calorico e proteico di lunga durata che causa perdita di peso per deplezione delle masse muscolari e dei depositi di grasso con tuttavia un contenuto proteico viscerale normale. Molto spesso è la fase terminale di malattie quali neoplasie, demenze, uremia, scompenso cardiaco, BPCO. Albumina, transferrina, conta linfocitaria ed emoglobina sono, almeno inizialmente, normali o poco diminuite; oppure tipo kwashiorkor o proteica: malnutrizione prevalentemente proteica con riserve adipose e muscolari inizialmente conservate legata ad un quadro ipercatabolico ad insorgenza acuta conseguente a malattie acute quali sepsi, traumi gravi. È presente edema con albuminemia solitamente inferiore a 2,8 gr/dl, linfocitopenia, anemia e ipotransferrinemia; infine mista: una commistione variabile delle due forme.
Le cause principali di malnutrizione sono:
• riduzione dell’apporto orale di nutrienti (anoressia, vomito, dolore, ostruzioni gastro- intestinali ecc..);
• perdita di nutrienti (malassorbimento, diarrea, emorragia, fistole digestive, drenaggi, lesioni da decubito, ecc...);
• aumentati fabbisogni (sepsi, ustioni, traumi, neoplasie, patologie neurologiche quali per esempio M.di Parkinson, interventi chirurgici, malattie infiammatorie croniche intestinali –MICI-);
• alterata utilizzazione dei nutrienti (neoplasie, aids, sepsi, insufficienza renale ed epatica).
Nel paziente anziano la malnutrizione ha genesi multifattoriale e deve essere affrontata in modo multidimensionale, comprendendo elementi fisici e psicologici: decadimento, dipendenza, solitudine patologie croniche concomitanti. Risulta pertanto indispensabile agire sulla prevenzione e/o terapia della malnutrizione proprio affrontando tutte le possibili cause.
La prevalenza della malnutrizione calorico proteica è stimata da studi recenti del 31% dei pazienti al momento del ricovero in ospedale (34,3% se di età superiore a 65 anni). Ma la maggior parte dei soggetti malnutriti o a rischio di diventarlo vive sul territorio: complessivamente si stima che un anziano su tre residente a domicilio o in struttura residenziale sia malnutrito o a rischio di malnutrizione (dal 17 al 65% dei pazienti ricoverati nei reparti ospedalieri di cura e dal 5 al 59% di quelli ospitati nelle strutture di lungodegenza). Approssimativamente il 16% degli anzi...