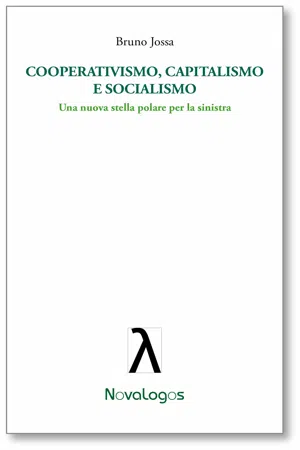
eBook - ePub
Cooperativismo capitalismo e socialismo. Una nuova stella polare per la sinistra
- Italian
- ePUB (disponibile sull'app)
- Disponibile su iOS e Android
eBook - ePub
Cooperativismo capitalismo e socialismo. Una nuova stella polare per la sinistra
Informazioni su questo libro
Un sistema d'imprese cooperative è una forma autentica di socialismo. Un suo grande pregio è che esso soddisfa il bisogno dei lavoratori di essere liberi e di diventare finalmente individui sociali pienamente sviluppati; altro suo pregio è quello di evitare che la società sia dominata dalla volontà e dagli interessi del grande capitale. Per questo un sistema d'imprese democratiche dovrebbe diventare la nuova stella polare della sinistra, oggi tanto in difficoltà.
Domande frequenti
Sì, puoi annullare l'abbonamento in qualsiasi momento dalla sezione Abbonamento nelle impostazioni del tuo account sul sito web di Perlego. L'abbonamento rimarrà attivo fino alla fine del periodo di fatturazione in corso. Scopri come annullare l'abbonamento.
Al momento è possibile scaricare tramite l'app tutti i nostri libri ePub mobile-friendly. Anche la maggior parte dei nostri PDF è scaricabile e stiamo lavorando per rendere disponibile quanto prima il download di tutti gli altri file. Per maggiori informazioni, clicca qui.
Perlego offre due piani: Base e Completo
- Base è ideale per studenti e professionisti che amano esplorare un’ampia varietà di argomenti. Accedi alla Biblioteca Base con oltre 800.000 titoli affidabili e best-seller in business, crescita personale e discipline umanistiche. Include tempo di lettura illimitato e voce Read Aloud standard.
- Completo: Perfetto per studenti avanzati e ricercatori che necessitano di accesso completo e senza restrizioni. Sblocca oltre 1,4 milioni di libri in centinaia di argomenti, inclusi titoli accademici e specializzati. Il piano Completo include anche funzionalità avanzate come Premium Read Aloud e Research Assistant.
Perlego è un servizio di abbonamento a testi accademici, che ti permette di accedere a un'intera libreria online a un prezzo inferiore rispetto a quello che pagheresti per acquistare un singolo libro al mese. Con oltre 1 milione di testi suddivisi in più di 1.000 categorie, troverai sicuramente ciò che fa per te! Per maggiori informazioni, clicca qui.
Cerca l'icona Sintesi vocale nel prossimo libro che leggerai per verificare se è possibile riprodurre l'audio. Questo strumento permette di leggere il testo a voce alta, evidenziandolo man mano che la lettura procede. Puoi aumentare o diminuire la velocità della sintesi vocale, oppure sospendere la riproduzione. Per maggiori informazioni, clicca qui.
Sì! Puoi usare l’app Perlego sia su dispositivi iOS che Android per leggere in qualsiasi momento, in qualsiasi luogo — anche offline. Perfetta per i tragitti o quando sei in movimento.
Nota che non possiamo supportare dispositivi con iOS 13 o Android 7 o versioni precedenti. Scopri di più sull’utilizzo dell’app.
Nota che non possiamo supportare dispositivi con iOS 13 o Android 7 o versioni precedenti. Scopri di più sull’utilizzo dell’app.
Sì, puoi accedere a Cooperativismo capitalismo e socialismo. Una nuova stella polare per la sinistra di Bruno Jossa in formato PDF e/o ePub, così come ad altri libri molto apprezzati nelle sezioni relative a Economia e Economia politica. Scopri oltre 1 milione di libri disponibili nel nostro catalogo.
Informazioni
Argomento
EconomiaCategoria
Economia politicaCapitolo primo
L’impresa cooperativa come alternativa all’impresa capitalistica
1. Introduzione
Si è detto nell’introduzione che per eliminare la disoccupazione e togliere ogni potere al capitale bisogna lasciar gestire le imprese ai lavoratori. Questo significa creare un sistema d’imprese cooperative, cioè d’imprese democratiche o autogestite. Nell’uso che ne facciamo, si badi, i termini autogestione, impresa democratica e cooperative di produzione sono usati sostanzialmente come sinonimi. Un sistema d’imprese cooperative fa tutt’uno, infatti, con la democrazia nelle imprese e, per definirlo, data la varietà delle sue forme possibili, basta chiarire che l’unica caratteristica irrinunciabile di esso è la regola fondamentale della democrazia, la regola secondo la quale il potere decisionale in un’associazione spetta tutto e solo ai componenti (ai soci) della stessa (secondo il principio ‘una testa, un voto’). Quanto alle altre caratteristiche, che possono esserci oppure no, esse vanno scelte con riferimento soprattutto al gran problema dell’efficienza, come vedremo.
In questo capitolo, pertanto, come già detto, noi ci soffermeremo a fare una presentazione generale dell’impresa cooperativa.
2. Le due facce del cooperativismo
Soffermiamoci, inizialmente, sulle origini del cooperativismo, che, come si diceva, oggi, per la teoria economica, fa tutt’uno con l’autogestione. Due aspetti di queste origini vanno messe in luce. Il primo è il carattere di reazione alle brutture del capitalismo di allora che caratterizzò il primo cooperativismo. Owen (1771-1858) è considerato spesso il fondatore sia del socialismo che del movimento cooperativo (cfr. Potter, 1893, p. 17).1 La sua esperienza della vita industriale di Manchester, dei comportamenti spietati della nuova imprenditoria di allora e della corsa all’arricchimento prodotta dalla rivoluzione industriale in atto lo convinsero che il sistema della fabbrica, con la libertà di concorrenza, era la causa del diffondersi dell’avidità e dei comportamenti disumani e del deterioramento dei principi morali; e lo spinsero a proporre, come è noto, nuove forme di organizzazione sociale, per abolire il sistema del profitto basato sulla concorrenza. Owen creò ‘i villaggi della cooperazione’ per dare lavoro ai disoccupati; ma in seguito egli considerò le sue organizzazioni «come uno strumento di rigenerazione universale, grazie al quale si sarebbe potuto liberare rapidamente il mondo intero dal sistema del profitto basato sulla concorrenza» (Cole, 1953, p. 105).
Tra i padri ispiratori del movimento cooperativo ricordiamo, poi, William Thompson, che fu un fautore sia del cooperativismo che del sindacalismo e considerò il sindacato come uno strumento di lotta per ridurre il profitto dei capitalisti e per favorire la nascita di un sistema di cooperative, che avrebbe dovuto eliminare progressivamente il sistema di imprese capitalistiche. Thompson era convinto della superiorità del modo di produzione cooperativo rispetto a quello capitalistico e si batté per favorire la nascita di cooperative di produzione con lo scopo di eliminare i capitalisti dal processo produttivo (cfr. Thompson, 1827).
Infine è interessante ricordare il contributo di Mazzini allo sviluppo del cooperativismo, che è di primaria importanza. L’idea centrale del pensiero del nostro patriota a riguardo è che i lavoratori debbano essere liberati dal “giogo del salario” e diventare «produttori liberi, padroni della totalità del valore della produzione». Nella sua visione, infatti, nel capitalismo il capitale è «arbitro di una produzione alla quale rimane straniero» e deve, pertanto, essere sostituito nel suo ruolo dal lavoro associato. L’associazione dei lavoratori – egli scriveva – dovrebbe garantire «eguaglianza dei soci nelle elezioni di amministratori a tempo o, meglio, soggetti a revoca» e assicurare un riparto degli utili a seconda della quantità e qualità del lavoro di ciascuno; e questo, a suo giudizio, «sarebbe la più bella rivoluzione che possa idearsi», perché porrebbe il lavoro «come base economica al consorzio umano» (cfr. Mazzini, 1935, pp. 109 e 132).
Owen, Thompson e Mazzini sono tutti autori che videro nel cooperativismo un’alternativa al capitalismo.
L’altro aspetto delle origini del cooperativismo che bisogna mettere in luce è la discendenza di esso dalle società di mutuo soccorso. In Italia il mutuo soccorso assunse una certa importanza verso la metà del XIX secolo ed ebbe per lo più motivazioni umanitarie, soprattutto quella di soccorrere i soci in caso di malattie. Ma anche il mutuo soccorso si sviluppò come reazione al capitalismo. La rivoluzione industriale aveva diffuso l’uso delle macchine e generato molta disoccupazione; e le abitudini di vita dei popoli andavano cambiando, perché il capitalismo difendeva l’individualismo, lo spirito competitivo e l’egoismo e ciò faceva sorgere, per contrasto, il bisogno della solidarietà e dell’aiuto reciproco. Così, oltre a dare sussidi in caso di malattie, le società di mutuo soccorso presero a concedere aiuti alle puerpere e alle famiglie dei soci defunti, sussidi ai disoccupati, pensioni di invalidità e di vecchiaia ed altri contributi di vario genere.
I due aspetti delle origini del cooperativismo che abbiamo menzionato rivelano sia una coerenza che una contraddizione nelle prime manifestazioni di esso. La coerenza sta nel fatto che entrambi gli aspetti di cui si è detto hanno un carattere anticapitalistico; la contraddizione sta nel fatto che organizzazioni che vogliano tendere a soppiantare l’impresa capitalistica, come quelle auspicate da Owen, Thompson e Mazzini, non possono essere di carattere altruistico. Date le caratteristiche della natura umana, dato, in particolare, l’ineliminabile aspetto individualistico ed egoistico che è alla base dei comportamenti umani nell’attività produttiva, un’organizzazione che sia basata fondamentalmente sull’altruismo, la solidarietà o anche lo scopo mutualistico non potrà essere in grado, di regola, di superare in efficienza l’impresa capitalistica, in modo da soppiantarla progressivamente. In altre parole, un’impresa, per essere efficiente, deve far leva sull’interesse individuale; perché, «fintanto che non si allarghi l’ambito dell’altruismo umano», è necessario e ragionevole «fare appello al profondo istinto degli individui di fare quattrini e amare i quattrini, come principale forza motrice della macchina economica» (Keynes, 1931, pp. 241 e 245).
Questo è quanto osservavano lucidamente e senza ambiguità Riguzzi e Porcari nel 1925 (p. 191) che scrivevano che per una cooperativa il successo «al pari dell’impresa privata nel regime attuale come in ogni altro regime, dipende dalla sua capacità di produrre secondo le leggi dell’economia nel modo più perfetto e meno costoso. La cooperazione che vuol battere in breccia, in regime di libera concorrenza, l’impresa privata, deve osservare con la maggior cura e col massimo rigore queste leggi. Sta in ciò la sua ragion d’essere».
Delle due, infatti, l’una. O l’impresa cooperativa si accontenta di coprire uno spazio limitato, cercando solo di sopravvivere in ambito capitalistico, ove le imprese che perseguono il profitto occupano la maggioranza dello spazio, e in tal caso essa può ben far leva sull’altruismo o lo scopo mutualistico; oppure l’impresa cooperativa si propone di affermarsi progressivamente in modo da affrancare l’umanità dal “giogo del salario” e rendere tutti i produttori liberi e padroni di ciò che producono, e in tal caso essa non può basarsi solo sull’altruismo o lo scopo mutualistico e deve far leva necessariamente sull’interesse personale.
3. Le cooperative di produzione
La contraddizione di cui parliamo sembrò che potesse essere risolta con la nascita delle cooperative di produzione, che sono imprese ove i lavoratori diventano “imprenditori di se stessi” (Mill, 1871, p. 739). Le cooperative di produzione sono imprese che eliminano l’intermediazione di chi si assume il compito di organizzare l’attività produttiva e di sopportarne i rischi e che, per questo, si ritiene che acquisti il diritto al sovrappiù, cioè alla differenza tra ricavi e costi. In esse i soci dell’impresa si autorganizzano ed hanno così il diritto di appropriarsi del sovrappiù, il quale, almeno in teoria, può essere liberamente ripartito tra tutti i lavoratori. Nelle cooperative di produzione, quindi, come osservava Mill (1871, p. 744), i soci dell’impresa sono «in una relazione tale rispetto al loro lavoro, da far sì che diventi loro principio e loro interesse – contrariamente a quanto avviene attualmente – di fare il massimo possibile, invece che il minimo possibile, in cambio della loro remunerazione». Ma ciò significa che le imprese cooperative «sono imprese economiche; e, come ogni altra impresa economica, tendono a conseguire fini prettamente economici in modo economico». Di esse, pertanto, bisogna dire che, oltre ad eventuali più nobili motivazioni, è anche «l’egoismo la forza che le crea e che, in seguito, le tiene in vita»; è anche «l’interesse individuale la forza di cui esse sono una manifestazione» (Pantaleoni, 1898, p. 133).
Con la nascita delle cooperative di produzione, dunque, la contraddizione esistente nel movimento cooperativo tra il proposito di abbattere il capitalismo e l’idea di contrapporre all’impresa capitalistica un’organizzazione basata sulla solidarietà avrebbe potuto essere sciolta, perché all’impresa capitalistica venne contrapposta un’impresa non capitalistica, perché gestita dai lavoratori, ma che poteva essere basata anch’essa sui calcoli economici del massimo rendimento. Si può, anzi, dire che la nascita delle cooperative di produzione, più che sciogliere la contraddizione con la scelta di uno dei due corni del dilemma, avrebbe potuto conciliare ciò che appariva inconciliabile, perché, queste cooperative, anche se basate sul movente del lucro, mantennero il carattere anticapitalistico, sia perché toglievano ogni potere al capitale, sia perché stimolavano la solidarietà e, in qualche modo, si alimentavano di essa: i soci di una cooperativa di produzione, infatti, (allora come ora) perseguono un interesse comune e la loro attività produttiva è organizzata in modo che, se qualcuno si sforza di aumentare il suo reddito, ciò avviene contemporaneamente a vantaggio di tutti gli altri.
Per dire la stessa cosa in altro modo, esaminando il problema in astratto, senza riferimento alle vicende storiche, si può osservare che una cooperativa di produzione, secondo la definizione di Keynes, è un’impresa «in cui i fattori della produzione sono remunerati dividendo in proporzioni concordate il prodotto effettivo del loro sforzo cooperativo» (Keynes, 1979, p. 66); e, se ciò è vero, il comportamento razionale di chiunque in essa lavori, perseguendo il massimo utile proprio, è quello di cercare di massimizzare il reddito complessivo di tutta l’impresa (perché in tal modo, insieme al reddito degli altri soci, egli massimizza anche il reddito che sarà a lui attribuito). Di conseguenza, non solo l’egoismo, ma anche la solidarietà e, quindi, un aspetto fortemente di carattere anticapitalistico sono insiti nella natura stessa dell’impresa gestita dai lavoratori.
Vilfredo Pareto è il primo che ha colto, sia pure sotto un diverso aspetto, il carattere contraddittorio che caratterizzò alla nascita le cooperative2. «Esse – egli scrisse (1926, pp. 382-3) – ci presentano un curioso esempio di istituzioni che prosperano grazie a ragioni del tutto diverse da quelle che si credeva dovessero assicurare il loro successo. Lo scopo delle società cooperative era di sostituire alla concorrenza degli imprenditori la solidarietà dei lavoratori. In fatto, le società cooperative hanno semplicemente il risultato di far comparire sul mercato nuove imprese concorrenti». A giudizio di Pareto, in altre parole, le cooperative, mentre proclamano di far leva sulla solidarietà, sono, a ben vedere, imprese non molto dissimili dalle altre, che riescono a far concorrenza alle imprese capitalistiche perché sono basate sull’interesse personale. E Pareto commentò l’opposizione alle cooperative degli economisti suoi contemporanei osservando che essi, invece di applaudire alla nascita di un nuovo tipo di imprese che facevano concorrenza alle imprese capitalistiche, «hanno avuto il torto gravissimo di combatterle». Così «essi hanno gratuitamente proclamato la necessità degli intermediari, quali esistevano» (Pareto, 1926, p. 384).
Come si diceva, dunque, il carattere contraddittorio che caratterizzò alla nascita il movimento cooperativo, ragionando in astratto, avrebbe potuto essere eliminato con la nascita di cooperative di produzione, che perseguissero il fine di lucro; ma nei fatti questo non è avvenuto, sino ai nostri giorni. Ciò si spiega con la considerazione che il movimento cooperativo si è alimentato alle origini così fortemente della critica alle brutture della concorrenza che alle cooperative non si è voluto consentire di perseguire liberamente il fine di lucro. Nella sua storia del movimento cooperativo, Beatrice Potter (più nota, poi, come Beatrice Webb) sottolineò con forza “la distinzione radicale” tra “il Credo della Concorrenza Universale” e l’“Idea Cooperativa”, che spiega la natura delle prime cooperative: l’impresa capitalistica, ella scrisse, è basata sulla legge biologica della sopravvivenza del più forte, della sopravvivenza del più adatto nella lotta per la vita; l’impresa cooperativa, all’opposto, trae la sua ragion d’essere nella convinzione, egualmente di carattere biologico, che “la funzione crea l’organo”, cioè che la modificazione della funzione determina la modificazione della struttura (cfr. Potter, 1893, pp. 18-19). E, poiché entrambe le l...
Indice dei contenuti
- CoverImage
- Jossa - Cooperativismo capitalismo e socialismo
- 1. L’impresa cooperativa come alternativa all’impresa capitalistica
- 2. Come le cooperative vanno organizzate secondo la teoria economica d’oggi
- 3. Sui pregi dell’impresa cooperativa
- 4. Impresa cooperativa, occupazione e fallimenti
- 5. Sulla transizione dal capitalismo all’autogestione
- 6. Democrazia nelle imprese ed evoluzione spontanea
- 7. Conclusioni