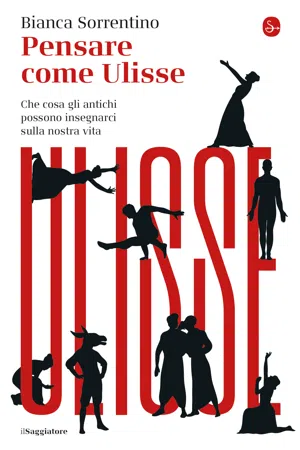![]()
1. Sulla soglia dell’eterno
Felice chiunque abbia i propri luoghi della durata!
Egli, anche se venisse portato lontano
senza prospettive di ritorno nel suo mondo,
non sarà più un esule.
Peter Handke
Passeggiare lungo via dei Fori Imperiali, nella luce irrevocabile di Roma, così arcana, così netta, è già compiere un viaggio. Nelle giornate più fredde, in cui il cielo giganteggia e non lascia scampo, percorrere il cammino che dal Colosseo conduce a piazza Venezia significa attraversare una parentesi di bellezza nella quale persino le rovine diventano sinonimo di splendore; la Storia pare offrirsi senza veli allo sguardo del passante, in un continuo fluire, dai gloriosi fasti dell’antico alla spiritualità che le cupole delle chiese barocche sembrano suggerire, dalla celebrazione degli ideali legati alla Patria fino alle fitte ombre del Novecento – estremo monito con cui è ancora necessario fare i conti, nonostante il rischio di negligenti dimenticanze. Neanche le gru, che con il loro gelido ferro sovrastano il cantiere della metropolitana in costruzione, sanno svilire l’energia che dal Foro promana, perché, seppure in maniera distonica rispetto alla grandiosità circostante, dicono del tempo in divenire, che talvolta si attarda, ma non si ferma mai, come le nostre piccole vite, talora in affanno, talora sospese.
Nel vortice rumoroso dei giorni, alcuni luoghi, come questi in cui ci si imbatte continuamente nella capitale, custodiscono ancora la radice dell’umano, interrompono la pazza rincorsa delle lancette e sospendono in un eterno presente i segni del comune sentire. E se alle metropoli tocca fare i conti con il turbinio inarrestabile del tempo che travolge ogni cosa, se i grattacieli simbolo del progresso devono accettare il lento opacizzarsi del loro originario smalto, se le smart city del domani sono già condannate a divenire archeologia industriale, esistono oasi segrete in cui si avvera il miracolo della durata.
Chi attraversa questi spazi si sente ricongiungere alla propria essenza più profonda e, insieme, avverte la sensazione di essere parte di un flusso inesorabile, come ha scritto il premio Nobel Peter Handke in un poemetto del 1986, Canto alla durata:
Quando mi avvicino a questo luogo,
[…] posso sperare nell’incanto
in cui ogni mio rimuginare si dissolve
e il mio pensare diviene un puro riflettere sul mondo.
Le chiacchiere dentro di me,
un tormento fatto di molte voci,
lasciano il campo alla meditazione,
una sorta di silenzio redentore.
[…]
Porto sulle mie spalle i miei predecessori e i miei successori,
un peso che mi eleva.
Risalendo ai secoli lontani in cui altri hanno abitato quei posti, e proiettandosi verso un futuro dai contorni ancora imprecisi – in cui passi differenti percorreranno il medesimo cammino –, colui che accoglie la grazia della durata riesce a trovare un inedito riscatto alla prigionia della solitudine, e ad accorgersi che ogni luogo è abitato da moltitudini di spettri già passati di qui o che, presto, di qui passeranno.
Assecondando l’ispirazione del Canto di Peter Handke, si potrebbero immaginare i classici proprio come «luoghi della durata»: spazi immortali di un sentimento che ci affratella e che di generazione in generazione si tramanda come un racconto intorno al fuoco, vincendo la patina del tempo e l’ostilità delle mode passeggere destinate a tramontare.
Sarà opportuno tuttavia mettere in guardia il lettore: se l’idea di un’eredità incorruttibile può infondere coraggio in questo tempo liquido e impastato di precarietà, non bisogna credere che il patrimonio classico sia un pedissequo portatore di certezze incrollabili. Il lascito degli antichi è, contrariamente alle aspettative di molti, materia viva e, in quanto tale, generatrice di dubbi e inquietudini. È un magma che, mentre ribolle, agita le nostre irriducibili contraddizioni.
Non è possibile – né gioverebbe farlo – ricomporre la complessità dell’antico o appiattirne gli slanci e gli spigoli; anzi, ammirare il caleidoscopio di visioni luminose e figure d’ombra che da quell’universo proviene permette di apprezzarne la vitalità e di cogliere tutte le inaspettate somiglianze che ancora ci avvicinano agli antichi.
Sebbene il gusto evolva, accordandosi allo spirito dei tempi, e nuove, urgenti istanze impongano una meditazione lucida su ciò che ormai avvertiamo come lontano, è innegabile l’esistenza di una sostanziale prossimità tra quel che siamo e quel che siamo stati: al netto delle distanze insanabili, cioè, il modo in cui pensiamo, agiamo, osserviamo il mondo non è altro che il riflesso di una tradizione brulicante di miti, simboli e racconti che hanno fecondato un terreno fertile e hanno generato frutti che non sanno marcire.
Chiunque si specchi negli eroi (e negli antieroi) dell’epica greca, per esempio, non potrà fare a meno di riconoscersi nelle debolezze, negli eccessi, nelle doti risolutive, insomma nei tratti che li rendono visceralmente umani. Talvolta ai personaggi che popolano le storie dell’antico è concesso di evadere dalle pagine dei manoscritti e di stabilire nelle terre del visibile una durevole dimora: accade così che le petrose regioni della Grecia, i vulcanici promontori siciliani, le coste assolate del Lazio ospitino l’incanto del mito, restituendone una tangibile geografia.
E se il teatro ateniese non smette di suggerirci riflessioni intorno alle urgenti questioni della democrazia e della giustizia, Delfi ci esorta a ripensare il senso del sacro, che da qualche parte abbiamo smarrito; le isole che come luminose costellazioni affiorano nell’Egeo suscitano considerazioni sulla solitudine, il male del nostro tempo, e sul significato autentico di comunità; infine la riviera di Ulisse, su cui aleggia la presenza spettrale di Circe, fa da scenario a un discorso estremamente attuale sull’identità, sulla consapevolezza del sé quando si relaziona con l’altro.
Questo nostro stare sulla soglia dell’eterno ci permette così di frequentare due mondi, di coglierne il dialogo silenzioso e duraturo, di rintracciare antiche ferite e memorie nei luoghi delle nostre modernissime e vive inquietudini.
Atene e l’avvento della democrazia
Come strategica cerniera tra il centro sacro di Atene, l’acropoli, e il cuore della vita civile, l’agorà, si staglia roccioso l’Areopago, il colle di Ares, il luogo in cui, secondo la leggenda, il dio della guerra fu processato per aver ucciso il figlio di Poseidone. L’altura costituisce lo scenario in cui un’altra celebre vicenda mitica trova il suo avvincente scioglimento – decisivo per le allusioni storiche di cui l’evento si carica.
Dopo dieci anni di assedio alla rocca di Troia, finalmente la guerra è vinta e Agamennone, sovrano di Argo, può intraprendere con la sua flotta il viaggio verso casa. L’Orestea, la trilogia composta dal tragediografo Eschilo, racconta che ad accoglierlo c’è sua moglie Clitemnestra, la quale, con parole lusinghiere e dichiarazioni di ostentata fedeltà, saluta il rientro del marito. In realtà l’assenza del re ha generato un vuoto, non tanto istituzionale – il suo posto l’ha preso infatti a tutti gli effetti la regina, il cui «cuore di donna da uomo decide, fremente» –,1 quanto sentimentale: a differenza di Penelope, che ha saputo sopportare la lontananza di Ulisse perché forte di un vissuto comune, Clitemnestra ha subito le decisioni del marito senza mai condividerle e la distanza di Agamennone non ha fatto altro che esacerbare il risentimento della donna. Il suo livore si acuisce poi di fronte all’ennesimo oltraggio: sul cocchio del re appena tornato c’è anche Cassandra, la principessa troiana bottino di guerra. Subito la regina esorta le schiave a stendere ai piedi di Agamennone drappi purpurei: si tratta di un onore riservato agli dei e l’uomo, acconsentendo a calpestarli, compie un atto di hýbris, di tracotanza. Il rosso dei tappeti srotolati da Clitemnestra si carica di ulteriori significati simbolici: da un lato, esso richiama il rosso della morte di Ifigenia – la figlia offerta in sacrificio prima della partenza per Troia –, dall’altro, esso allude, per mezzo dell’ironia tragica, al rosso del sangue nella vasca in cui Agamennone verrà assassinato.
Dopo l’omicidio del re, perpetrato con premeditazione dalla regina con l’aiuto del suo amante, Egisto, il figlio Oreste vendica l’assassinio del padre, macchiandosi così di matricidio. Il gesto criminoso richiama l’intervento delle Erinni, divinità ctonie che puniscono chi compie delitti contro i consanguinei; le spaventose dee della vendetta perseguitano il ragazzo con visioni terribili, allucinate e cruente, e lo costringono a una fuga che non conosce tregua. La precipitosa rincorsa si conclude ad Atene, dove viene istituito un vero e proprio tribunale: a sostenere la difesa è Apollo, il dio che ha ispirato il moto di Oreste, mentre l’accusa spetta alle Furie; la giuria, composta da dodici cittadini, si esprime con un sostanziale pareggio – sei sono le pietre nere, a detrimento dell’imputato, sei quelle bianche, a favore della sua innocenza. L’ultima parola compete ad Atena, che con il suo voto insindacabile garantisce al figlio di Agamennone una definitiva assoluzione e sancisce la trasformazione delle Erinni in Eumenidi, divinità benevole, custodi dell’ordine. La dea, in effetti, promettendo onori eterni da parte della città di Atene, riesce a placare la rabbia e il rancore delle Furie spietate, lasciando loro intendere che si appresta un rinnovamento improrogabile, un tempo in cui i nuovi dèi non saranno più disposti ad accettare la violenza cieca delle antiche potenze.
In chiave simbolica, il racconto illustra il passaggio dall’antica legge del taglione alla civiltà del diritto e segna dunque l’avvento delle istituzioni democratiche. Politica e senso civile sono il cuore pulsante del teatro greco, il quale è espressione di un acceso dibattito sull’attualità che coinvolge spettatori e drammaturghi – funzione altissima dell’arte scenica, che oggi costituirebbe una preziosa bussola per orientarci nel nostro tempo smarrito. Nell’Orestea, Eschilo dà voce alle questioni stringenti della sua epoca: l’urgenza del diritto di voto, le faide di sangue, le guerre civili. La trilogia eschilea vince gli agoni tragici del 458 a.C.: viene composta, cioè, negli anni immediatamente successivi alle riforme democratiche di Efialte; quest’ultimo, insieme al giovane Pericle, si era fatto promotore di un cambiamento, in virtù del quale i poteri politici venivano affidati al consiglio popolare dei Cinquecento, mentre le funzioni giudiziarie spettavano a cittadini tratti a sorte; nel frattempo l’introduzione della mistoforía, cioè l’indennità giornaliera per coloro che ricoprivano pubblici uffici, avrebbe garantito la partecipazione alla vita politica anche ai ceti più disagiati.
Nel dramma eschileo, la dea che sovrintende alla città di Atene dona alla pólis un lascito immortale: «né anarchia né dispotismo» consiglia Atena «questo tribunale […] io lo istituisco […] incorruttibile, venerabile, inflessibile, una sentinella che sempre veglia sul sonno altrui, una guardia a presidio di questa terra».2
L’ordinamento su cui si regge la comunità riesce dunque, attraverso la razionalità del lógos e della legge, a sciogliere quei rimorsi, rappresentati metaforicamente dalla furia delle Erinni, che tormentano la coscienza dell’uomo per mezzo di interrogativi apparentemente insolubili sulla giustizia divina e umana.
Tra le righe della tragedia risuonano in tutta la loro potenza alcune domande, espressione di una mentalità arcaica: può l’assassinio del padre restare invendicato? È lecito commettere un ulteriore crimine per rivalersi di quell’offesa, per di più lavandola con il sangue della propria madre? Simili dubbi aleggiano sul dibattito pubblico ancora oggi, quando episodi efferati di cronaca nera dividono gli animi: sui giornali leggiamo talvolta di casi particolarmente penosi e complessi, di famiglie inesorabilmente lacerate da anni di abusi e aggressioni, condannate a un esito tragico. Attraverso il teatro, la società greca si interrogava intorno a temi rilevanti per l’intera comunità e rifletteva sul conflitto insanabile che portava una presunta giustizia (la legge del taglione) a trasformarsi in ulteriore rovina; spesso anche noi siamo chiamati dall’attualità a prendere posizione su questioni altrettanto gravi (i femminicidi, le violenze domestiche, gli omicidi tra consanguinei) e a riconoscere che le conquiste del diritto, come l’abrogazione del cosiddetto delitto d’onore, sono necessarie per sancire la supremazia della civiltà, laddove serpeggia ancora la malsana convinzione che la reputazione offesa debba essere vendicata.
Nel testo eschileo, Oreste tentenna prima di agire – non è un semplice burattino nelle mani degli dèi, né un mero esecutore dei desideri rancorosi della sorella Elettra, gonfia di odio. Di fronte all’azione, il ragazzo reagisce con un ennesimo quesito, «cosa farò?», rivolto all’amico Pilade. Quest’ultimo gli ricorda la volontà del dio Apollo e lo esorta a compierla. Il senso del sacro che permea la civiltà ellenica influisce sulla condotta dei mortali: la devozione nei confronti della divinità e di suo padre Agamennone arma la giovane mano di Oreste.
La nostra sensibilità ci impedisce di cogliere appieno la dimensione religiosa che fa da sfondo a quel gesto rimasto nel mito, forse perché siamo eredi del temporeggiare di un altro orfano, che con le sue inquietudini inaugura la letteratura moderna: Amleto. Anche il principe di Danimarca deve vendicare il padre, assassinato in una sordida congiura ordita dalla regina e dallo zio usurpatore; tuttavia il protagonista ne sente tutto il peso...