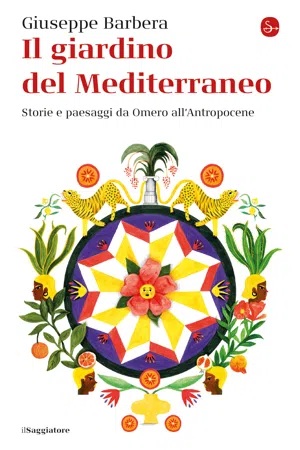1. Il Mediterraneo o la diversità
Mar d’Affrica
Il vento cambia spesso direzione e con esso la luce, la consistenza dell’aria e i profumi. Quando soffia il maestrale, l’aria è fresca e tersa e si avvertono, non stemperati nel vapore dell’acqua che il calore del sole sottrae al mare, i profumi delle fioriture d’inverno o di primavera o, in estate, quelli penetranti, acuti, degli olii essenziali e delle resine degli arbusti e degli alberi della macchia e della foresta mediterranea.
Nell’isola di Pantelleria, in giornate così, è inevitabile essere distratti dal profilo che la sponda tunisina segna all’orizzonte: 38 miglia marine non bastano a celare la sagoma scura di Capo Bon, il promontorio con cui termina a nord la penisola che chiude il golfo di Tunisi, e il litorale di Nabeul; questo di giorno come di notte, quando le terre africane sono svelate dal punteggiare dei fari e dalla luminosità diffusa degli abitati. Al tramonto il sole si schiaccia sul mare e può accadere – dipende dal suo percorso nell’arco delle stagioni – che il profilo della Tunisia si ritagli sul disco aranciato che sembra sciogliersi nell’appoggiarsi sull’acqua, per poi affondare lanciando riflessi caleidoscopici. Qualche volta (in conseguenza della scomposizione della luce) lampeggia rapido un raggio verde che, affermano antiche leggende avvalorate da un «viaggio straordinario» di Jules Verne, «ha la virtù di fare sì che chi l’ha visto non possa più ingannarsi nelle cose che riguardano il sentimento; […] chi è stato tanto fortunato da vederlo una volta, vede chiaro nel proprio cuore e in quello degli altri».
Si pensa l’Africa lontana e invece è vicina, addirittura a vista. Si torna a scrutare l’orizzonte: la costa si mostra lunga e distesa; è il tratto visibile di un continente. Se ribaltiamo il punto di vista, dalla sponda tunisina, con il sole alle spalle, si può invece scorgere appena il breve segmento occupato da Pantelleria e succede anche lì, come lungo tutta la costa magrebina dove le montagne fanno frangia al mare, che è sufficiente salire appena sulle pendici per riuscire a scorgere l’Europa (fosse anche una piccolissima e periferica parte) e passare qualche ora a sognare e desiderare altri mondi possibili.
L’isola è meta temporanea che non si trova sulle usuali rotte dei migranti che partono dalle coste libiche verso il continente europeo favoriti dal disordine politico, dalla ferocia di mercanti senza scrupoli e dalla indifferenza (o il lucido disegno) dei governanti. I pochi che sbarcano clandestinamente a Pantelleria sono accolti con generale benevolenza ed è con dispiacere che viene comunicata loro la risposta quando dopo poco chiedono dove sia la stazione ferroviaria.
La traversata del Canale di Sicilia, se il vento è favorevole e il mare è calmo, può durare anche solo un giorno che passa velocemente tra l’emozione di solcare acque mai immaginate così vaste e l’invidia per il passaggio deciso e sicuro degli uccelli migratori (nibbi, poiane, falchi pescatori, aquile, albanelle, cicogne e anatre, fenicotteri). Questi, in libero volo tra Europa e Africa, si servono di Pantelleria come momentaneo luogo di riposo, sostano presso l’accogliente lago di Venere (l’antico «Bagno dell’Acqua») e riprendono quota sfruttando le correnti di aria calda ascensionale che, assenti in mare aperto, si formano al risalire lungo la montagna.
Fino a qualche anno fa i migranti venivano accompagnati dagli isolani al porto dove parte la nave per Trapani e in piccoli gruppi riuscivano solitamente a imbarcarsi senza destare sospetti, mimetizzandosi tra turisti e locali che volentieri si rendevano complici. Il pericolo corso e la fatica provata per giungere sull’isola, attraverso prima il deserto e poi il mare, erano motivo di solidarietà sia per chi abitava stabilmente Pantelleria (da sempre luogo di emigrazione verso terre più generose) e ne riconosceva l’angustia spaziale e la voglia di evadere, sia per chi l’aveva scelta come luogo di vacanza appagando una privilegiata, seppure provvisoria, ricerca di libertà. La testimonianza del loro arrivo rimaneva nei vestiti abbandonati sugli scogli, zuppi dopo la traversata e poi rinsecchiti dal sole e sostituiti da altri ritenuti più dignitosi e comunque asciutti, trasportati in sacchi impermeabili. Un relitto di tanti colori, infranto sugli scogli e portato a secco, giaceva da qualche anno, squarciato sul fianco, nei pressi del porto. Adesso è stato demolito, ignorando storia e memoria, e non può più ricordare ai panteschi, suscitando orgogliosa commozione, quella notte del mese di aprile del 2011 trascorsa a cercare di trarre in salvo dal naufragio donne e bambini.
Quando il vento è caldo e umido di scirocco, la Tunisia è, invece, nascosta dalla foschia e il cielo, seppure sereno, si confonde con il mare; insieme sfumano tra le nebbie che il calore della terra condensa sul cono della montagna e che impediscono la vista dell’orizzonte. In giorni come questi, neanche il sollievo dell’ombra di un muro di pietre a secco né quella dei pochi alberi della campagna che crescono alti nel vento frequente e intenso, riesce a concentrare l’attenzione. Lo sguardo non trova confini nelle strie tracciate dalle correnti marine, nelle velature del cielo, nella composizione sempre mutevole di nuvole illuminate, candide in piena luce o arancioni, rosa, rosse addirittura, plumbee quando manca il sole, e nelle notti piene di stelle e di rumori che appartengono solo al dominio delle onde e del vento. Tra luce e ombra, tra Africa ed Europa, tra Oriente e Occidente, spazio e tempo si dilatano senza limiti e Pantelleria ostenta allora il suo isolamento: pur sempre tappa ideale per attraversare il Canale di Sicilia, per avventurarsi nei viaggi di piccolo cabotaggio attraverso il «Mar d’Affrica» o «Mar Libico», come lo chiamano le vecchie carte nautiche. Anche dalla costa siciliana si può scorgere un profilo scuro che lo scrittore polacco Jarosław Iwaszkiewicz vedeva «come una nuvola adagiata sul mare, la remota, irreale, già africana Pantelleria» e, un tempo, nella navigazione ci si orientava basandosi sulla cima della Montagna Grande, che emerge oltre 800 metri, coperta di querce e pini: riserva di legna per accendere fuochi e così segnalare, nell’oscurità della notte o della foschia, la presenza di scogliere rischiose per i navigatori.
Natura, storia e contemplazione
Sul tetto dell’isola non si sosta tra i corbezzoli e i mirti a contemplare un’«ampia e bella veduta qual può abbracciarsi con lo sguardo» – stando alla definizione di «panorama» da parte del dizionario Treccani –, o a scrutare uno spazio indefinito (la vista si perderebbe oltre i campi coltivati e gli arbusti selvatici che dal termine del bosco si collegano all’orlo degli strapiombi sul mare), o a osservare un territorio delimitato da confini geografici o amministrativi. Non è neanche un «ambiente» quel che si osserva; questo, infatti, è nozione ecologica: secondo il dizionario Devoto Oli: «L’insieme delle condizioni fisico-chimiche e biologiche che permettono e favoriscono la vita degli esseri viventi», mosaico di ecosistemi cui partecipano piante, animali, microrganismi, aria, acqua e suolo coinvolti, lungo catene alimentari, in un comune e continuo flusso di energia e circolazione di materia. Dalla cima di una montagna, invece, la vista spazia nella lunga distanza, l’orizzonte si allontana e tutto ciò che è compreso tra il suo definirsi e l’osservatore è invece propriamente «paesaggio», insieme di caratteri fisici e tangibili di un’area, attività dell’uomo, significati o simboli impressi attraverso lo sguardo nella sua coscienza. Come afferma, con la Convenzione europea del paesaggio del 2000, il Consiglio d’Europa: il paesaggio «designa una determinata parte di territorio, così come è percepita dalle popolazioni, il cui carattere deriva dall’azione di fattori naturali e/o umani e dalle loro interrelazioni».
La differenza semantica si svela seguendo i tornanti stretti e ripidi della strada sconnessa o i sentieri che salgono sulla montagna di Pantelleria. La natura si esibisce dal cielo al mare, dalla costa al piano e lungo il pendio, variabile nelle forme geologiche, nelle espressioni climatiche, nelle caldere vulcaniche pianeggianti e coltivate, lungo i pendii terrazzati, nella vegetazione, nella flora che la compone e nella fauna che ospita, nella macchia, i boschi, le praterie nude per la terra superficiale, la roccia affiorante e il vento salmastro. La storia è nelle tombe megalitiche, nelle rovine romane, nelle piccole architetture di segno arabo, nelle casermette dell’ultima guerra, nei muretti senza tempo, nei segni inevitabili e disordinati della contemporaneità. La lentezza del procedere, segnata dal ritmo imposto dal passo e dal fiato, trasforma lo spazio, l’ambiente, il panorama in paesaggio, prolunga e approfondisce l’attenzione. Alla natura e alla storia si unisce la contemplazione e, attraverso essa, i ricordi, la bellezza, l’emozione poetica. L’umano ha modo di confrontarsi con l’inumano per creare un paesaggio.
Le forme del paesaggio, il loro nascere dal mondo della natura, dal lavoro e dalla conoscenza dell’uomo si svelano salendo la montagna mentre l’orizzonte si amplia e lo sguardo si arricchisce della riflessione. Una delle ascensioni più importanti della storia, «in cerca di un punto di vista più alto, di un’unica occhiata» fu quella che compì Alexander von Humboldt nel 1802 sul Chimborazo, una montagna andina che raggiunge 6300 metri e che all’epoca era considerata la più alta del mondo. Non riuscì, carico di strumenti scientifici e afflitto dal mal di montagna, a raggiungere la vetta ma fatica, tempo, pericoli lo portarono a una visione della natura, «microcosmo in un sola pagina», che avrebbe cambiato la storia della scienza. Nei suoi appunti, accompagnati da disegni, e poi nei cinque volumi di Kosmos ai quali lavorò per più di due decenni, il geografo e naturalista tedesco intendeva dimostrare che
la natura è un insieme vivente […] le forze organiche lavorano senza sosta interagendo una con l’altra […] in questa grande catena di cause ed effetti non c’è un sol fatto che possa essere considerato isolatamente.
Humboldt riflettendo su quel viaggio ha avviato la cultura moderna a una visione della natura che solo molto più tardi (anni venti del xx secolo) sarebbe stata definita olistica. Con lui nasce la moderna concezione di paesaggio, «totalità dei caratteri di un territorio» – seppure il termine e la definizione che gli è attribuita non compaia nei suoi scritti – che comprende natura, storia, conoscenza, in una somma che è maggiore delle parti.
A guidarlo era l’intento di
descrivere la natura in maniera tale da restituire il più possibile il piacere immediato della visione e al tempo stesso contribuire, sulla base dell’attuale stato della scienza, a una maggior comprensione dell’armonico nesso che governa l’agire delle forze naturali.
L’unità della natura è nelle forme geologiche, nelle rocce e nei suoli in cui si sono trasformate, nelle acque profonde e superficiali, nel clima che concorre a determinare caratteri fisici e scambi e flussi, nelle piante e negli animali, in tutte le forme viventi. A modificarla è poi intervenuto il lavoro degli uomini, nel tempo della storia e la comprensione che di essa ha chi lo abita, lo attraversa, chi in essa deposita, trova e condivide identità, memorie, emozioni, sentimenti, ispirazioni per espressioni artistiche. La cultura dell’uomo trasforma la natura, la vista diventa sguardo e con esso la definisce, nella diversità che distingue comunità e singoli individui, la percepisce e la contempla. La storia dell’uomo, il suo lavoro accumulatosi nei secoli e la cultura che lo sottende rendono la natura un’oggettiva costruzione umana.
L’ambiente che diventa paesaggio, ha scritto il filosofo siciliano Rosario Assunto, «è natura promossa a cultura […] è quello in cui viviamo le nostre speranze e i nostri disinganni, le nostre gioie e le nostre pene».
Ascensioni
Accompagno spesso chi visita Pantelleria in cima alla montagna a scoprire una sorprendente natura boschiva, a rabbrividire per il freddo inaspettato dell’altitudine o per nebbie che sembrano continentali, a stupirsi della vista dell’Africa. Durante la camminata mi capita spesso di ripensare a un’altra ascensione che precede di cinque secoli quella di Humboldt ed è considerata altrettanto importante per chi si interessa di paesaggi: quella di Francesco Petrarca al Mont Ventoux, nell’aprile del 1336. Nel racconto – in una delle sue lettere Familiares – di quell’episodio, la cultura occidentale si trovò a scoprire il piacere della veduta che diventa paesaggio attraverso la sapienza di chi guarda.
Conosco la montagna provenzale, la sua sommità spoglia di alberi e assolata, per averla osservata tante volte negli oziosi pomeriggi estivi davanti alla televisione quando è percorsa dai ciclisti affannati del Tour de France, e il mio interesse per la corsa è solitamente distratto dalla natura pietrosa della sommità dove è posto il traguardo. Non è però questa a incantarmi, ma la rappresentazione di cui è parte: per me, solo una corsa ciclistica; per Petrarca, la natura di cui si limita a indicare rocce «denudate», Alpi «ghiacciate e innevate», che diventa paesaggio quando in lontananza riconosce il Rodano, il mare e il cielo italiano che appare «più al cuore che agli occhi». Paesaggio che è per lui fonte di stupore, ammirazione e contemplazione («dapprima, colpito da quell’aria insolitamente leggera che mai avevo provato e da quello spettacolo grandioso rimasi come stupefatto»).
Sul Ventoux era salito «mosso unicamente dalla curiosità di vedere un luogo famoso per la sua altezza». Suo malgrado trova altro: oltre i significati allegorici di una salita che sembra condurlo allo smarrimento e poi al ritrovamento della retta via, scopre l’importanza dello sguardo interiore. Complice di questo movimento dell’anima è un libro; è grazie a esso che Petrarca, seppure indispettito per aver compreso che non solo a Dio deve rivolgersi ma anche al proprio animo, si apre al paesaggio; in esso riconosce non solo lo specchio d...