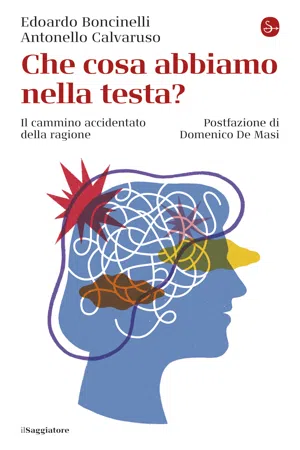![]()
Introduzione
Non ci sono molte alternative
all’uso della ragione. Il punto è
se questa deve essere usata
per ragionare o per sragionare.
Edoardo Boncinelli
Se giungendo in stazione mi accorgo di aver perso un treno per tre minuti, mi rammarico di più, molto di più, che se l’ho perso per mezz’ora o un’ora. Perché?
Compro un berretto e una felpa della mia squadra preferita pagando 110 euro. Se so che la felpa costa 100 euro più del berretto, quanto mi costa il berretto? Riflettendoci a freddo, dirò quasi certamente 5 euro, ma a caldo la maggior parte delle persone, inclusa la metà degli studenti di prestigiose università degli Stati Uniti, dirà 10 euro, commettendo un errore marchiano. Perché?
Ho in genere molta più paura di salire su un aereo che su un’auto, anche se le statistiche di tutto il mondo dicono che è più pericolosa l’auto. Perché?
Perché moltissime persone sono convinte che non ci siano mai stati tanti delitti come oggi?
Perché qualcuno è convinto che una persona brava in matematica e fornita di un potente calcolatore non possa fare altro che vincere al tavolo della roulette?
Questi esempi mostrano come ci si possa ingannare, di poco o di tanto, nel valutare le varie situazioni. Valutare e soppesare sono le operazioni mentali che precedono un’eventuale scelta, che sia eccezionale o parte del nostro quotidiano. Le domande che sorgono da queste considerazioni sono due: «Perché sbagliamo alcune valutazioni?» e «Come facciamo a sapere che quelle sbagliate sono sbagliate?».
La risposta alla seconda domanda è semplice: un po’ di riflessione, qualche calcolo aritmetico, un’utilizzazione intelligente della statistica e dei dati statistici e in ogni caso un rigoroso ragionamento, sveleranno sicuramente gli errori, anche se questa operazione può richiedere tempo e sarà verosimilmente diversa da caso a caso. Anche la risposta alla prima domanda è in fondo semplice: «Perché spesso andiamo di fretta, ragioniamo in maniera superficiale e sbrigativa e ci basiamo su conoscenze o convinzioni malsicure, soltanto perché sono le prime che ci vengono in mente». È insomma tutto un problema di precipitazione, specialmente se accompagnata da un interessamento tiepido e talvolta anche da testardaggine.
Che cosa si può fare? Innanzitutto capire. Senza idee preconcette, se è possibile.
Noi esseri umani siamo sempre stati fieri di possedere un cervellone e di saperlo usare. Non a caso ciò che ci distingue da altri tipi di esseri viventi risiede nel nostro esser dotati di ragione, o almeno così si è sempre pensato e si pensa tuttora. La definizione dell’uomo come “essere razionale” ne è d’altronde una conferma.
Comunque si voglia definire la razionalità – e non è così facile –, è abbastanza chiaro che essa deve riguardare tanto la nostra capacità di intendere correttamente ciò che ci serve sapere, quanto quella di risolvere i problemi che via via ci si presentano. L’unica minaccia seria per la razionalità sembra provenire dall’esistenza di un’irriducibile e turbinosa provincia del nostro animo che ci tiene spesso in scacco e che corrisponde più o meno al termine “cuore”. A quest’ultimo Blaise Pascal attribuisce molto opportunamente il possesso di «ragioni che la ragione non conosce».
Da tempo abbiamo intuito, però, di non riuscire a essere sempre e del tutto razionali. Già nel 1955 Herbert Simon aveva infatti parlato di una «razionalità limitata» come caratteristica del comportamento umano. Razionalità limitata appare una felicissima espressione per descrivere la particolare condizione nella quale sembra operare la nostra mente, in rappresentanza del nostro cervello: razionale sì, ma non al cento per cento e non sempre. L’aggettivo “limitata” si riferisce a una condizione di imperfezione della nostra razionalità, per quanto riguarda l’estensione o il rigore. Imperfezione relativa, si badi bene, e ipotetica, perché manca un termine di paragone concreto, ovvero una ragione perfetta o assoluta che a prima vista non sembra difficile da immaginare e della quale si parla da secoli. Non stiamo parlando del fatto che il nostro cervello magari non arriverà mai a comprendere certe cose, ma stiamo molto più prosaicamente parlando dell’osservazione che nel momento di manipolare certi concetti e certe affermazioni il tessuto logico del nostro ragionamento rivela alcune smagliature. A volte veramente preoccupanti. E questa è un po’ una sorpresa.
La sorpresa cresce e prende connotati più nitidi se ci si accinge a un esame sistematico delle risposte che persone diverse danno a domande che presentano qualche difficoltà, piccola o grande che sia. Questo tipo di indagine è stato intrapreso quasi mezzo secolo fa e negli ultimi decenni ha dato risultati molto interessanti, sempre nuovi e spesso sorprendenti, dando vita a una disciplina che possiamo chiamare psicologia cognitiva, nel quadro di un’impresa scientifica di più ampio respiro che prende generalmente il nome di scienze cognitive o anche di neuroscienze cognitive.
Da qualche decennio la ricerca scientifica ci sta raccontando cose incredibilmente interessanti un po’ su tutti i fronti della conoscenza, dalle stelle e dalle galassie nel cielo alla correzione di geni difettosi dentro le nostre cellule, dallo sviluppo di robot e di computer sempre più potenti alla comprensione di anno in anno più approfondita del funzionamento del sistema nervoso e del nostro cervello. In questo campo le scienze cognitive associate a una rampante neurobiologia ci hanno fornito una messe di risultati che nessuno si sarebbe potuto aspettare e che ci rendono un po’ più familiare il funzionamento del nostro cervello. E non solo.
Tra questi risultati spiccano quelli sull’efficienza del nostro raziocinio. Si osserva spesso che anche quando un individuo “ce la mette tutta” per essere razionale, a volte incespica e produce qualcosa di traballante e confuso, se non addirittura di superficiale e arbitrario. L’osservazione quotidiana non può che confermare questo stato di cose spesso contraddittorio e che fino a poco tempo fa risultava un terreno poco fertile per la riflessione. Dal momento, però, in cui è stata data più attenzione a questa particolarità, non è stato difficile stilare l’elenco di una serie di inadempienze più o meno specifiche, alcune di natura individuale e altre di natura sociale.
La descrizione e la comprensione di questi fenomeni, che ovviamente ci riguardano molto da vicino, sono state negli ultimi anni oggetto d’innumerevoli studi approfonditi e specificatamente mirati. In queste righe troverà posto l’esposizione di alcuni risultati scaturiti da questa ricerca tanto schietta da mettere a fuoco, a volte impietosamente, la fragilità e la gracilità di molte delle nostre doti, la cui consapevolezza accresce di molto la nostra capacità di comprenderci. Senza dubbio ciò costituisce anche una grande avventura intellettuale, con il vantaggio mai abbastanza sottolineato di poter lavorare su dati di fatto e su esperienze faticosamente ottenute partendo da ipotesi falsificabili, quindi non vuote di significato o arbitrarie come si è usato in passato. La storia che racconteremo è anche, senza alcun dubbio, una delle più belle che si conoscano.
A cosa porta tutto questo? Come tutte le avventure scientifiche che danno risultati interessanti e corroborati da una grande quantità di fatti, anche questa nuova concezione di alcuni nostri processi mentali può essere vista da due punti diversi: può essere goduta in sé e per sé come una più approfondita visione della realtà e può essere messa a frutto per riuscire a districarci meglio nella selva delle occasioni offerte dalla nostra vita. Da una parte, insomma, soddisfazione intellettuale; dall’altra, applicazione pratica. Nessuno, sia ben chiaro, può riuscire a comportarsi in ogni circostanza in maniera ineccepibile – l’essere umano possiede certe caratteristiche che sono sì modificabili, ma non oltre un certo limite –, però si può rendere molto più consapevole e riflessivo il nostro navigare nel mondo della vita.
E non è finita qui. Vedremo che il grosso di questi risultati riguarda il funzionamento della testa di un individuo, chiunque egli sia, ma è sempre più chiaro che problemi seri si profilano anche a livello dei gruppi più o meno numerosi di individui, quando non dell’intera società. Nonostante oggi si sappiano tantissime cose e molte di queste siano accessibili a chiunque senza grande difficoltà, intorno a noi osserviamo per lo più tanta ignoranza e la circolazione di tantissime idee sbagliate. Perché?
Teniamo presente che non è strettamente necessario che tutto abbia una spiegazione, ma se ce l’ha è meglio.
1. Che cosa abbiamo nella testa?
I fondamenti
Sono pochi gli interrogativi che nel tempo ci hanno assillato più insistentemente di questo e che hanno ricevuto una maggiore attenzione. Su diversi piani e partendo da punti di vista molto diversi. Occorre anche dire che se il quesito è riferito in genere alla testa del nostro prossimo, a pochi sarà sfuggito che la domanda può essere riferita anche alla nostra, l’unico strumento che possediamo per studiare il mondo e la nostra stessa testa. Studiare significa osservare attentamente, cercare possibili costanti e regolarità, formulare un’idea su quanto osservato e rifletterci sopra, in un processo potenzialmente senza fine ma capace di portare a sempre nuovi approfondimenti. Nel tempo questo modo di procedere si è articolato e complicato, ma sempre di questo si tratta. Per le cose inanimate come per le cose animate. Come per la nostra testa e il suo cervello.
Raramente però si riflette su una cosa: il cervello è l’unico oggetto del creato che si può osservare dall’esterno, come tutto il resto, ma anche dall’interno, ovvero sia da fuori che da dentro. Con il nostro cervello si può anche osservare il nostro cervello. Ed è quello che facciamo in continuazione, quasi ventiquattro ore su ventiquattro. La ragione è ovvia. Noi siamo in connessione diretta con il nostro cervello e le sue pratiche. Il nostro cervello ce lo viviamo e ce lo sondiamo, osservandolo e frequentandolo. Consapevolmente e inconsapevolmente. Questa considerazione ci dovrebbe rendere fieri, ma nello stesso tempo ci responsabilizza e ci mette sotto pressione. Potrebbe sembrare che il doppio accesso faciliti il nostro compito di comprendere e di comprenderci, ma non è detto. Quello che è certo è che abbiamo a disposizione molte diverse strategie per comprendere il cervello e la sua mente.
Lo si può studiare introspettivamente come si fa da secoli, ma c’è sempre il dubbio che la nostra introspezione non sia totalmente onesta, ma un poco tendenziosa, o in sé o nella sua verbalizzazione. Lo si può studiare anche osservando il comportamento degli altri e cercando di impegnarci in una sorta di contorsionismo che ci permetta di passare dall’osservazione diretta della nostra mente al tentativo di immedesimarsi negli altri. Esiste poi tutta la varietà delle osservazioni fatte con l’ausilio di strumenti e condotte nel quadro di un atteggiamento più scientifico. Queste diverse vie d’accesso non possono essere nemmeno riassunte e il loro numero aumenta di anno in anno. Alcune sono di natura statica e descrittiva, altre di natura funzionale, elettrofisiologica, quasi tutte di natura strumentale ma a volte anche discorsiva. È inutile dire che ci si sente più soddisfatti ogniqualvolta i risultati ottenuti con le diverse procedure coincidono, in tutto o in parte.
Questo non significa però che i risultati ottenuti usando una sola metodica non possano essere molto interessanti o anche entusiasmanti. Questo è il caso, per esempio, delle ricerche di cui stiamo parlando in questo libro, come dire dell’osservazione sistematica dei nostri modi di valutare le situazioni, soprattutto quelle nuove. Lo studio in questione è stato avviato negli anni settanta da due psicologi cognitivi: Daniel Kahneman e Amos Tversky (in sostanza gli ideatori di tutto quello che stiamo dicendo qui). Con nostra grande sorpresa abbiamo scoperto negli ultimi decenni che la nostra facoltà di giudizio è piuttosto zoppicante e incredibilmente poco logica. È stato un po’ una doccia fredda venire a sapere che noi diamo valutazioni e prendiamo decisioni con una certa leggerezza. Che cosa abbiamo scoperto quindi?
Pare che nel giudicare e decidere commettiamo continuamente un incredibile numero di errori, o meglio di errori logici, che qualcuno ha battezzato “incongruenze” e “tunnel cognitivi”, mentre qualcun altro le ha definite “trappole mentali”, anche se più che di trappole si tratta in verità del perseguimento di false piste. Questo libro tratta di tali argomenti cercando di fare luce su come procede veramente il nostro cervello al di là di quello che a noi piacerebbe credere.
Come vedremo più estesamente in seguito, sembra che dentro la nostra testa ci siano due sistemi relativamente indipendenti per valutare, rappresentare, concludere e infine decidere. Un primo sistema, che possiamo chiamare Sistema 1, che funziona molto velocemente e ci costa poco o niente, ma la cui attendibilità è piuttosto scarsa – trattandosi di un modo di spicciare le questioni in maniera un po’ superficiale, avventata e soprattutto aprioristica – e un secondo sistema, il Sistema 2, decisamente più lento, che ci richiede molta più fatica intellettuale ma che, al meglio delle nostre evidenze, conduce a conclusioni e quindi a decisioni più razionali, supponendo di avere chiaro in testa il concetto di razionalità.
In ogni circostanza, se non ci pensiamo troppo, se siamo presi alla sprovvista oppure pressati dagli eventi, ci affidiamo istintivamente al Sistema 1 che fornisce molto velocemente il suo, approssimativo, verdetto. Se per uno scrupolo, sorto dentro di noi o suggerito da ciò che ci circonda, vogliamo tentare di trarre conclusioni più attendibili, dobbiamo mettere in moto e adoperare, magari per un determinato tempo, il Sistema 2. In sintesi, il Sistema 1 opera in velocità, mentr...