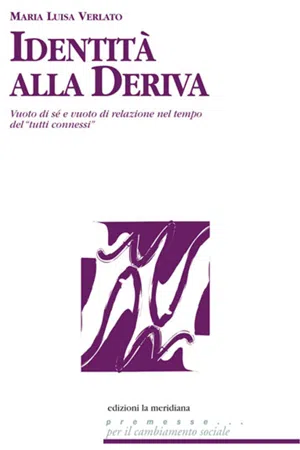![]()
PARTE II
Vuoto di sé, vuoto di
relazioni.
Come lavorare con
quello che non c’è?
![]()
5.
Le nuove ferite
Molti fattori influenzano l’esperienza di ogni essere umano. Il paradigma biopsicosociale sottolinea la necessità di tener conto delle variabili legate alla biologia del nostro organismo, ai fattori temperamentali e sociali, oltre a quelli psicologici.
Nella prima parte di questo lavoro abbiamo parlato di attaccamento, di legami affettivi, dei fattori protettivi che le relazioni sicure favoriscono e della sofferenza che nasce da quelle disfunzionali e insicure. Temi che la ricerca e tanta letteratura psicologica hanno esaminato e che restano tuttora validi per capire cosa avviene nelle relazioni genitori/figli e nello sviluppo della personalità.
Ci forniscono delle chiavi di lettura per avvicinare il dolore che nasce da relazioni ferite.
Oggi ci troviamo però a fronteggiare altre difficoltà, ferite culturali, sociali , che vanno a sommarsi alle precedenti. Che pur nelle differenze individuali legate alle specifiche storie di vita, alle coloriture con cui si è al mondo, aggravano il disagio di molte persone.
In terapia o nelle supervisioni sono sempre più numerosi i giovani imprigionati nel conformismo esasperato ai dettami del gruppo, alle leggi dei mercati e del consumismo, omologati, che non si espongono, sembrano non pensare con la propria testa. Oppure con forme di chiusura, di cinismo o apatia refrattarie a ogni tentativo di contatto. Con sempre maggiore frequenza incontriamo ragazzi impulsivi, sprezzanti del pericolo, confusi, nella cui storia non sempre troviamo quelle esperienze di discontinuità nelle relazioni, riconducibili all’attaccamento disorganizzato, che potrebbero in parte spiegare la genesi della loro vulnerabilità. Ragazzi col vuoto dentro. Ragazzi che si fanno male.
Come nei disturbi di personalità prevale in loro la tendenza a sentirsi sempre dalla parte della ragione, della verità e di vedere sempre all’esterno di sé la fonte dei propri problemi; negli altri che non li capiscono o nel destino. Altrettanto difficile è esplorare la loro parte di responsabilità nella vita, aiutarli a porsi domande, sollevare dubbi, senza che si sentano ingiustamente attaccati.
Anche quando chiedono aiuto è per avere risposte rapide e “a modo loro”. Nei consultori capita, ad esempio, che alcune ragazze, e quel che è peggio se sono minorenni qualche volta anche le loro madri, siano molto contrariate di dover rispettare le procedure previste per l’interruzione di gravidanza. Vorrebbero un lasciapassare rapido, una soluzione immediata, senza nessun colloquio. Non è solo la preoccupazione e l’ansia che sottende questo atteggiamento. Spesso ad accomunare le ragazze in questa situazione è l’atteggiamento svalutante verso gli operatori.
Come se dicessero “fatevi gli affari vostri, cosa volete da me?”.
Quando le ferite sono legate alle relazioni non viene mai del tutto meno la presenza dell’altro. Per quanto possa essere vicino o distante, affettuoso o freddo, iperprotettivo o trascurante, permissivo o autoritario, qualche volta purtroppo anche violento, amato o rifiutato l’altro c’è.
Nella società attuale invece spesso è come se non ci fosse. E allora è più facile perdersi.
5.1 L’ALTRO DOV’È?
L’opposizione. “Sei cattivo. Ti cancello”
Un bambino in prima elementare cancella il simbolo che rappresenta il giudizio dell’insegnante sul lavoro fatto in classe. Ci fa una croce sopra, bella grande, col tratto marcato. Sempre in prima un altro strappa la pagina in cui la maestra spiegava ai genitori come completare a casa una scheda che a scuola non aveva finito. Piccoli episodi che i genitori mi raccontano preoccupati per la tranquillità con cui i figli tolgono di mezzo ciò che li disturba o evitano quello che non hanno voglia di fare. Hanno sempre cercato il dialogo con loro e adesso sono sconfortati perché non accettano nessun richiamo o limite, non riconoscono alcuna autorevolezza a loro o agli insegnanti. Sempre in prima c’è una bambina tranquilla, socievole. Partecipa attivamente ai giochi ma quando è il momento di impegnarsi, di fare qualcosa sul quaderno non lo fa. L’insegnante la invita a iniziare il lavoro, ma la piccola dice “no”; e non lo fa. Non si arrabbia, non risponde male, ma continua a non farlo. Voglio giocare, è la sua spiegazione ed è inamovibile.
È più chiaro il messaggio di un altro bambino che sempre in prima dice deluso alla mamma: “Io le scienze non me le immaginavo così. Ma con le ampolle... il laboratorio...”, e ricorda un cartone che gli piaceva dove imparava a conoscere il corpo umano e si divertiva.
Alcuni bambini o ragazzi abbandonano lo sport che stanno praticando, o allenamenti a lungo desiderati come fare salti e acrobazie con lo skateboard, perché entrano in conflitto con l’allenatore, perché non tollerano le regole. È “cattivo”.
Possibile che già così piccoli non accettino il limite posto dall’adulto? Una richiesta? Il giudizio cancellato non esiste più. E in quei momenti anche il rapporto con l’insegnante, con il genitore, pare più sfuocato. Nel momento dell’opposizione, della sfida si sentiranno forti, ma chissà come si sentiranno smarriti quando la tensione non li sorregge più. E quando poi gli adulti risultano troppo deboli o inconsistenti ai loro occhi chi potrà aiutarli?
Qualche genitore o collega con figli piccoli si chiede cosa alimenti questa opposizione che interessa fasce di età sempre più basse. Si chiedono se sono stati abbastanza chiari a definire cosa si può fare e cosa no, senza troppi “forse”, “mi pare che”, “magari ti trovi meglio a...”. Siamo ambigui nel dare le regole o poco capaci di accettare la delusione, la rabbia, la protesta del bambino per cui ci si arrende subito? Di accettare il suo sguardo amareggiato... Oppure può essere che per aiutarli ad ascoltarsi, a sentire e scegliere, li abituiamo a troppe opzioni, a troppe possibilità, “ti piace di più questo, questo o questo, preferisci andare dalla nonna, al parco o invitare qui il tuo amico?” e poi, non ce la fanno a stare nelle situazioni in cui non c’è questa possibilità di scegliere? È come se accettare la realtà significasse essere deboli, perdere. Le semplici richieste del vivere quotidiano vengono decodificate come imposizioni cui opporsi, come competizione. Chissà se nel rispettare la loro libertà e soggettività sbagliamo qualcosa inducendoli a credere di avere più potere di quanto ne abbiano e un margine di scelta non proporzionato all’età. Forse servono delle tarature diverse e aver chiaro quando è possibile lasciar decidere a loro e quando no.
Mi chiedo se possa valere anche una riflessione di segno opposto. Di recente mi sono resa conto che spesso con i bambini molto piccoli si stanno facendo sempre più frequenti pratiche invasive quando sono ammalati e devono prendere uno sciroppo, o sono raffreddati e hanno il naso chiuso. Siringhette per far inghiottire le medicine. Lavaggi del naso per liberarlo. Ma come facevamo quando non si usavano e in un modo o nell’altro imparavamo a prendere i farmaci, a soffiare il naso? Per quanto i genitori siano attenti a non far troppo male e dispiaciuti per il pianto del bambino, trasmettono un indubbio messaggio di non fiducia verso di lui e il suo corpo. Anche se di solito sono comprensivi e affettuosi in quel momento obbligano il bambino a subire qualcosa che non vuole, che gli fa paura. Una pratica probabilmente efficace dal punto di vista sanitario, ma disfunzionale rispetto alla relazione. E soprattutto che crea ambivalenza. Chi mi vuol bene a volte mi fa male. Posso fidarmi? Un’ambivalenza con origini diverse da quelle dei genitori che creano relazioni dipendenti, ma potrebbe essere che parte dell’opposizione nasca anche da questo?
Cosa c’entri con me?
Terza media, ultimi giorni di scuola. L’insegnante di lettere e coordinatrice della classe suggerisce a una ragazza di aggiungere alla tesina preparata per l’esame su un argomento scelto dall’allieva, geografia, qualche riferimento alla letteratura; una poesia, il richiamo a un particolare autore, per far sì che sia interdisciplinare. La ragazzina dice: “No. Cosa c’entra lei con il mio esame! Mi piace così...”.
L’autodeterminazione è esasperata. Non si ha bisogno dell’altro. Come poter tornare a dire qualche volta “grazie, scusi, ne tengo conto...” dice una di questi insegnanti. Parole che esprimono attenzione e riconoscimento; anche gratitudine. Parole che scompaiono.
Seconda media: il ragazzo non segue quello che si fa in classe. Giocherella, manda sms, si distrae. Se l’insegnate si avvicina e chiede cosa sta succedendo, se può fare qualcosa per lui, la guarda indifferente e con il primo oggetto che trova a disposizione, la penna, una graffetta, continuando a fissarla come se fosse trasparente, impassibile si taglia. Succede sempre così e l’insegnante non sa cosa fare, è sempre più angosciata.
Non ti vedo, non esisti, non ti faccio entrare nel mio mondo sembra dire.
In questo caso il ragazzo si fa male davanti all’insegnante, mentre di solito non è così. L’autolesionismo è sempre più frequente ma riguarda parti del corpo non visibili agli altri. Non costituisce più un grido di aiuto ma qualcosa che ha a che fare solo con sé, con il sollievo momentaneo dalla tensione. Qualche ragazza è molto arrabbiata con i famigliari o con chi interferisce con queste pratiche qualora se ne accorga. “Non sono affari loro. Se capissero quanto sto male mi lascerebbero in pace”, dice.
L’anoressia stessa è spesso una scelta per il rifiuto, scelta di padronanza (al contrario delle dipendenze) che esprime indipendenza ed autonomia rispetto all’altro e l’antiamore è il prezzo per la differenziazione1.
Anche molti comportamenti pericolosi come attraversare i binari evitando un treno, o l’autostrada piuttosto che un incrocio pericoloso con il semaforo rosso, lanciarsi dai balconi (balconing) degli hotel rischiando di schiantarsi, o procurarsi lo svenimento premendo sulla carotide, non sembrano veicolare un messaggio, una richiesta di aiuto, né il bisogno di dimostrare a qualcuno il proprio coraggio o potere (questo di solito lo si fa aggredendo, facendo male, non facendosi male), ma l’illusione di avere il potere sulla propria vita, sul proprio destino, una sfida con se stessi. L’illusione di essere liberi di decidere.
Cosa significa questa esasperazione della propria individualità? Cosa sta succedendo? Ancora una volta l’altro dov’è? Come ritrovarlo?
Sappiamo che non ci può essere crescita e autorealizzazione senza gli altri esseri umani, senza quello che riceviamo da loro e dall’impegno verso di loro. Che la nostra interiorità e riflessività, la nostra mente hanno bisogno di un incontro io-tu per svilupparsi e per continuare a crescere.
Per affrontare le crisi della vita è necessario che qualcuno (e non qualcosa, come ben ha asserito Martin Buber) ci “riconosca”, ci accolga, ci “alleni”, ci permetta di apprendere, di costruire in noi la capacità di affrontare le frustrazioni inevitabili, ci permetta di diventare, come oggi affermano alcuni studiosi, “resilienti”2.
L’esaltazione della propria autodeterminazione ha bisogno di trovare una linea di confine, i limiti, nell’incontro, altrimenti sarà la vita che li porrà presentando dei conti salati qualora vengano violati. Come l’autoreferenzialità rischia di impoverire la persona. Al contrario lo scambio con gli altri, il confronto, permette di ampliare le proprie idee, di arricchirsi di punti di vista e valori diversi, di diventare più creativi, di aprirsi all’affettività e ai sentimenti.
Oltre ai colloqui individuali, necessari all’inizio e spesso per molto tempo per ripristinare il desiderio di contatto, di relazione, di apertura all’altro, anche il lavoro in gruppo (nel mio caso propongo il gruppo d’incontro rogersiano), costituisce un’ottima risorsa per ritrovare i fili che collegano ognuno agli altri. Spesso, e negli ultimi tempi in misura più frequente che in passato, sono proprio i giovani che a un certo punto del processo terapeutico cominciano a sentire il desiderio di scambiare e confrontare le loro esperienze con coetanei che si trovano nella stessa situazione. E fra le righe si sente che cominciano a desiderare rapporti diversi, con persone in carne e ossa, non virtuali, con cui condividere questo viaggio verso la propria e la loro individualità. Persone con cui nel tempo, terminato il percorso di gruppo, si possano scoprire interessi comuni, con cui fare amicizia.
5.2 APATIA, STANCHEZZA
Da dove arriva tutta questa apatia, stanchezza, devitalizzazione? L’inquietudine e il caos? Cosa ne è dell’autenticità, della verità? Delle relazioni?
Pur nella precarietà di questo momento storico e culturale, molti giovani riescono a credere nelle proprie potenzialità e investire energie nella costruzione del loro futuro. A studiare, lavorare, condividere interessi e passioni.
Per molti altri non è così. La disillusione, l’amarezza per le aspettative tradite, il rifiuto verso questo tipo di società può renderli cinici, sfiduciati, incapaci di trovare alternative diverse dal ripiegarsi in se stessi, dal cadere nella passività.
L’impressione è di vivere, di lavorare accanto a persone con sempre meno risorse. Fragili. Giovani annoiati, stanchi. Sempre più allievi non riescono ad alzarsi alla mattina per andare a scuola in orario. Le famiglie e gli insegnanti no...