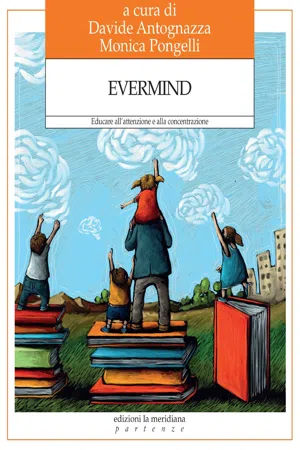![]()
APPENDICE
Tradizione e neuroscienze
I mistici hanno scandagliato per millenni la mente mediante ricerche soggettive e personali, mentre gli scienziati hanno cercato di comprenderla tramite ricerche obiettive e impersonali. Proprio in tale indagine sulla natura della mente, consiste la meditazione, ed è impossibile una pratica meditativa davvero efficace senza un’attenzione focalizzata.
Poiché la mente non addestrata oscilla, lo sviluppo di un’attenzione stabile ha rappresentato nel corso dei secoli un elemento chiave nelle tradizioni meditative, originando un vasto insieme di pratiche e tecniche31.
La pratica meditativa che è stata oggetto negli ultimi anni di numerosi studi scientifici in Occidente è la mindfulness, derivante dagli insegnamenti del principe Siddhattha Gotama, conosciuto come il Buddha (colui che si è risvegliato), vissuto in India nel V secolo a.C. Egli ha insegnato due forme principali di meditazione, samatha (si basa sulla concentrazione unitiva) e vipassana (che si dedica allo sviluppo della consapevolezza mentale), sulla base del quale in Occidente, in tempi recenti, si sono messi a punto dei programmi standardizzati di pratica meditativa (come ad esempio la MBSR Mindfulness Based Stress Reduction), che hanno reso possibile la ricerca sperimentale e clinica32. L’aspetto straordinario è che le teorie filosofiche e psicologiche elaborate dal Buddha, più di 2500 anni fa, corrispondono all’idea della mente, della coscienza di sé e del Sé elaborata negli ultimi decenni dalle neuroscienze cognitive33. La grande intuizione del Buddha fu che tutto quanto importa accade nella mente34.
Mindfulness, Sati in lingua pali, suggerisce i concetti di “consapevolezza, attenzione e ricordo”. Le parole “consapevolezza” e “attenzione” sono usate nello stesso modo in cui le utilizziamo comunemente, ovvero per indicare la conoscenza del fatto che sta succedendo una certa cosa e la concentrazione su di essa. La componente del “ricordo” indica il “ricordare” continuamente di essere consapevoli e attenti, e non riguarda invece – come comunemente utilizzata – la rievocazione di eventi passati. Ma non solo. Si tratta di una particolare qualità della concentrazione, ovvero quella con atteggiamento di accettazione, non giudicante, con calore, cordialità e compassione35. Quando meditiamo la coscienza osserva con un’attitudine non riflessiva e non giudicante.
On a fort justement traduit dans les autres langues mindfulness par “pleine présence” ou “pleine attention” ou “pratique de l’attention”. La méditation est un exercise de “pleine présence”36.
Nella mindfulness si pratica l’osservazione neutra e distaccata da tutto ciò che succede nel corpo e nella mente (sensazioni, pensieri, immagini, emozioni); ci si rende conto di come siamo abituati a vivere persi nei pensieri sul passato e sul futuro e impariamo a liberarci di queste abitudini prestando attenzione ai singoli momenti della vita così come si rivelano a noi e accettandoli37. Per praticare occorre un certo grado di concentrazione, senza la quale non potremmo osservare il funzionamento della mente e ci perderemmo nei nostri pensieri riguardo a ciò che sta accadendo al suo interno, invece di sperimentarlo direttamente.
La concentrazione è il fondamento della pratica mindfulness38. In ogni caso, anche quando stiamo ancora imparando a concentraci, coltiviamo già un po’ di consapevolezza mindfulness, ovvero dell’esperienza del momento accompagnata dalla disponibilità ad accettarla. Infatti, quando la mente si allontana dal respiro, possiamo notare dove se ne sia andata, prima di riportarla sul respiro. In altre parole, prendiamo atto di aver pensato, udito, fantasticato, ecc. Poiché la mindfulness implica un atteggiamento d’interesse o curiosità verso tutto ciò che sta avvenendo, quando pratichiamo la concentrazione possiamo incuriosirci del nostro respiro, affascinante e prezioso, notandone l’aspetto, la profondità, il ritmo ad ogni atto d’inspirazione ed espirazione. Possiamo anche iniziare ad accettare tutto ciò che si presenta durante la pratica di concentrazione, sotto forma di sensazioni, pensieri e stati d’animo che vengono a trovarci.
In generale, trovare un equilibrio ottimale tra la pratica di concentrazione, in cui si continua a tornare a un oggetto di attenzione prestabilito, e la pratica di consapevolezza, in cui si lascia che la mente si focalizzi su oggetti diversi nel momento in cui assumono predominanza nella coscienza, è un’arte. Di solito ci si lascia guidare dalla forza della concentrazione: quando è forte si può sperimentare di più la mindfulness; quando è debole e frammentaria conviene ritornare più spesso alla pratica di concentrazione39.
Il progetto Evermind è il nostro contributo per rendere accessibili a sempre più persone i numerosi benefici della pratica attentiva, confermati dalla neuroscienza. Non sono studi con una risposta facile, in quanto i metodi si differenziano notevolmente l’uno dall’altro (come ad esempio è diverso percorrere il corpo con attenzione o ripetere un mantra oppure osservare un’immagine di meditazione, evocare un atteggiamento amorevole, ecc.), come pure i loro effetti sull’attività e sulla struttura del cervello40.
Oggi un numero crescente di studi empirici confermano antiche intuizioni: un addestramento continuativo della mente altera il cervello, sia sotto il profilo strutturale sia sotto quello funzionale, e questa è la prova di concetto della base neuronale di quei tratti alterati che i testi di meditazione descrivono da millenni [...] Noi tutti possiamo muoverci lungo questo cammino e la neuroscienza contemplativa, la disciplina emergente che dà una base scientifica al discorso sui tratti alternati, ha ormai raggiunto la maturità41.
Una caratteristica importante della pratica riguarda l’attenzione, che talvolta viene focalizzata su di un oggetto, come ad esempio sul respiro che passa dalle narici, oppure viene mantenuta aperta, osservando ad esempio la mente. L’obiettivo di queste pratiche non è produrre un rilassamento ma modificare lentamente le abitudini negative.
La facoltà di focalizzare volontariamente l’attenzione che si sparpaglia di continuo costituisce la radice stessa del giudizio, del carattere e della volontà. Chi non la possiede non è una persona intera [...] un’educazione mirata al miglioramento di questa facoltà sarebbe l’educazione per eccellenza [...] ma è più facile definire questo ideale che dare delle indicazioni pratiche su come realizzarlo42.
Ma qual è l’educazione per eccellenza? Se qualsiasi tipo di meditazione comporta un riaddestramento dell’attenzione, può essere allora la meditazione l’educazione per eccellenza?43
La ricerca scientifica sull’attenzione è recente. Negli anni Settanta l’attenzione era ancora considerata come qualcosa di perlopiù automatico, guidato dagli stimoli, un processo inconscio “dal basso verso l’alto” e non c’era nessun concetto scientifico per il controllo volontario dell’attenzione. Negli anni Ottanta, con la fondazione della neuroscienza affettiva (studio dei circuiti emozionali e del modo in cui le emozioni influiscono sull’attenzione), e negli anni Novanta, con la nascita della neuroscienza contemplativa, i ricercatori sono giunti alla conoscenza del modo in cui i circuiti nella corteccia prefrontale gestiscono la nostra attenzione volontaria ma anche la nostra sofferenza emotiva.
L’attenzione è una funzione cognitiva complessa organizzata in numerose componenti. Essa permette di selezionare e di seguire gli eventi che ci interessano, inibendo quelli ritenuti non interessanti. L’attenzione può essere considerata come una parte del sistema di autocontrollo44.
A seconda di dove si sceglie di focalizzare l’attenzione, si attivano specifiche aree cerebrali responsabili delle relative modalità sensoriali ed emozioni. Vengono inoltre attivate alcune reti per la regolazione e il controllo dell’attenzione, che si occupano del mantenimento del punto focale scelto e del ripristino in caso di distrazione45.
William James parlava dell’attenzione come fosse una singola unità; oggi la scienza vede l’attenzione come a più tipi di abilità, che attivano differenti circuiti neuronali46:
•l’attenzione selettiva è la capacità di concentrarsi su un singolo elemento e di ignorare gli altri o ignorare le distrazioni;
•la vigilanza è il mantenere un livello di attenzione costante al passare del tempo, senza assuefarsi, come ad esempio quando si mantiene l’attenzione al respiro;
•l’allocazione dell’attenzione permette di notare piccoli o rapidi cambiamenti in ciò che sperimentiamo, grazie a una riduzione del battito di ciglia dell’attenzione (o blink);
•la concentrazione sull’obiettivo o controllo cognitivo permette di concentrarsi su uno specifico obiettivo o compito e di tenerlo a mente mentre resistiamo alle distrazioni. Ciò permette di rafforzare quelle capacità che sembrerebbe vengano danneggiate dal multitasking. Infatti, il cervello sembrerebbe non essere multitasking, ma si limiterebbe a passare ripidamente da un’attività all’altra. Ciò significa che i diversi compiti svolti dall’attenzione non procederebbero in parallelo, ma in maniera seriale, e richiederebbero quindi un rapido passaggio da una cosa all’altra. L’attenzione, passando da un compito all’altro, perderebbe di forza ad ogni passaggio e si impiegherebbero diversi minuti prima di poter tornare a una piena concentrazione. Sembrerebbe dunque che il multitasking porti ad un indebolimento dell’attenzione mentre una pratica di concentrazione, come il conteggio dei respiri, possa costituire un modo per migliorarla, almeno nel breve periodo;
•la meta-consapevolezza è l’essere in grado di tenere sotto controllo la qualità della nostra stessa consapevolezza, osservando attentamente i movimenti della nostra mente. Nella meta-consapevolezza, non conta ciò su cui focalizziamo la nostra attenzione, quanto piuttosto il fatto di rendersi conto della consapevolezza stessa. La meta-consapevolezza permette di seguire la nostra stessa attenzione, notando, ad esempio, quando la mente si è messa a vagare allontanandosi da qualcosa su cui volevano concentraci (ad esempio il respiro). Questa capacità di monitorare la mente senza farsi portar via dal flusso dei pensieri è una capacità mentale che ci facilita l’apprendimento, il rendersi conto di aver avuto un’intuizione creativa, vedere un progetto realizzato, ecc.
La meditazione, come mostrano le scoperte fatte sino ad oggi47, sembra rafforzare molte di queste abilità. In particolare l’attenzione volontaria sembrerebbe una facoltà fondamentale, poiché sarebbe in grado di mantenere alcuni contenuti mentali nella luce della coscienza48.
L’attenzione volontaria è una delle principali funzioni del sistema esecutivo. […] L’attenzione volontaria e il sistema esecutivo sono stati posti in relazione con il sistema metacognitivo, responsabile del monitoraggio e del controllo della cognizione, e con la coscienza di ordine superiore, ovvero con la capacità di essere allo stesso tempo coscienti degli stimoli ambientali, di quanto accade nella propria mente e di se stessi49.
Grazie alle ricerche condotte sino ad oggi, è stato evidenziato in modo esteso che le meditazioni con focalizzazione dell’attenzione sul respiro o...