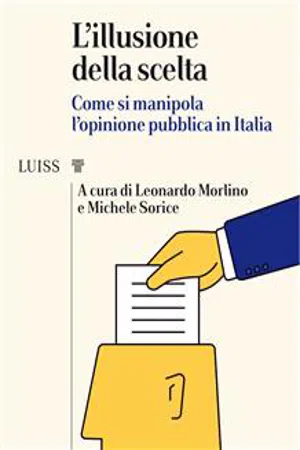![]()
parte quarta
![]()
capitolo 9
Il disordine informativo: premesse teoriche
di donatella selva
9.1 i disordini informativi
Uno degli elementi più problematici del rapporto tra media, politica e democrazia riguarda la circolazione delle fake news. L’interesse per questo fenomeno è cresciuto esponenzialmente negli ultimi anni perché è stato collegato alla manipolazione dell’opinione pubblica in occasione di referendum (Brexit) ed elezioni (Stati Uniti nel 2016; Francia nel 2017; Brasile, Italia e Regno Unito nel 2018). Durante la più recente esperienza della pandemia di Covid-19, l’Organizzazione Mondiale della Sanità ha lanciato un allarme riguardante il rischio che un’infodemia si potesse sovrapporre alla crisi sanitaria già esistente. L’OMS ha definito l’infodemia come “una sovrabbondanza di informazioni, alcune accurate e altre non, che rende difficile per le persone rintracciare le fonti degne di fiducia e le indicazioni corrette quando ne hanno bisogno” (WHO, 2020, p. 2, trad. nostra). Il particolare contesto della pandemia ha reso ancora più evidente il ruolo cruciale svolto dai mezzi di informazione e l’importanza di un attento monitoraggio dei processi che accompagnano la produzione, la ricerca e il consumo di news. Le fake news, e in generale tutti i disordini informativi, rappresentano una fonte di potenziale distorsione dei processi democratici, che si basano su principi di pluralismo e libertà della stampa; al contrario, è sempre più evidente come le logiche dei media vengano sfruttate per perseguire precise finalità politiche, e viceversa, come i media bias si inseriscano in un quadro di continua legittimazione dell’ideologia egemonica (Sorice, 2011, 2020). Con la crisi del Covid-19 anche la salute e la scienza sono state territorio di conquista da parte della propaganda politica: gruppi e movimenti, più o meno direttamente riconducibili a specifici attori politici, hanno utilizzato la disinformazione e la pseudoscienza per acquisire consenso. In Italia, ad esempio, i siti noti per essere fonti di disinformazione hanno cavalcato fin da subito l’interesse per il tema del Covid-19, addirittura al punto che nei mesi di gennaio e febbraio la copertura da parte della disinformazione superava quella da parte dell’informazione (figura 9.1).
Fig. 9.1. Incidenza giornaliera delle notizie riguardanti il Coronavirus sul totale disinformazione: confronto con l’informazione online (20 gennaio – 31 maggio 2020). Fonte: AGCom (2020)
Nonostante la grande popolarità dell’espressione “fake news”, tuttavia, sarebbe più corretto aprire lo sguardo a uno spettro di disordini informativi che può comprendere essenzialmente tre forme:
– Mis-informazione si ha quando le informazioni false sono create o diffuse senza un’intenzione malevola. Può essere legata a distorsioni fisiologiche del newsmaking oppure a veri e propri errori inconsapevoli, come l’accostamento di titoli, grafica, foto e video decontestualizzati rispetto al contenuto fattuale dell’informazione. Esempi di misinformation ci sono stati anche nel corso dell’attacco agli Champs Elysées del 20 aprile 2017, quando sui social media cominciarono a circolare voci infondate riguardanti l’uccisione di un secondo agente di polizia. Le persone non hanno condiviso queste voci in mala fede ma le hanno condivise privilegiando la tempestività (richiesta dal contesto di urgenza, pericolo e ansia) rispetto all’accuratezza;
– Dis-informazione identifica invece una specifica intenzione ad arrecare danno al pubblico o a oppositori politici attraverso la creazione e diffusione di informazioni false, fuorvianti o distorte. È questo un tipo di disordine che trova diversi punti di contatto con i partisan bias, cioè con le distorsioni informative tipiche dei media partigiani: la differenza, tuttavia, è che la partigianeria può essere dichiarata e trasparente, mentre la disinformazione non lo è mai (Gili, 2001);
– Mal-informazione riguarda lo svelamento di informazioni vere ma di tipo privato, che arrecano un danno pubblico (come l’hackeraggio e la pubblicazione di email private, nei casi di Hillary Clinton e Emmanuel Macron), oppure l’uso di hate speech contro gli oppositori politici, sia da parte dei leader sia dai loro sostenitori (Wardle e Derakhshan, 2017). Solitamente questo tipo di strategia viene anche identificata come mud machine (macchina del fango), utilizzata soprattutto in comunicazione politica e in particolare nel negative campaigning (Sorice, 2011).
Nella figura 9.2, vengono mostrate le tre forme dei disordini informativi sopraesposti.
Fig. 9.2. Disordini informativi. Fonte: adattamento da Wardle e Derakshan (2017)
Il termine disinformazione è una traduzione dal russo dezinformatsiya. La parola identificava una delle “misure attive” utilizzate dal KGB per destabilizzare gli Stati nemici o mantenere la stabilità nei Paesi d’influenza sovietica. Attraverso la dezinformatsiya, i sovietici disseminavano informazioni false o basate su comuni credenze e pregiudizi popolari per inasprire i conflitti sociali, sabotare le politiche interne e minare i rapporti internazionali (Shultz e Godson, 1984; Morozov, 2018). Nella letteratura angloamericana, il termine identifica ancora oggi le operazioni di creazione e diffusione di informazioni false ma plausibili, mescolate con altre vere, messe in atto strategicamente per perseguire finalità politiche. Tra le armi a disposizione di queste operazioni si rintracciano le fake news, ma anche tutti i tentativi di inquinare il dibattito pubblico (sui social media in particolare, ma non solo) attraverso trolling. I troll sono account di social media (utenti reali, fittizi o bot) che intervengono nelle discussioni di gruppi politici avversari per destabilizzare, insultare, creare un clima di polarizzazione e impedire la crescita di un dialogo costruttivo. Le tecniche si sono certamente evolute, ma rimane il fatto che le operazioni di disinformazione sfruttano la cultura popolare e le logiche commerciali dei media.
La manipolazione delle informazioni può anche assumere la forma di distorsioni fisiologiche, connaturate al processo stesso di newsmaking e che non perseguono una chiara volontà: in questo caso si parla di misinformation. Tra misinformation e disinformazione è possibile rintracciare un continuum di forme, evidenziate nella figura 9.1: i) parodia e satira possono essere informazioni fuorvianti, ma non nascono con l’intenzione di ingannare il pubblico; ii) false connessioni, quando non c’è coerenza tra il contenuto dell’informazione e il titolo o i materiali foto/video; iii) contenuto fuorviante, che usa in modo malevolo le informazioni a disposizione per inquadrare un tema o un soggetto, attraverso sottintesi e insinuazioni; iv) contesto falso, quando le informazioni veritiere sono inserite in un contesto non accurato o inventato; v) contenuto inventato simulando l’esistenza di fonti veritiere; vi) contenuto veritiero manipolato per ingannare; vii) contenuto falso al 100%, fabbricato per ingannare e danneggiare (Wardle e Derakhshan, 2017).
Dal punto di vista delle fonti, gli attori protagonisti dei disordini informativi sono diversi: troll, hate groups (che nell’ecosistema mediale americano appaiono come terminali ideologici dell’alt-right, ovvero la destra estrema popolata da suprematisti bianchi e nazionalisti), i gruppi misogini, teorici delle cospirazioni più disparate (da quelle antisioniste a quelle antiscientifiche), e infine media iperpartigiani e politici, che fanno la loro parte per incendiare e polarizzare il dibattito pubblico (Marwick e Lewis, 2017). Con l’ascesa al potere di leader vicini a tali gruppi, in particolare negli Stati Uniti, in Regno Unito e in Brasile, si è compiuto un passaggio concettuale dai disordini informativi all’ordine disinformativo o “era della disinformazione”. Secondo alcuni, infatti, la disinformazione rientra ormai nel repertorio standard della propaganda politica sia per la conquista sia per il mantenimento del consenso elettorale (Bennett e Livingston, 2018). La tesi dell’ordine disinformativo si poggia sugli studi che hanno enfatizzato il ruolo dei media come strumenti di mantenimento dello status quo (dell’ordine sociale, per l’appunto). In questo momento storico, la disinformazione ha come risultato quello di “cancellare la storia, risultando nella dissoluzione o nell’ostruzione del pensiero critico” dei cittadini (Cheyfitz, 2019, p. 1), e così minando le basi della democrazia. Le caratteristiche dell’ecosistema mediale, quali la velocità di aggiornamento e l’aumento della competizione dovuto al moltiplicarsi delle fonti, sembrano avere un effetto amplificatore (amplifier effect) per i disordini informativi. Dall’altro lato, sebbene i media svolgano, consapevolmente o meno, un ruolo determinante nell’ordine disinformativo, la genesi è da ricercare nelle nuove modalità di relazione tra istituzioni democratiche e cittadini (Cheyfitz, 2017; Bennett, Livingston, 2018), soprattutto in tempi di populismo di governo nei regimi democratici, così come nei regimi autoritari, dove la propaganda computazionale è utilizzata per sopprimere la libertà d’informazione (Bradshaw e Howard, 2019).
Per tutti questi motivi quando si parla di disinformazione e misinformation si ha una sovrapposizione di temi, attori e problemi che riguardano i diversi approcci regolativi esistenti rispetto al sistema dei media, della comunicazione politica, della sicurezza internazionale e della formazione della cultura civica dei cittadini. Essi sono parte di un ecosistema dei media in cui attori politici e istituzioni contribuiscono a definire il framing, i limiti e le modalità con cui affrontare i problemi che interessano la collettività (Colombo, 2020; Sorice, 2020). Nel caso dell’emergenza del Covid-19, ad esempio, le istituzioni hanno dovuto affrontare il problema di definire il modo con cui i cittadini sarebbero andati incontro non solo alla prospettiva di un rischio concreto per la loro salute, ma anche a forti limitazioni della libertà personale. Nel momento del lockdown, i mezzi di informazione e di comunicazione sono diventati l’unico canale per confrontare le proprie opinioni con l’ambiente circostante: questo ha significato un netto rafforzamento della comunicazione come cornice e come contesto sociale. I siti e gli attori protagonisti dei disordini informativi hanno cavalcato fin da subito l’interesse per il Coronavirus. D’altra parte, la comunicazione delle istituzioni è stata la protagonista nel modellare tale contesto, diffondendo alcune informazioni e non altre, ma anche scegliendo il modo in cui comunicarle, ad esempio evitando di scatenare il panico, dedicando risorse al debunking delle fake news, incentivando l’uso di dati e numeri provenienti da fonti ufficiali. Infine, diversi leader politici provenienti da diverse parti del mondo sono stati accusati di aver sottovalutato gli effetti del Coronavirus, diffondendo messaggi di calma, incentivando l’applicazione del “buon senso” da parte dei cittadini e adottando un atteggiamento tollerante (quando non apertamente incoraggiante) nei confronti di quanti si dichiaravano contrari all’uso della mascherina di protezione.
I disordini informativi possono quindi assumere diverse forme, ma tutte hanno in comune il fatto che inquinano il rapporto tra cittadini, media, politica e istituzioni. Proprio partendo dal concetto di “inquinamento” associato all’ecosistema mediale contemporaneo, si può adottare una prospettiva secondo cui “se le conseguenze dell’evoluzione dell’ecosistema vanno in una direzione minacciosa o almeno pericolosa per la vita dell’uomo, la preoccupazione ecologica si concretizza in strategie e comportamenti che possano invertire la tendenza, e salvare la vita della nostra specie” (Colombo, 2020, p. 11). Le politiche pubbliche possono giocare un ruolo chiave. In particolare, possono intervenire su due aspetti: il contesto (e quindi, più o meno direttamente, gli attori, come le fonti d’informazione, le piattaforme e i cittadini) e i contenuti dei disordini informativi.
9.2 la manipolazione del contesto: bias cognitivi, nudging e disordini informativi
Anche se lo studio dei disordini informativi riguarda prioritariamente l’analisi dei media e delle dinamiche di informazione, la manipolazione emerge come argomento di ricerca in epoca premediale. L’esempio più lampante è offerto dallo studio della retorica, che discende dagli antichi greci e che è ancora oggi impegnata in una costante revisione del repertorio comunicativo legato ai tentativi di persuasione e influenza (nella comunicazione interpersonale e mediale). La retorica si poggia sulle regole di funzionamento del nostro cervello, e in particolare sulla logica deduttiva, per indurre il destinatario a trarre conclusioni non esplicitate dal mittente e a comportarsi di conseguenza: alcuni esempi di ciò sono rappresentati dal giocare sugli equivoci utilizzando un linguaggio ambiguo (la frase “faremo tutto ciò che è necessario per assicurare i responsabili alla giustizia” non chiarisce quali provvedimenti verranno presi né i destinatari di tali provvedimenti), giustificare le proprie azioni ricorrendo a una presunta volontà popolare (“Gli italiani sono stufi”) o ad argomenti pseudoscientifici (“I medici concordano nel dire che…”), oppure introdurre lo spettro di una catena di eventi a seguito di un’azione (“Se interveniamo in questo ...