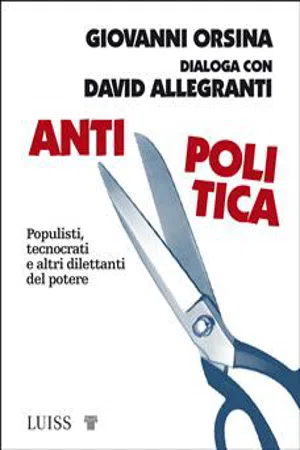![]()
Il Movimento 5 stelle
Non si può parlare di antipolitica senza approfondire il caso dei Cinque stelle. Vorrei però partire dalla conclusione dell’avventura grillina. Il M5s che nel 2018 va al governo con la Lega, partito peraltro con il quale diceva di non volersi mai alleare, e poi non combina più niente — benché il taglio del numero dei parlamentari sia il trionfo dei Cinque stelle, non poca cosa — è la dimostrazione che l’antipolitica quando entra nel Palazzo può solo fallire? È destino di questi rivoluzionari entrare nel Palazzo da incendiari e morire da pompieri? E dipende dalla qualità del gruppo dirigente grillino o dalla forma dell’antipolitica, che quando arriva nelle istituzioni non può restare se stessa?
“La dimensione politica è incomprimibile, caro David. Puoi sognare di eliminarla, la politica, o almeno di eliminarne alcuni aspetti, poi però ti ricade sempre addosso. Indebolita, magari, o fatta più di rappresentazioni che di realtà, ma pur sempre ingombrante. Perché non sono eliminabili del tutto né il potere, né il conflitto su di esso, né le abilità e competenze peculiari – per non dire degli aspetti caratteriali – che servono a gestire l’uno e l’altro. Nel caso del M5s la questione ha poi una dimensione istituzionale: il sogno di eliminare l’intermediazione politica grazie a Internet. Sogno che però non si è realizzato. Infine, il Movimento ha sperato di poter prescindere dalle ambizioni umane. Ma il potere piace, il conflitto per il potere e il desiderio di conservarlo sono ineliminabili. Le divisioni, il teatrino, la ‘cadrega’, le nomine, le risse: la politica è questa. Il politico vuole affermare la propria personalità, vuole comandare, la politica è il luogo nel quale le personalità forti e ambiziose cercano di realizzare sé stesse. Un po’ come lo scorpione con la rana, nel noto apologo. Pensa a uno come Renzi. Questo fa e probabilmente farà sempre parte della natura umana”.
Ma è tutta colpa dell’antipolitica o c’è una responsabilità della politica?
“L’antipolitica è generata anche dai difetti strutturali, ineliminabili della politica. Rino Formica diceva, con un’espressione diventata celebre, che la politica è ‘sangue e merda’. In La Politica moderna tra scetticismo e fede, Michael Oakeshott scrive:
“In tutti i tempi la politica è uno spettacolo sgradevole. L’incomprensibilità, il fango, gli eccessi, i compromessi, l’indelebile comparsa della disonestà, la finta pietà, il moralismo e l’immoralità, la corruzione, gli intrichi, la negligenza, l’ingerenza negli affari altrui, la vanità, l’inganno di se stessi e infine la futilità, ‘come un vecchio cavallo in un recinto’, offendono la gran parte dei nostri sentimenti razionali e tutti quelli artistici’”.
Spesso la politica tira fuori il peggio, e solo più raramente il meglio, che c’è negli uomini: la volontà di potere, il desiderio di sopraffare gli altri, la vanità, il narcisismo. In un contesto come quello attuale, fortemente destrutturato e privo di idealità forti, questi aspetti deteriori possono godere d’un campo d’azione particolarmente ampio. Una politica robustamente istituzionalizzata riesce a mettere a frutto i vizi umani e a impedire che vadano fuori controllo. Ma un caos come la politica italiana attuale lascia ai vizi libero corso. Eppure, anche questo fa parte della natura politica. Con una punta di provocazione, ma nemmeno troppa, potremmo dire che la politica è un male necessario”.
Ad alimentare l’antipolitica non ha partecipato anche la stessa classe dirigente, nel tentativo di fare ammenda nei confronti della popolazione? Il caso di Torino è emblematico, lo cito spesso. Chiara Appendino del M5s è diventata sindaco nel 2016 grazie anche al voto degli industriali.
“Stiamo assistendo a un epic fail della classe dirigente a tutti i livelli, incluso quello politico. Lo diceva Ortega y Gasset ne La ribellione delle masse, all’inizio degli anni Trenta del secolo scorso, che quella rivolta era l’altra faccia della medaglia del fallimento delle élite. E poi l’ha scritto Christopher Lasch più di sessant’anni dopo in un altro libro straordinario che s’intitola, appunto, La ribellione delle élite. Ma del resto l’aveva già notato ben prima Alexis de Tocqueville. Alla base delle meditazioni sul rapporto fra quantità e qualità che segnano il liberalismo ottocentesco c’è l’idea che possiamo anche costruire un sistema basato sulla quantità e sull’uguaglianza, sull’uno vale uno – che è una regola democratica, non grillina –, poi però qualsiasi ordine sociale avrà comunque bisogno di una classe dirigente, di organizzazione e stratificazione, di gerarchie. Di valorizzare la qualità, insomma. Non si può immaginare che in una società uno valga davvero uno, anche se la democrazia è questo che promette. Questa contraddizione i liberali la vedevano con grande chiarezza. A un certo punto, di fronte a un’antinomia così profonda e difficile da risolvere, le classi dirigenti hanno cinicamente, anche se forse inconsapevolmente o automaticamente, cercato di nascondere il proprio essere classi dirigenti, hanno finto di mischiarsi con la ‘gente’. E poi, dietro le quinte, si sono costruite dei meccanismi che consentissero loro di continuare comunque a perpetuare se stesse. La ribellione populista avviene nel momento in cui la ‘gente’ si rende conto di quest’operazione, ossia di essere stata imbrogliata. Voi dite che è un mondo per tutti, voi dite che siamo tutti uguali – questa la protesta –, e non possiamo neanche più sfogarci perché non c’è nemmeno più una Versailles da assaltare. Però ci avete truffato. Come ci ha insegnato Tocqueville, il privilegio diventa intollerabile nel momento in cui non è più percepito come legittimo, nel momento in cui lo si nega o cerca di cambiare”.
Non è quello che è successo negli Stati Uniti con la vittoria di Donald Trump?
“È probabile. È probabile che i forgotten ones di Trump protestino anche contro un potere del quale sentono il peso, e che però non si capisce più bene dove sia né quale funzione abbia. Le classi dirigenti hanno negato che esistessero le classi dirigenti. Hanno rumorosamente sposato, a partire dagli anni Sessanta, l’idea che siamo tutti uguali. Hanno finto di democratizzarsi, hanno delegittimato l’idea stessa di classe dirigente, ma nel frattempo il potere, le gerarchie e i privilegi non sono venuti meno. Risultato: ora la ‘gente’ è furibonda”.
A proposito di rabbia politica, l’elettorato grillino sarà furibondo anche perché il M5s, dopo aver sostenuto Giuseppe Conte, si è schierato con Mario Draghi. Peraltro, la Piattaforma Rousseau doveva essere la matrice della ristrutturazione integrale della democrazia, ma con 70 mila persone che hanno partecipato alla votazione sull’appoggio, o meno, del Movimento alla figura di Draghi che cosa vuoi ristrutturare? Niente. E la maggioranza degli iscritti, proprio su Rousseau, ha detto sì all’ex presidente della Banca centrale europea (Bce). Un esito che rappresenta la quintessenza di tutto ciò che loro non sono stati, non possono essere e che odiano. Draghi rappresenta tutto ciò che hanno sempre combattuto. Risultato: è finito il M5s per come l’abbiamo conosciuto?
“Io penso che la fine del M5s così come lo abbiamo conosciuto sia cominciata nel momento in cui è andato al potere. Non è un caso che nel primo anno di governo il suo consenso si sia dimezzato. E se ci fossero state alternative proponibili si sarebbe anche più che dimezzato. C’è una comprensibile difficoltà degli elettori Cinque stelle ad andare altrove, perché per loro non c’è un altrove dove andare. Mi pare che il M5s sia il risultato di un incrocio fra almeno tre elementi: la ribellione antimoderna, la democrazia diretta e il ‘vaffa’. Nel primo elemento si condensa il patrimonio programmatico originario del M5s, che in larga misura era un programma di sinistra alternativa, movimentista, contraddistinto dall’etichetta ‘piccolo è bello’. Contro il gigantismo, contro le super mega tecno-burocrazie, contro la finanza globale, contro i meccanismi impersonali della modernità che schiacciano l’individuo, bisogna tornare alla piccola comunità, al chilometro zero, al controllo sulle filiere, alla sostenibilità etica e ambientale, alla decrescita felice. È una vecchia storia, non comincia di certo oggi. È la storia della ribellione dell’individuo e della piccola comunità contro il gigantismo moderno e il senso di spersonalizzazione e perdita di controllo ch’esso porta con sé. È anche una ribellione che ha una qualche ragione. E ‘piccolo è bello’ è un sogno che esiste pure dentro certe varianti del liberalismo, convinte che la libertà individuale possa essere garantita soltanto se le strutture sociali restano di dimensioni gestibili. Più la scala dei fenomeni cresce, più vengono costruite delle mega-macchine burocratiche, più è difficile per l’individuo salvaguardare i propri spazi di libertà. I Cinque stelle, naturalmente, non declinano la questione in senso tanto liberale quanto comunitario”.
Comunitari e attivi sul “Sacro Blog”, dove gli spazi virtuali vengono condivisi dagli attivisti.
“Questo è il secondo elemento di cui dicevo sopra: la democrazia diretta resa possibile da Internet. Con una bella contraddizione fra il primo elemento e il secondo, peraltro: il web chi ce l’ha dato? È in buona sostanza un prodotto delle mega-macchine organizzative della modernità. Ricostruire il tessuto comunitario e dare vita a meccanismi di democrazia diretta utilizzando uno strumento messoti a disposizione dal tuo ‘nemico’ era ed è foriero di contraddizioni e difficoltà. Ma il ragionamento in realtà, caro David, non era del tutto sprovvisto di ragioni. Scombinato quanto si vuole, aveva una sua dignità. Ma era utopistico”.
Utopia e “vaffanculo”. Un mix letale. Anche per lo stesso M5s?
“Il ‘vaffa’ è il terzo elemento, quello che li ha portati al 32,5 per cento dei voti. Perché gli altri due elementi che ho appena citato potevano portarli al 3,2 per cento dei voti, a essere molto generosi, ma certo non al 32. L’elemento della protesta, della rottura – che se vogliamo aveva anch’esso delle ragioni –, è legato al cosmico fallimento storico, in Italia, di tutte le altre opzioni. Lasciamo stare se i fallimenti siano stati reali o no: i fallimenti percepiti sono una realtà politica di per sé. Se ci pensi, abbiamo avuto i partiti e i politici di professione e ne abbiamo dichiarato il fallimento già nel biennio 1992-’93. Abbiamo avuto il grande imprenditore, Silvio Berlusconi, e grosso modo ne abbiamo dichiarato il fallimento nel 2005-’06, al termine della sua prima legislatura di governo. Poi abbiamo avuto i magistrati, tra cui Antonio Di Pietro. Anche il partito di Di Pietro è finito male: polemiche, scissioni, malcostume, trasformismo. Tutto quello ch’era nato per contrastare. Infine, abbiamo avuto gli euroburocrati alla Mario Monti. Abbiamo dichiarato falliti anche questi. Un Paese che ha bruciato tutte queste opzioni non può che essere disperato”.
E quindi cosa rimane? La soluzione antipolitica?
“Rimane la casalinga. Se tutti i grandi esperti e i grandi politici non hanno capito niente, allora io elettore mi affiderò alle persone come me. Almeno le comprendo, mi ci posso rispecchiare. In più, aggiungici la crisi economica e del debito sovrano. Aggiungici l’austerity. Aggiungici che tutto questo fallimento non avviene in astratto, ma che in tanti lo sentono sulla propria pelle. L’angoscia, il senso di un Paese in fallimento. La ‘massa’ del debito pubblico che mi insegue. Lo spread che segna che un italiano vale un quinto di un tedesco. Mentre parliamo, mi vengono in mente le riflessioni di Elias Canetti in Massa e Potere sull’inflazione, sulla moneta come simbolo del valore di un popolo e sulla sua svalutazione come emblema della crisi di quel popolo. Ecco, alla fine siamo anche questo: emozioni e senso di sé”.
Che senso ha di sé un italiano nel 2012?
“Ha il senso di appartenere a un Paese sull’orlo della bancarotta. Disperato. Bene o male lo abbiamo provato tutti. Che cosa dicevano gli elettori grillini a quei tempi? ‘Tanto quelli del Movimento non potranno essere peggio di chi ci ha governato finora’. Dentro il M5s c’erano questi elementi. Che alla prova del governo, però, hanno fallito tutti. Il partito che nasceva dal fallimento altrui è diventato esso stesso un fallimento. Il ‘piccolo è bello’ è fallito perché nel mondo globalizzato, iper-complicato e iper-connesso, certe operazioni di ‘ritirata’ hanno dei costi insostenibili. Intendiamoci, molte perplessità del grillismo sono entro certi limiti comprensibili: il gigantismo burocratico, la pressione omogeneizzante dei processi d’integrazione globale, l’ingovernabilità dei fenomeni sono oggettivamente preoccupanti. Una volta che ci siamo preoccupati, però, che soluzione diamo? Abbandoniamo tutto? Ci isoliamo? L’Italia è un Paese che esporta, come si fa a isolarlo? La nostra economia è un pezzo dell’economia mondiale. Al dunque, se torniamo all’autarchia, come campiamo? Con la decrescita felice? Temo che la decrescita sia sempre infelice”.
E alla fine arriva Draghi.
“Già. Il sostegno dei Cinque stelle a Draghi, se vogliamo nobilitarlo, è una sorta di ammissione implicita dell’impossibilità di ‘evadere’ dal mondo globalizzato e della necessità, allora, di farsi guidare e proteggere da chi quel mondo lo conosce meglio di ogni altro e lo sa affrontare e gestire. Come, se mi passi una similitudine un po’ brutale, un adolescente problematico, un hikikomori, che cerca di sfuggire all’ambiente circostante isolandosi nella sua stanza ma si accorge a un certo punto che quella è una vita orribile, insostenibile. E cambia radicalmente strategia: invece di un isolamento impossibile, cerca il miglior psicanalista sul mercato che lo aiuti a reinserirsi. Il massimo della fuga si converte nel massimo della riconciliazione con la realtà. Il prezzo da pagare tuttavia è l’abbandono definitivo di un altro dei tre elementi portanti del grillismo: quando sei al governo con il Partito democratico e Forza Italia, sotto la guida dell’ex presidente della Bce, il ‘vaffa’ proprio non puoi più dirlo. Una volta, parlando con un deputato grillino in una trasmissione televisiva, gli ho fatto notare l’incoerenza del M5s. Gli ho detto che alla fine avranno governato con tutti. Lui mi ha risposto che tutti gli altri partiti sono incoerenti ‘ma voi ve la prendete soltanto con noi’. Loro però, è stata la mia risposta, dovevano essere un’altra cosa. Meglio: la loro ragion d’essere era che fossero un’altra cosa. Se sono come gli altri, allora non hanno più una ragion d’essere”.
Il M5s d’altronde ha basato fin dall’inizio la propria superiorità politica sulla diversità antropologica.
“Se gli altri sono dei cialtroni e chiediamo loro perché sono dei cialtroni, ci rispondono che la politica è fatta così. Può essere una risposta furbesca, ma almeno è onesta. Se tu entri in politica per cacciare i cialtroni e poi diventi come loro, il tuo ‘vaffa’ non solo non c’è più, ma ti si ritorce contro. Tra l’altro ormai hanno governato con tutti i partiti che hanno mandato a quel paese”.
E la democrazia diretta? Anche quella non regge più.
“Proviamo ad andare un po’ più a fondo. L’impossibilità della democrazia diretta a mio avviso non è tecnica, ma antropologica. In un mondo difficile, complicato e pericoloso, per prendere decisioni di governo occorre avere delle competenze e delle specializzazioni. Non bastano, certo, perché i competenti possono pure essere degli inetti e commettere errori madornali. Diciamo che è una condizione non sufficiente ma certamente necessaria. Gli esseri umani non hanno il tempo, la forza, l’intelligenza, le capacità cognitive per decidere a ragion veduta in un mondo così difficile e così complesso. È possibile immaginare la democrazia diretta quando si tratta di scegliere, in un quartiere, dove fa...