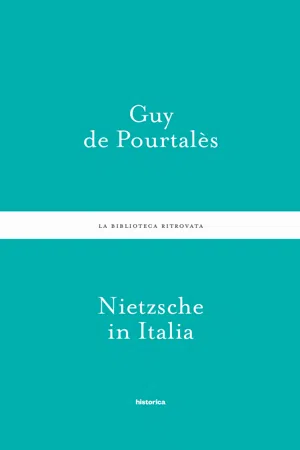![]()
VI.
La signorina Lou a Nasso
Appena arrivato a Roma Nietzsche si recò presso la nostra “idealista” di Sorrento. Come fanno molte zitelle che per tutta la loro vita hanno pianto un fidanzato, anche Malwida von Meysenbug si compiaceva combinare matrimoni. E se aveva tanto insistito perché Nietzsche venisse a Roma, era perché le era nata l’idea di unire il suo selvaggio poeta con una giovane russa di cui si era fatta protettrice. E subito gliene tessé l’elogio. Era una certa signorina Lou Salomé. Ebrea di origine finlandese (in realtà russa, nacque infatti a San Pietroburgo, figlia di un generale tedesco al servizio dello zar, nel 1861; anche le sue ascendenze ebraiche non sono certe: Daniel Halévy, uno dei maggiori biografi di Nietzsche, adombra molti dubbi al riguardo, N.d.C.) , di appena venti anni, di una dolce bellezza, d’intelligenza vivace e ferma, di buona condizione economica. Coltissima e completamente indipendente, quella ragazza educata liberamente cercava di occupare il suo tempo e certo non domanderebbe di meglio che unire il suo genio nascente al destino del professore errante, la cui rinomanza cominciava già a spuntare un po’ dovunque. La signorina Lou era stata iniziata alle opere di Nietzsche dalla vecchia Meysenbug e dal suo amico Paul Rée, egli pure di passaggio a Roma. Ella non tardò a manifestare il suo entusiasmo. Non si nascose neppure a Nietzsche che quel suo tenero discepolo aveva già avuto un maestro e un amico a Helsingfors nella persona di un professore eminente ma ammogliato e attaccato ai suoi doveri. Coraggiosamente ella si era esiliata ed ora si trovava a Roma alla ricerca di un affetto che, senza esigere niente dal suo cuore addolorato, sapesse almeno occupare i suoi pensieri. Queste caratteristiche non dispiacquero affatto a Nietzsche. Acconsentì volentieri a vederla. E un bel giorno di fine aprile, l’Anticristo e la giovane ebrea furono presentati l’uno all’altra nella Basilica di San Pietro.
Lou rimase incantata. Nietzsche, fedele alle sue teorie, conservava la maschera della cortesia più convenzionale; ma ella si accorse subito che la portava male. Il suo sguardo lo tradiva, quello sguardo miope che non rifletteva mai le cangianti espressioni del mondo esteriore, ma rivelava una specie di luminosa fissità gli orizzonti interiori. Quelle luci colpirono Lou. Quanto a Nietzsche, egli ne fu subito sedotto. Ma si mise anche subito in guardia. La giudicò poco bella, forse senza personalità, come scrisse a sua sorella; ma nella stessa lettera si ricredé, lasciando intendere che era già stato conquistato. “Una ragazza che fino dalla sua più tenera infanzia non ha cercato che la conoscenza e che ha consentito a tutti i sacrifici. Ciò mi ha profondamente turbato”. Alla signorina von Meysenbug egli disse: “Ecco un’anima che, con un soffio, si è creata un piccolo corpo”.
Nietzsche non poteva credere alla felicità nell’amore. Ma indubbiamente egli amò. Con quella meravigliosa ingiustizia dei gusti che si fanno della perfezione un’idea assoluta. Con quel superbo egoismo degli amanti ch’egli stesso ha cantato come il feroce e necessario ideale del possesso. Essi ebbero insieme delle lunghe conversazioni da cui uscivano seriamente turbati: Lou dalla violenza del pensiero di Nietzsche, dalle sue parole appena mormorate, dalle sue mani troppo intelligenti che lo tradivano, ed anche da quelle sue orecchie “fatte per intendere ciò che non è mai stato detto”; Nietzsche commosso dalla presenza di un essere femminile di cui anni ed anni di solitudine volontaria lo avevano per tanto tempo privato.
Ben presto partirono in quattro per il lago di Orta, la signora Salomé, sua figlia (Lou sempre accompagnata dalla madre nel suo girovagare per l’Europa, N.d.C.) e i due filosofi. Nietzsche diceva al suo amico: “È una donna ammirevole, sposatela…”. E l’altro rispondeva: “Sposatela voi; è la compagna che vi occorre”. Si divertivano come bambini a trascinare Lou nella carriola di un giardiniere, mentre ella decideva di “sacrificare la sua vita alla verità”. Nietzsche studiava quella giovane ebrea di sì precoce intelligenza e di una già solida cultura.
Si separarono di nuovo per ritrovarsi più tardi, a metà maggio, a Lucerna. Certamente fu Nietzsche che scelse il luogo di questo incontro. Al sentimento nuovo che lo riempiva di una riconoscente mansuetudine, egli ci teneva a fare omaggio del suo passato. Quale passato? L’amicizia con Wagner? L’amore inespresso – inesprimibile – per Cosima? Qualunque cosa fosse, egli desiderava condurre Lou Salomé a Tribschen, in quell’isola felice, in quella Nasso dove Wagner, Cosima-Arianna e lui avevano altra volta vissuto ore tanto piene di fede e d’entusiasmo.
Ma prima egli incaricò Rée di consegnare alla giovane una lettera che conteneva la sua domanda di matrimonio. “Poiché, - chiese timidamente al suo amico, – non si può certo trattare di unione libera…”. Ingenuità di dotto e di artista che non vive affatto nelle contingenze. Del resto la signorina Salomé aveva troppo senso pratico e non abbastanza amore per intravedere un sol momento una tale ipotesi. Tuttavia l’improvvisa decisione di Nietzsche la sorprese. Ella non vi credé o volle non crederci. Avrebbe preferito fidanzarsi con Rée? Forse, ed è stato detto. In ogni caso è certo che nonostante una viva simpatia spirituale e una non dissimulata ammirazione, ella non fu mai innamorata di Nietzsche. Il genio – ed anche il talento – spesso pensano a trovare la via del cuore, poiché gli istinti si sollevano contro il sottile nemico delle loro esigenze. Si persona all’intelligenza se la si crede incapace di fallire? La signorina Lou fu perspicace come sa esserlo ogni donna quando si tratta delle profonde verità della carne. Ella vide il pericolo che costituiva un tal uomo e ideò una menzogna pratica. Convenne con Rée che, non essendosi trovata l’occasione opportuna, la lettera non era stata consegnata. Alcuni giorni furono così guadagnati; poi andarono insieme a Tribschen.
Nietzsche vi era già stato la prima volta il 15 maggio del 1869, un sabato prima della Pentecoste. Giovane professore dell’Università di Basilea aveva scritto a Wagner l’entusiasmo che gli ispirava la sua musica; si sentiva commosso dall’uomo come da un essere soprannaturale, da un divino “ossesso”. Ed ecco che il Maestro lo aveva subito chiamato; e Nietzsche, immobile davanti al cancello della villa dove l’eterno esiliato aveva cercato rifugio, ascoltava i battiti del suo cuore. Ascoltava anche un doloroso accordo modulato su di un pianoforte e ripreso ripetutamente, che sfuggiva da una finestra aperta sul giardino primaverile… Un domestico venne ad informarlo che il suo padrone avrebbe lavorato fino alle due e non avrebbe potuto ricevere il professore dopo tale ora. Nella impossibilità di attendere Nietzsche se ne andò. Tutto ciò ch’egli ritenne di quel primo tentativo fu dunque quell’unico accordo, incessantemente ripetuto e che andava a morire tra i fiori come un lontano richiamo, una affannosa domanda. Più tardi vi riconobbe il motivo del terzo atto del Sigfrido, quando Brunilde grida: “Mi ha ferito, quegli che mi svegliò…” – e vi scorse un sorprendente presagio. Ritornò poi a Tribschen il lunedì di Pentecoste e quella volta fu ricevuto dal compositore e da Cosima von Bülow che viveva con lui. Cominciò allora quell’appassionante amicizia, l’epoca felice e breve in cui il suo cuore senza critica accettò l’intrusione del pensiero più violento del suo tempo”.
“Mia Italia”, soleva dire Nietzsche parlando di quella soleggiata penisola sul lago dei Quattro Cantoni al limite della quale si elevava il rifugio che il re di Baviera aveva affittato per il suo illustre amico. Nietzsche vi si recava da Basilea quasi tutti i sabati, vi passava la notte e la domenica e contava i giorni che lo separavano dalle prossime vacanze. E come se questa nuova amicizia dovesse segnare subito avvenimenti straordinari, il primo soggiorno di Nietzsche fu marcato dalla nascita del figlio di Wagner e di Cosima; la fine di quella stessa stagione, qualche settimana più tardi, coincise con la nascita dell’altro Sigfrido, il figlio spirituale del Maestro.
Wagner lavorava senza posa alle sue opere musicali e si accaniva per dar loro un’espressione filosofica. Vicino a lui Nietzsche non lavorava meno, sollevato dall’entusiasmo dionisiaco di quella musica e con la certezza di essere il primo a scrutare le più riposte intenzioni del poeta, a coglierne forse il senso meglio dello spirito. E tuttavia come e quanto sapeva essere naturale e semplice quella donna così estranea!
Cosima amava ridere, si divertiva con niente, giocava con i suoi figli, proponeva Nietzsche per gli acquisti dell’albero di Natale, – libri, bambole, marionette, – chiedeva angeli più rosei e un diavolo più satanico. Come compenso il filosofo avrebbe avuto in regalo una bella edizione degli Essais di Montaigne. Anche Wagner, del resto, incaricava il suo giovane amico di missioni confidenziali: si rimise a lui per sorvegliare la correzione delle bozze e la stampa dell’autobiografia doveva uscire a Basilea in sole dodici copie, per gli intimi soltanto. (E con quale discrezione Nietzsche ha sempre taciuto ciò che aveva saputo da Wagner stesso sulle sue origini e la sua nascita). Era allora il tempo della fiducia intera, del mutuo incantamento. Cosima gli scriveva un giorno: “…Sentendo benissimo che le sofferenze passate rimangono impresse nell’anima in modo indelebile, io dico che la più grande felicità sulla terra è una visione e che questa visione ci è toccata in retaggio”.
Sì, quel primo periodo di Tribschen è restato nella memoria di Nietzsche come una grave e serena esperienza; e infatti gli appare come una visione, un ultimo quadro idilliaco, prima dei tempi mostruosi del 1870, prima dell’altra guerra… quella che poneva il rivoluzionario di domani contro quello di ieri, il poeta dell’avvenire contro il musicista del passato.
Fin d’allora Nietzsche lavorava alla Nascita della Tragedia; aveva portato con sé gli appunti fin sotto le mura di Metz, li riportò in Germania quando rientrò dai campi di battaglia lorenesi, li ficcò nella valigia quando, con sua sorella, intraprese attraverso il massiccio del San Gottardo il suo primo viaggio a Lugano. Era il principio di febbraio nel 1871. Stretti sul piccolo traino a due posti, Friedrich ed Elisabeth scivolavano sotto il caldo sole d’inverno, al ritmo dei sonagli del cavallo, sui declivi che salgono e discendono, tra i pini di Natale ovattati di silenzio e picchiettati di ghiaccioli, verso le porte d’Italia.
Nietzsche rivede tutto ciò sulle rive di quel patetico lago. O piuttosto lo risente, ché non è quasi mai con gli occhi ch’egli si ricorda (quegli occhi troppo miopi), ma per mezzo dell’udito. Le sue nostalgie non concernono affatto i paesi ch’egli ha visto, i colori, i quadri, i visi, ma le musiche che ha inteso, la voce delle creature che ha amato, la sonorità dell’aria che ha respirato, del suolo che ha calpestato, infine la vita armonica, il canto delle cose e delle persone.
Come avviene nei ciechi è questa materia immateriale che trova accesso nelle sue profondità e, nei giorni tristemente dolci del ricordo (come in questo giorno), risale dall’oblio per popolare l’aria, la rena, la riva, di risonanze dolorose. Mi sembra che raramente la definizione della malinconia data da Gide nelle sue Nourritures terrestres si sia meglio verificata che qui, in quell’uomo e in quel momento di fulgente solitudine: “La mélanconic n’est que de la ferveur retombée…”.
La sua prima opera appare, dunque, al principio del 1872. Wagner gli scrive non appena riceve il libro: “Non ho mai letto niente di più bello…”. E Cosima: “Il vostro scritto risponde a tutte le domande che intimamente mi ponevo…”. Poi ancora: “Quanto è bello il vostro libro! Bello e profondo! Profondo e ardito! Mi domanderei con angoscia chi vi ricompenserà se non sapessi che concepen...