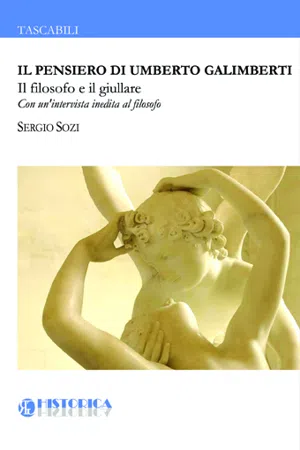![]()
1. Sotto il naso
Nella vastissima opera di Umberto Galimberti, troviamo tutto quel che sta sotto il nostro naso senza che nessuno di noi sappia capirlo, o meglio approfondirlo, contestualizzarlo, giustificarlo nel senso di darne una spiegazione il più possibile esauriente e coerente attorno a dei dati punti di partenza (che per Galimberti sono inseriti in un ordine di tipo genealogico-filosofico in senso nietzschiano, o fenomenologico-filosofico), ossia sistematizzarlo – pur anche, com'è abitudine del Nostro, più ricorrendo al pensiero di altri che non al proprio, cioè leggendo il tutto tramite l'unire frammenti di letture altrui secondo la finalità principe consistente nell'analizzare la nostra epoca.
Un'epoca, questa, che l'autore reputa meritoria di studio in quanto fortemente differente dalle precedenti (da ciò il suo procedere in base ad un metodo che sorge dalla storia in quanto studio della genesi di ogni evento dal precedente cioè dalla storia come genealogia, e dalla fenomenologia della filosofia che ci ha preceduto, così riferendosi sia ai testi che alla realtà nel loro rispettivo procedere e mutare – queste due dimensioni, rispettivamente, lette o intuite. Diremmo così che la creatività di Galimberti si configuri massimamente nel saper estrarre dalla sua gigantesca epitome del pensiero umano, finora giuntoci, delle conclusioni che mai siano esplicite ma costantemente intuibili da parte del lettore, nonché di certo foriere di rivivificante dibattito a tutti i livelli della società).
Al filosofo, comunque, contrariamente che al sottoscritto, il quale il tutto lo vede solo in virtù di un possibile suo (ingenuissimo) utilizzo in funzione affabulatorio-narrativa, spetta toglierci tutto da sotto il naso ed inserire questo tutto, ed anche l'oltre questo tutto, in un sistema. La sistematizzazione, dunque, è aspirazione da sempre quanto meno legata alla filosofia (certo, però, resta il fatto che l'esaustività totale non è di questo mondo, dunque nemmeno dei sistemi filosofici, che, fra le opinioni umane, forse rappresentano i più articolati sforzi di comprensione del tutto che la nostra razza possa elaborare, come risultato dell'insieme di razionalità, passione, riflessione, visionarietà, coscienza e capacità analitica innata che alcuni membri della nostra tribù sono stati e sono tutt'ora capaci di coagulare esprimendosi – almeno infine se non in itinere durante l'elaborazione – alfabeticamente).
L'approfondimento di tutto quanto resti legato a ogni uomo, tuttavia, Galimberti ha il dono di riuscire a compierlo senza che mai scompaia al lettore il referente fondamentale, che rimane sempre il nostro naso: pochi, come vedremo, nella sua scrittura, i tratti oscuri o sibillini, quasi assenti i termini specifici che non siano corredati di adeguata spiegazione dell'accezione voluta, in modo da portare il suo pensiero all'altezza di qualsiasi uomo di buona volontà che abbia una minima assiduità con la filosofia e disponga di tempo ed energia per dedicarsi a questa disciplina, la quale, nella domanda umana rispetto alla determinazione del destino, per gli antichi Greci, superata la fase mitica, significava ''ricerca delle cause, dove l'efficienza, la finalità, la forma e la materia offriranno, come vuole (...) Aristotele, la ragione di ogni cosa'' (da Psiche e techne. L'uomo nell'età della tecnica, Milano 1999, p. 83).
La filosofia, perciò, anche per il Nostro e per l'oggi, sin dall'antichità greca ed almeno in larga parte, è ''scienza delle cause prime'', ossia ''quel lungo percorso che Talete ha inaugurato quando, ponendo la domanda circa il 'principio di tutte le cose', ha dato avvio a quel modo di pensare teso alla costruzione di un Uni-verso in cui dissolvere ogni di-verso, ogni pluralità, ogni differenza in cui si articola il mondo-della-vita. Questo modo di pensare, che siamo soliti chiamare 'filosofia', riconosce solo ciò che si lascia ridurre ad unità. Il suo ideale è il sistema in cui la molteplicità delle figure del mondo-della-vita trova la sua posizione e il suo ordinamento'' (ivi, pp. 387-388).
Perché questo fosse e sia possibile, l'operazione ineludibile che l'uomo greco compì fu l'elaborazione della logica formale acché l'uomo potesse (e possa) calcolare l'universo al di fuori della certezza sensibile, cioè dei dati immediati e sensibili della vita. ''La certezza sensibile fu così sacrificata per una certezza superiore: la certezza dei costrutti della mente che potevano raccogliere i responsi della sensibilità solo se convalidanti i costrutti edificati indipendentemente dalla sensibilità'' (ivi, p. 388).
Questo è – ma filologicamente in coerenza con le origini greche della disciplina dunque esternamente alla degenerazione attuale della logica formale in madre ed essenza della assoluta tecnologia, dove assoluto significa un triste solutus ab, ''sciolto da ogni legame, quindi da ogni orizzonte di fini, da ogni produzione di senso, da ogni limite e condizionamento'' (ivi, p. 680) – questo è, dicevamo, anche il mestiere che Galimberti si assume sulle spalle e, direi, dentro di sé. Questo il suo agire, ma tutto fuorché assoluto. Perché l'azione è l'essenza dell'uomo, ne fa parte, automatica in lui-noi come il muoversi, sia col corpo che con il resto che ci costituisce. Così riportare – con libri come i tanti suoi fin oggi editi – l'azione umana sotto il naso degli uomini stessi che rischiano di perderne la consapevolezza, ma trasfigurata, anzi sovente sublimata di prima inavvertibili sfumature e fondamenta che superano l'azione stessa (sublimare è andare oltre dei limiti), è cosa una con il procedere scrittorio piano e coerente, articolato ma scorrevole, di qualsiasi testo di Galimberti. Egli non ci sembra mai dimenticare la sua natura di uomo fra gli uomini, ben inoltre conscio della propria innata funzione di (eccelso) epitomatore critico delle azioni umane. Critico, già... criticare, dice lui stesso, con il suo solito ricorrere all'etimologia (ma non sempre ce se ne ricorda), nient'altro è se non distinguere, cioè, di conseguenza e strettamente a ciò, vagliare, esaminare... sezionare per poi poter riunire. O meglio ancora sezionare riunendo. Senza, per questo, scegliersi un uditorio piuttosto che un altro. Diremmo criticare restando se stessi. Un sé che, nel caso di Galimberti, è rivolto apertamente in modo indiscriminato a tutti. Tutti quelli che possono – ognun dica per sé autonomamente – ascoltarlo. La convinzione è quella che la natura umana risieda in quella tendenza a distinguere grazie alla quale l'antenato diretto dell'uomo di oggi apparve sulla terra, tagliando il cordone ombelicale con l'interpretazione mitica del mondo e dell'esistenza. Era l'uomo nato dalla filosofia greca, poiché essa troncò per prima quel legame assumendo la ragione come fulcro dell'umanità, perciò facendo uscire questa dalla notte dell' ''indifferenziato'' in cui abitava il dio (che era un lui-loro, va specificato: Dio-Dèi, così la penso) e gli uomini con Lui. Un Loro a guida di un Lui.
Un'umanità tale e quale, ripeto, almeno in questo, ad oggi, pur mutatis mutandis riguardo alle modalità del criticare, del distinguere, dell'identificare.
Dunque Galimberti non scrive per l'accademia, per i suoi colleghi universitari del secolo XXI d.C., ma per l'uomo che voglia indirizzare alcune delle proprie azioni al capire chi sia e da dove venga, all'uomo cui Galimberti ricorda quel passo (cioè la nascita della filosofia greca) dall'indistinto al distinto, e poi, a causa del sopravven...