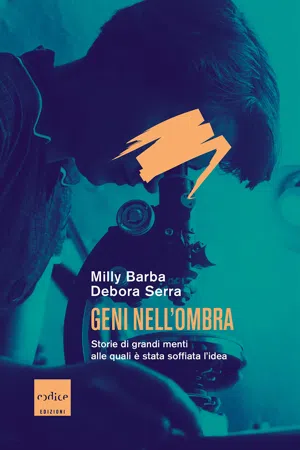![]()
Capitolo 1
Trotula De Ruggiero
Siamo in Campania, in un’antica Salerno dominata dai Longobardi. Con molta probabilità (o forse no) è il 1030. La nobile e influente famiglia dei De Ruggiero festeggia la nascita della piccola Trotula, di cui, nel corso della storia, le notizie si perdono o si ricamano, costruendo intorno all’immagine della donna un alone di leggenda, veridicità e pionieristico progresso. Di Trotula – più verosimilmente Trotta, Trocta o magari Trottola – persino il nome è incerto e la memoria storica non è clemente. Della sua adolescenza nulla ci è noto.
I primi indizi che riconducono alla reale esistenza della mulier salernitana si trovano nella Historia ecclesiastica del monaco normanno Odorico Vitale, scritta tra il 1114 e il 1142. L’opera racconta l’incontro avvenuto nel 1059 a Salerno tra il nobile Rodolfo Malacorona, edotto in medicina, e una nobilissima donna assai colta, l’unica in grado di tenergli testa.
Un secondo indizio lo troviamo all’interno del Lai Deus amanz, scritto da Marie de France alla fine del XII secolo, dopo la Historia ecclesiastica di Vitale. Un racconto che vede al centro l’amore contrastato di due ragazzi e la loro richiesta d’aiuto a una donna salernitana, che dalla descrizione sembra corrispondere proprio a Trotula. E ancora, il poeta trovatore francese Rutebeuf ne Le Dit de l’herberie, un monologo del XIII secolo, cita Trotte, una donna sapiente che metteva a punto medicinali per la cura dei suoi pazienti, ottenuti anche dall’uccisione di animali feroci. A questa narrazione dai contorni mitici, si aggiunge la citazione nell’opera Placides et Timéo, o Li secrés as philosophes, risalente al XIII secolo, nella quale si fa riferimento agli insegnamenti di Trocta. La sanatrix riappare poi tra le citazioni di papa Giovanni XXI, nel Thesaurus pauperum, e a seguire, nel XIV secolo, come Dame Trot da Salerno ne I racconti di Canterbury dell’inglese Geoffrey Chaucer.
Che cosa sappiamo realmente di Trotula? Con ogni probabilità si avvicina molto presto agli studi di medicina presso la prestigiosa scuola medica salernitana. L’estrazione sociale e la vocazione laica di Salerno, così come l’apertura mentale del luogo, garantiscono a Trotula la scelta di un futuro in linea con le sue ambizioni. Ad agevolarne la vita, anche la grande capacità dei De Ruggiero di fare del cambiamento un’occasione propizia. Prima sono presenza di spicco nel panorama sociale al fianco dei regnanti longobardi e anni dopo, tra il 1076 e il 1077, durante il passaggio di Salerno sotto il dominio normanno, entrano nelle grazie del nuovo duca Roberto d’Altavilla, detto il Guiscardo, preservando nel tempo il proprio potere e lo status sociale.
Le ipotesi prevalenti vedono Trotula diciottenne e sposa di Giovanni (forse Matteo) Plateario, detto il Vecchio, noto magister della scuola medica salernitana e tra le personalità più influenti di Salerno, ma non sappiamo se le nozze sono state frutto di una libera scelta o di un’imposizione familiare. Dall’unione nascono due figli, destinati come i genitori alla carriera medica nella scuola salernitana, Giovanni e Matteo. E poi, dopo qualche tempo, forse anche il terzo, Ruggiero.
Le esigue e incerte informazioni sulla vita personale di Trotula cedono il passo alla sua carriera, al carattere e alla sapienza che hanno fatto della sanatrix l’antesignana della medicina moderna, nonché una vera “dottoressa delle donne”. L’ambiente multiculturale e la ventata di innovazione tipica della Salerno medievale contribuiscono ad alimentare il genio magmatico della scienziata, capace di porre le basi della medicina europea.
Trotula approfondisce ogni aspetto della salute femminile, trascrivendo e così tramandando la propria conoscenza in campo ostetrico fino al XIX secolo. Precorre le scoperte sul fronte ginecologico e comprende l’importanza della prevenzione e dell’igiene per la salute dell’individuo.
La sua attenzione non pertiene solo la sfera scientifica ma anche quella umana. Cerca, per esempio, strumenti e terapie meno dolorose, prova ad alleviare le sofferenze del parto, individua metodi per controllare le nascite o promuovere la fertilità. Questi argomenti sono tutti racchiusi nel primo dei libri attribuiti alla sanatrix salernitana o, più verosimilmente, fatti scrivere da lei: il De passionibus mulierum ante in et post partum, conosciuto anche come Liber de sinthomatibus mulierum. Il libro apre alla conoscenza di aspetti propri della ginecologia e della sessualità, rifacendosi al pensiero galenico, del quale la scuola medica salernitana è promotrice. A questo volume si aggiungono il De ornatu mulierum e il De curis mulierum. L’unico a essere sicuramente di suo pugno, tuttavia, è il Practica secundum Trotulam.
Per comprendere le grandi abilità di Trotula e il modo con il quale nel tempo si è tramandato il suo sapere, occorre non perdere mai di vista la centralità della scuola medica salernitana – prima scuola di medicina in Europa – e il fatto che fosse un luogo multietnico, un crocevia di conoscenza e il centro dell’antica farmacopea europea.
Una leggenda – che in sé è vera e propria metafora – narra della fondazione della scuola prima dell’anno 1000, a opera di quattro medici raccolti sotto gli archi del vecchio acquedotto cittadino: il greco Pontus, proveniente da Alessandria d’Egitto; il latino Salernus; l’ebreo di Betania, Helimus; l’arabo Abdela, da Aleppo, in Siria. Quattro epigoni della medicina provenienti da culture, luoghi e storie differenti che uniscono il proprio sapere con l’intento di diffonderlo.
La tradizione empirica e narrata, fondata sulle analisi del battito cardiaco o sull’esame delle urine, dall’XI secolo si somma a quella tramandata per iscritto, voluta in primis dal medico salernitano di origini longobarde Garioponto. A lui si deve la svolta e l’influenza culturale trasmessa alla scuola – e intercettata da Trotula – attraverso l’opera in cinque volumi Passionarius, un trattato sulle malattie nel quale convergono a tutti gli effetti le dottrine di Ippocrate e Galeno. Sempre a Garioponto, maestro di Alfano, a sua volta medico-arcivescovo mentore diretto di Trotula, dobbiamo il processo di istituzionalizzazione del percorso scolastico, con il conseguimento della laurea abilitante e la possibilità di esercizio della scienza medica nel pieno interesse della salute del malato e secondo il principio del primum non nocere, in linea con il giuramento ippocratico.
Ad accrescere il sapere detenuto dalla scuola medica salernitana, anche Costantino detto l’Africano, nato in Nord Africa, di fede musulmana e capace di parlare e comprendere il latino. Il suo contributo è prezioso: traduce almeno venti volumi medici provenienti dal mondo arabo e sconosciuti in Europa. Così Salerno si apre a un bacino inestimabile di conoscenze nei campi più svariati, dall’eziologia alla prevenzione, fino alle malattie degli organi riproduttivi, sapere al quale Trotula attinge in modo puntuale. Tra i meriti di Costantino, anche l’introduzione dell’alchimia, intesa quasi come la chimica moderna, studiata lungamente nel mondo islamico e subito inserita nel programma della scuola.
Trotula non è la prima nella storia a esplorare il mondo della ginecologia; tuttavia la sua medicina ha peculiarità specifiche che la contraddistinguono. Si basa sulla teoria ippocratica dei quattro “umori” che rispecchiano i quattro elementi: «Il sangue caldo e umido come l’aria prevale in primavera, il flegma che è freddo e umido come l’acqua è proprio dell’inverno; la bile gialla calda e secca come il fuoco è caratteristica dell’estate; e infine la bile nera fredda e secca come la terra dell’autunno. La prevalenza di uno dei quattro “umori” sugli altri determina il carattere degli individui»1. Mentre il temperamento – ovvero l’equilibrio dei quattro elementi – rappresenta lo stato ottimale, il disequilibrio è malattia.
Oltre a Ippocrate, anche molti dei precetti di Galeno sono punti fermi della medicina di Trotula. Emerge, dal suo approccio con i pazienti, l’agire “da buon medico” galenico, che distingue una fase di anamnesi, la diagnosi e poi la terapia, dando all’ascolto e al dialogo con il malato un ruolo prioritario.
Gran parte della vita della sanatrix scorre, dunque, tra le mura sapienti della scuola medica salernitana. Qui riveste un ruolo importante e, se non è pari rispetto a quello dei colleghi magister, vi è molto vicina. Insegna, è a capo di un gruppo di mulieres che svolge “attività di ricerca” e opera come medico clinico in campo ginecologico. È tra le prime promotrici della tradizione scritta, inaugurata da Garioponto, a fronte della conoscenza orale.
Attua una medicina preventiva a scopo conservativo per evitare, laddove possibile, la chirurgia e le sofferenze annesse. Comprende la necessità dell’igiene personale e il suo valore; sottolinea spesso quanto sia importante lavarsi in modo puntuale. Ma non è tutto. Trotula ha un rapporto diretto con le donne che cura: riesce a entrarvi in confidenza, le analizza e le osserva da vicino nude, nell’intimità, una prospettiva di studio privilegiata che ai colleghi uomini non è concessa. Vede il desiderio femminile come naturale e giusto. Parla in modo esplicito di sessualità e di desiderio non soddisfatto quale origine di malessere; illustra le pulsioni maschili e femminili con un approccio medico del tutto inedito. Analizza la frigidità femminile con un punto di vista scevro da ogni preconcetto e, allo stesso modo, parla dell’impotenza maschile. Tra le sue più grandi intuizioni, il riconoscimento dell’infertilità come patologia di entrambi i sessi e la proposta di un “test” per verificare se l’uomo sia fertile o meno. Desume, in ogni caso, che l’infertilità è una condizione incurabile e svincola dalla “macchia della colpa” le donne che non possono procreare. Propone sistemi anticoncezionali e trattamenti per influenzare il sesso del nascituro. In particolare, nel De passionibus mulierum ante in et post partum, si concentra su tutti gli aspetti legati al parto, pre e post, suggerendo cure, applicazioni e buone pratiche. Affronta qualsiasi necessità o stato delle sue pazienti con comprensione. Focalizza la sua attenzione sulle complicanze che derivano dalla gravidanza, formulando rimedi e applicazioni per evitare lacerazioni. Ma la madre non è l’unica a giovare del suo intervento: per preservare la salute dei neonati vi sono regole da osservare che riguardano in particolare l’alimentazione delle balie che sono incaricate di nutrirli e devono avere specifiche caratteristiche.
Anche nel De curis mulierum si focalizza sul post partum ma con riferimenti differenti, nuove proposte di cura – non ascrivibili solo ai principi della dottrina galenica – e l’illustrazione di molte altre malattie, senza un preciso ordine. Nel tempo si è supposto che il testo abbia subito più interventi, magari non di suo pugno, e spesso il trattato è stato attribuito alla mano di altri.
Le terapie proposte nel De curis prevedono, tra le altre, l’eliminazione dei pidocchi dalla zona genitale, rimedi per i denti neri, il cancro e persino l’obesità, correlata da Trotula proprio all’infertilità, in linea con i precetti della scuola medica salernitana: «Se ti mancano i medici, siano per te medici queste tre cose: l’animo lieto, la quiete e la dieta moderata»2.
La scienziata salernitana non è solo maestra di medicina: eccelle anche nelle cure di bellezza. Nel primo trattato di cosmetica della storia a lei attribuito, il De ornatu mulierum, come le altre opere probabilmente non scritto di suo pugno, i consigli di bellezza sono rivolti proprio alle donne e pertengono anche la sfera della seduzione. Come i più moderni dettami di medicina estetica, la sanatrix propone rimedi di lunga giovinezza: depilazione, metodi per nascondere rughe o lentiggini, per tingersi i capelli o avere un alito gradevole. Una cura dedicata a donne di ogni estrazione sociale, come non manca di specificare nel trattato, vero manuale di chimica cosmetica ed erboristeria con ben sessantatré ricette per rimedi di ogni tipo. I dettami di cosmetica non sono solo di sua creazione: arrivano a Trotula anche attraverso la sapienza delle donne di origini arabe, presenti a Salerno nell’XI secolo, e quali prezioso retaggio di un viaggio in Sicilia che la porta a conoscere gli usi delle donne saracene.
Nell’ultima opera a lei attribuita – forse parte di un trattato più vasto – la Practica secundum Trotulam, le malattie studiate sono varie e la medicina delle donne, pur presente, lascia il posto a uno sguardo globale e generalizzato su patologia e cure.
La vita di Trotula e la sua dedizione medica d’avanguardia si interrompono con molta probabilità nel 1097, a Salerno, quando la donna che il mito vuole di estrema bellezza si spegne all’età di sessantasette anni.
Tra le notizie tramandate nel tempo, c’è quella che vede il suo feretro seguito e compianto da un corteo lungo tre chilometri. A ciò si aggiunge una prova della datazione certa della sua morte, rinvenuta in un documento firmato dal figlio Ruggiero, che testimonia un lascito in onore della madre, proprio nel 1097, e la reale esistenza di Ruggiero. E ancora l’iscrizione, nello stesso anno, di tale Trocta o Trotta nel registro delle morti della cattedrale di Salerno.
Se i vuoti storici permettono una ricostruzione difficile e incerta, il ruolo di pioniera in campo ostetrico e ginecologico di Trotula resta indubbio. Oggi però molti dei suoi rimedi non sarebbero certamente catalogati co...