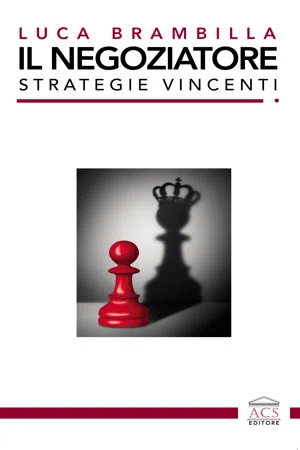![]()
UNO
La natura della negoziazione
Diamoci del lei
Buongiorno, Luca. È d’accordo se ci diamo del lei?
Sì, e per varie ragioni.
Me le vuole illustrare?
La prima per deformazione professionale: con tutti i clienti e i nostri nuovi contatti ci diamo del lei. La seconda è strategica: usare il lei fa sì che le persone debbano stare a distanza. Questo permette di individuare più facilmente gli interessi dell’interlocutore e soprattutto smaschera le tecniche manipolatorie con cui le parti fingono di essere amiche per poi non rivelarsi tali nei fatti. La terza ragione è estetica.
Questa terza ragione è quella che mi incuriosisce di più.
C’è un modo di dare del lei dentro cui si nasconde il tu. Mi spiego meglio: si è eleganti nella forma, si rispettano i ruoli ma, allo stesso tempo, si fa percepire che la relazione è personale. Un bravo negoziatore deve sia essere vicino al suo mandante per coglierne gli interessi, sia, in qualche modo, lontano per non subirne troppo la pressione psicologica. Abituarsi a dare del lei, facendo brillare il tu, è un ottimo allenamento per essere dei professionisti in questo mestiere.
Il negoziatore. Ovvero colui che costruisce ponti mentre altri gettano bombe
Lei come si definisce?
Un negoziatore.
Informandomi su di lei online ho letto del suo incarico come professore di Comunicazione Strategica e Negoziazione in diverse università. Come mai si definisce semplicemente “un negoziatore”?
È vero che ho diversi incarichi come adjunct professor, ma il mio mestiere è quello del negoziatore.
Che cosa fa un negoziatore?
Se volessimo dirlo in maniera romantica: è colui che costruisce un ponte mentre altri gettano bombe.
Se volessimo dirlo brutalmente?
Direi che è colui che viene chiamato ogni volta che vi è un conflitto, perché non c’è niente di più utile che avere accanto un negoziatore in mezzo a una guerra.
Quindi non sono i negoziatori a cercare le guerre, ma le guerre a cercare i negoziatori?
Esatto. I negoziatori cercano la pace. Per questo, forse, nonostante i pregiudizi, sono gli ultimi idealisti rimasti. Questo perché non potrebbero fare il lavoro che fanno senza credere fermamente nella pace.
Ma se non ci fossero più conflitti, quindi, non avrebbero lavoro?
Questo i negoziatori lo sanno, ma essendo realisti sanno anche che, per ora, nessuno rischia di rimanere disoccupato. Anzi.
Mi aiuti a capire meglio. Forse non sono ancora pronto per parlare col Tu-negoziatore e vorrei fare alcune domande al Tu-formatore. Di che cosa si occupa un formatore di negoziazione?
Forma innanzitutto le persone su che cosa si intende per negoziazione. Successivamente, forma sulle fasi del processo, gli approcci negoziali, il ruolo e le competenze del negoziatore e, ovviamente, la cosa più interessante di tutte: esempi di casi reali di quando è sceso in campo in prima persona.
Quindi un formatore dev’essere per forza anche un negoziatore sul campo?
Se in circostanze normali è raro che uno studente si innamori di una materia quando il docente non ne ha fatto esperienza, risulterebbe ancora più difficile catturare la sua attenzione nell’ambito di un corso che ha a che fare con quanto di più profondo ha l’uomo, ovvero i suoi interessi, se chi insegna non ne avesse mai fatto esperienza.
Insomma, ogni formatore dovrebbe essere anche un negoziatore.
Esatto. Non vale invece l’opposto. Questo perché l’abilità di estrarre modelli comportamentali e metodi di approccio alla negoziazione non è una caratteristica che contraddistingue tutti i negoziatori. Ovviamente, se lo scopo è trasmettere un valore reale alle persone in formazione. Se invece lo scopo è quello di riempire delle ore di un corso, basta pescare qualcuno a caso dal mucchio di quelli che dicono: “Tutti negoziamo tutti i giorni”.
A questo punto scatta naturale la domanda: chi si forma con lei si innamora dei suoi corsi?
Questo andrebbe chiesto a loro. Il mio obiettivo, in realtà, non è tanto che si innamorino dei miei corsi, quanto che si sentano soddisfatti, se possibile addirittura felici, dei risultati raggiunti grazie a ciò che hanno imparato frequentandoli.
Mi permetto di insistere: si innamorano della negoziazione?
Visto che la passione, come l’amore, spesso si trasmette per osmosi, direi che sì, si innamorano. Lo fanno perché io per primo sono innamorato dei suoi frutti.
A questo punto la curiosità cresce e mi spinge a chiederle cosa si possa intendere, secondo lei, con il termine “negoziazione”.
Vi sono moltissime definizioni di questa parola, in quanto identifica un’azione ancestrale degli uomini. Per cui posso semplicemente dire qual è la definizione che io ritengo più completa e, quindi, spendibile.
Qual è?
La definizione che preferisco è stata identificata da un team di esperti negoziatori e studiosi che fanno parte dell’Accademia di Comunicazione Strategica, di cui sono Direttore. La definizione che diamo, in questo caso il plurale è d’obbligo, è la seguente: “Negoziazione: processo extragiudiziale di comunicazione strategica volto alla risoluzione di conflitti”.
Dietro alla sua apparente semplicità ed eleganza, mi sembra una definizione complessa.
Come definizione promossa da un’accademia, in effetti, ogni termine che la compone ha un peso specifico importante e un significato chiaro.
Mi aiuti a capire meglio.
Con “processo” si intende che la negoziazione non è un atto, bensì per l’appunto un processo, una dinamica costituita da più fasi. Le fasi del processo negoziale possono essere classificate attraverso due diversi approcci: uno più psicologico, l’altro più tecnico. Il primo, quello psicologico, comprende un percorso che parte dall’identificazione di un conflitto fino alla metabolizzazione dell’accordo o del mancato accordo. Il secondo, quello tecnico, che personalmente prediligo, vede tre macro fasi, costituite poi da diverse sotto fasi. Le tre macro fasi sono: la Preparazione, la Trattativa e l’Accordo.
Perché predilige l’approccio tecnico?
Perché aiuta a fare chiarezza e perché un approccio tecnico permette di valorizzare, paradossalmente, gli aspetti psicologici intrinseci nel processo negoziale.
Un altro termine che mi incuriosisce è “extragiudiziale”. Proceda pure nella spiegazione.
Con extragiudiziale intendo che al centro di un processo negoziale vi sono gli interessi, e non i diritti.
Anche qui il tema mi sembra complesso.
Condivido una storia che mi può permettere di rendere più semplice ciò che intendo dire. In una grande casa ci sono due sorelle gemelle, Sara e Marta, di otto anni. Un giorno, entrambe escono dalla propria stanza e si recano in cucina. I loro occhi finiscono per posarsi su una bella e succosa arancia posta nel cesto della frutta sul tavolo. Si tratta dell’unica arancia presente. Entrambe si avvicinano al tavolo e, nel momento in cui poggiano la propria mano sul frutto, scoprono che entrambe la desiderano. All’inizio Sara usa la forza e tenta di tirare l’arancia strappandola dalle mani di Marta. Quest’ultima, ovviamente, inizia a fare lo stesso ma, essendo gemelle con la stessa età e forza, nessuna delle due riesce a prevalere sull’altra. A un certo punto si mettono a litigare, alzando la voce. Il vociare arriva fino in sala, dove la madre sta leggendo un libro. Seguendo le voci, che si fanno sempre più alte, la madre raggiunge la cucina, chiedendo alle figlie spiegazioni. Prontamente, Marta risponde: “Ho visto per prima io l’arancia, spetta a me”. Ma Sara replica: “No! Sono io ad averla vista per prima, è mia”. La madre allora interviene con autorità, prende l’arancia dalle mani delle figlie, tira fuori un coltello affilato e divide perfettamente il frutto, dando a ciascuna una metà. Le figlie si girano dando le spalle l’una all’altra imbronciate, mugugnando che meriterebbero l’intera arancia, mentre la madre replica che in quella casa è lei a stabilire le regole e che, comunque, ognuna aveva avuto la sua parte. In cucina Marta trova uno spremiagrumi e si prepara una spremuta, riempiendo appena mezzo bicchiere e rimanendo alquanto delusa. Sara si avvicina al tavolo dove è appoggiata una torta, prende un coltello, toglie la scorza dell’arancia, la trasforma in canditi e decora solo metà del dolce. Finita l’operazione, Marta butta via la buccia, inutile ai fini della spremuta. Viceversa, Sara elimina la polpa, superflua per la preparazione dei canditi per la torta. Nello stesso cestino, dunque, rimangono sia metà polpa, sia metà buccia.
Ho capito. E se abbandonassimo la metafora?
Ogni volta che vi è una relazione tra due o più persone, è intrinseca la potenzialità di un conflitto. Per risolvere i conflitti esistono tre vie principali. Immagini una piramide. Nella punta più alta, quella che corrisponde all’istinto, si soddisfano i bisogni. Qui la via per soddisfare questi bisogni è la forza, tant’è vero che le due sorelle hanno provato a strapparsi l’una dalle mani dell’altra l’oggetto del desiderio, la famosa arancia. Ciascuna, trovandosi però di fronte all’impossibilità di superare la forza della gemella, è passata a un secondo livello: quello dei diritti, la parte centrale della piramide. Fuori di metafora, la madre ha fatto il giudice, intervenendo con le sue regole di fronte alle figlie che si sono trasformate negli avvocati difensori dei propri diritti. Ognuna, infatti, ha rivendicato di aver visto l’arancia per prima, avanzando il diritto a possedere il frutto. L’intervento della madre è stato quello di un bravo giudice che agisce in maniera equa, utilizzando le proprie regole. Alla base della piramide, però, vi è un terzo livello, quello degli interessi. Questi si soddisfano attraverso la negoziazione. Se, infatti, le due ragazze si fossero confrontate sui reali interessi e sui reali obiettivi che ciascuna di loro aveva, avrebbero ottimizzato le risorse in campo, uscendo dal confronto pienamente soddisfatte: una con il bicchiere pieno di succo d’arancia e l’altra con la torta perfettamente adornata di canditi. In questa storia vorrei sottolineare due elementi: il primo è che gli interessi, essendo alla base della piramide, sostengono, e quindi valorizzano, sia il piano dei diritti, sia il piano dei bisogni. Il secondo elemento che vorrei evidenziare è che la negoziazione, tra le tre modalità di risoluzione dei conflitti, è quella che soddisfa di più entrambe le parti: è la via che permette di generare maggior valore.
Vorrei fare l’avvocato del diavolo. Lei ha detto che la negoziazione è la via che permette di generare maggior valore.
Lo confermo.
Ma se una delle due ragazze avesse avuto più forza dell’altra, avrebbe potuto procurarsi tutta la buccia o, eventualmente, tutta la polpa che le serviva.
Può essere. È vero, però, che avrebbe potuto ricavarne delle ferite, se fossero arrivate alle mani. E anche se non fossero giunte a questo livello di scontro, la sorella perdente si sarebbe vendicata in una futura occasione e, in ogni caso, siamo certi che la relazione tra loro sarebbe peggiorata. Nel caso negoziale, invece, dico che si sarebbe potuto produrre maggior valore in quanto, una volta risolto il conflitto, la relazione tra le parti sarebbe rimasta immutata, o forse addirittura migliorata. Di sicuro, non sarebbe migliorata nel caso in cui avessero scelto la via della forza per risolvere la diatriba.
Mi ha convinto. Ma si prepari, perché l’avvocato del diavolo è un ruolo che amo. Ora procediamo con la spiegazione della definizione.
Anche riguardo al termine “comunicazione strategica”, purtroppo, c’è molta confusione. A noi dell’Accademia è sembrato giusto, vista la bellezza di questo termine, (ri)costruire un nuovo significato, perché molti, forse tutti, hanno usato queste parole in svariati contesti, senza indicare in maniera chiara che cosa si intendesse con “comunicazione strategica”.
Anche in questo caso, quindi, propone la definizione creata dalla vostra Accademia?
È così. Mi pare l’unica che da una parte valorizza le precedenti definizioni e, dall’altra, è concreta e spendibile. Quindi per “comunicazione strategica” si intende quella comunicazione che valorizza l’Io, il Tu e il Contesto. Come si può intuire, si può parlare di comunicazione strategica in molti ambiti diversi, dalla comunicazione interpersonale, a quella corporate, fino a quella di marketing. Personalmente, da anni studio in verticale il tema della comunicazione strategica in ambito interpersonale. Non a caso, ne parlo in riferimento alla negoziazione, o meglio, al processo negoziale.
Mi dica di più: che cosa si intende per io, tu e, soprattutto, contesto? Ah, io li “pronuncio” con l’iniziale minuscola per non… compromettermi.
Capisco perfettamente, e non negozierò con lei sulle maiuscole. Con “Io” si fa riferimento agli interessi di un soggetto. Col “Tu” si fa riferimento agli interessi dell’altro o degli altri soggetti presenti all’interno della dinamica relazionale. Per “Contesto”, invece, si intendono tutti gli elementi oggettivi e soggettivi in grado di influenzare la relazione tra l’Io e il Tu. Per esempio, se due persone negoziano all’interno di una stanza, un elemento di contesto importante è comprendere se si trovano nell’ufficio di uno, dell’altro, o magari in una neutra sala riunioni di un albergo. In questo caso, la stanza è una variabile che definisco “oggettiva”. In altri casi, occorre analizzare gli elementi del contesto soggettivi, quindi quelle persone che potrebbero favorire o sfavorire un accordo.
Mi racconti dei casi concreti in cui ha operato tenendo conto del contesto oggettivo e di quello soggettivo.
Tempo fa ho guidato un team di avvocati che dovevano negoziare un accordo multimilionario. La location scelta per l’incontro con la controparte era un bellissimo albergo di Milano, scelto apposta come luogo “neutrale”, a differenza dei rispettivi studi. Tre giorni prima dell’incontro ho portato il team a cui facevo consulenza in quell’albergo in modo tale che studiasse gli spazi della sala riunioni, che potesse fare simulazioni in loco e che sentisse quel luogo un po’ familiare. Questo elemento ha fatto sì che all’arrivo degli altri avvocati i miei clienti “giocassero in casa”. E si sa che quando si gioca in casa si “performa” meglio.
Conoscendo il contesto, quindi, lo si può usare a proprio vantaggio. Un aneddoto di quando ha prestato particolare attenzione a un elemento soggettivo del contesto?
Alcuni mesi fa un mio cliente mi ha chiesto di aiutarlo a negoziare l’acquisto di una villa a Monaco in cui sarebbe andato ...