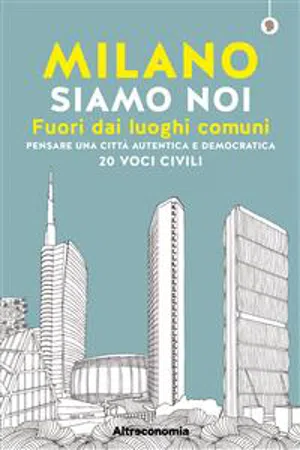“ La vita è agra, lassù ”.
Luciano Bianciardi, La vita agra
“La vita è agra, lassù”, scriveva Luciano Bianciardi nel suo capolavoro, dove tratteggia un ritratto feroce della metropoli milanese. “Lassù se caschi per terra nessuna ti raccatta”. E ancora. “ Ogni mattina mi desta il filo di luce che trapela dalle tapparelle, e sotto il ringhio sordo della città che ha cominciato a mordere”.
I detrattori di Milano non mancano, nelle diverse epoche “storiche”, anche le più recenti. La centralità stessa della città fatalmente le assegna spesso il ruolo del “cattivo”. Milano come centro del terrorismo negli anni di piombo, Milano come capofila del craxismo e della corruzione, Milano come “capitale immorale” durante Tangentopoli e Mani Pulite, la “Milano da bere”, città dell’individualismo sfrenato e, negli anni Ottanta e Novanta, il cuore del progetto mediatico-politico berlusconiano.
Tutte “narrazioni” basate, senza dubbio alcuno, su fatti passati in giudicato, ovvero su evidenze sociali, ma che non rendono conto della complessità. Così come non ne tiene conto la “retorica” che - una volta compiuto un autoreverse a partire dagli anni ’10, dopo l’avvento della giunta Pisapia e l’esperienza di EXPO - ha rovesciato sulla città colate di apprezzamenti non inferiori a quelle di cemento.
Milano è stata trasformata in una sorta di intangibile “sacrario” della modernità vincente, in cui spesso è la narrazione stessa a contare, e la somiglianza con la realtà è un accidente. L’EXPO è il simbolo perfetto di questa dissociazione: una manifestazione sul cibo e l’agricoltura “sostenibili” appoggiata su una piattaforma di cemento, con multinazionali come sponsor .
Le parole chiave di questo successo globale sono state ripetute all’infinito, meglio se in inglese, fino a inverarle e materializzarle in una sorta di Ambroeus, il robot di Verza e supereroe padano : innovazione, attrattività, s mart city, green city, new skyline, e così via. Ma Milano è davvero a place to be...?
Prima premessa. Questo libro non nasce affatto con l’intenzione di “parlare male di Milano”. Il suo scopo è infatti palese e dichiarato: fare strame delle semplificazioni trionfalistiche, per riflettere su che cosa sia davvero Milano e che cosa fare per migliorarla.
Ma non era perfetta? Parliamone. In questo paradiso lo smog e le polveri sottili, secondo autorevoli studi, accorciano di un anno e mezzo la vita ai suoi cittadini e provocano quasi 4.000 decessi prematuri annui che potrebbero essere evitati se fossero rispettati gli standard fissati dall’Oms . Un bambino su dieci vive in condizioni di povertà assoluta (Fondazione Cariplo 2017) ed è ben noto il “gap educativo” tra il centro e le periferie, che cresce con la fuga delle famiglie italiane e le altissime percentuali di bimbi stranieri nelle classi, dove sono forti la dispersione e l’abbandono scolastico; l’osservatorio della Caritas Ambrosiana - inoltre - segnala che le famiglie povere, soprattutto durante e a causa della pandemia, sono in netto aumento . Anche in questa temperie i prezzi al metro quadro delle case sono cresciuti in media dell’1,3% nel 2020 (comprare una casa a Milano costa mediamente 5.710 euro al metro quadro), gli affitti in lieve diminuzione restano tra i più alti d’Europa, in particolare per gli studenti, e la gentrificazione spinge i meno abbienti verso la periferia più profonda. In tema di lavoro, insieme a chi riceve retribuzioni d’oro e che rende Milano la città “regina” degli stipendi c’è chi si barcamena con i lavori dirty, dangerous, demeaning o con lavoretti precari che coinvolgono anche quelli “intellettuali” (e con la pandemia i giovani con contratti a termine, oltre alle donne, sono stati i primi a perdere il lavoro): non a caso qui è nato il miracoloso San Precario . Senza dimenticare che il costo della vita è il più alto d’Italia . Milano è attrattiva anche per la criminalità organizzata : le mafie - in particolare la ’ndrangheta - hanno secondo tutti gli osservatoti e gli inquirenti stessi interessi e “locali” ben incardinate, e le segnalazioni di acquisizioni sospette con il Covid si sono moltiplicate; gli spazi sociali “liberi” vengono spesso sgomberati; i ristoranti sono una pletora di cucine spesso senza identità; il non profit e il volontariato vengono spesso confusi con la beneficenza.
Le inutili e capziose classifiche sulla qualità della vita per noi sono a zero.
Questa, lo ribadiamo, si chiama complessità. Oppure è la manifestazione della “maledizione del capitalismo”: in quasi tutti i luoghi in cui il benessere è diffuso, spesso è anche mal distribuito. Le parole chiave di questo libro possono dunque essere disuguaglianza e conflittualità. La prima è uno stato oggettivo, la seconda è una bestia che cova sotto le braci del benessere di cui sopra, soffocata a volte dal trickle down della Milano col coeur in man, a volte negata dall’ottimismo di maniera di chi regge la barra del timone, a volte rimandata dall’emergenza pandemica. Questo divario e questo conflitto latente sono il fil rouge che corre in queste pagine.
Perché parlarne? La domanda dovrebbe essere invertita. Perché tacerlo?
Del resto, si sa: buon giornalismo non è tanto dare le risposte ma fare le domande giuste. Milano è davvero un posto dove stare e soprattutto lo è per tutti? Il problema è costruire dei grattacieli dove installare multinazionali, calciatori e fruitori di grandi patrimoni o risanare il patrimonio edilizio pubblico dove vivono 135mila persone? Milano è una città che attrae investimenti o che drena risorse al resto del Paese? Saranno le Olimpiadi invernali e le piste di pattinaggio a portare benessere diffuso? In che modo la storica ossessione milanese che concentra enormi energie nella cerchia dei Bastioni si potrebbe trasformare in rinnovata “ossessione per le periferie”? In che modo declinare la svolta green del (candidato) sindaco Sala in una città che, al di là degli annunci e dei progetti come Forestami, ha solo 17 m 2 di verde pro capite (media nazionale 31 m 2), il consumo di suolo libero è solo mitigato e - sottolinea Ispra - “i terreni sono quasi saturi e le poche aree naturali residue sono preziosissime e vanno tutelate”?
Qual è - in sintesi - la strada maestra per realizzare una metropoli moderna, democratica, autentica, verde, partecipata e non un mero status symbol di se stessa?
La sfida è imponente. Questo libro dà allora voce a donne e uomini “milanesi” , pensanti e senzienti, tra cui eminenti docenti universitari, urbanisti, architetti, magistrati, studiosi, pensatori, giornalisti, scrittori, artisti... Ne nasce un vero e proprio “alfabeto della città”.
Gli argomenti toccati sono quelli esiziali per il presente e il futuro della città: urbanistica, sviluppo edilizio, qualità e costo della vita, aria e inquinamento, mobilità, scuola, periferie, diritti, lavoro, legalità, cittadini stranieri, questione di genere, salute pubblica, cultura, innovazione, non profit, persone fragili, cibo e ristorazione.
Parliamo di Milano senza veli, senza negarne la centralità o disconoscerne la bellezza. Lo facciamo in un momento decisivo, in quella bolla di tempo e di pensiero tra la pandemia in corso e le elezioni comunali (che mentre scriviamo sono state spostate ad autunno 2021); tra la voglia di continuare a specchiarsi narcisisticamente e un’incipiente “crisi di identità”.
Una guida “politica”, che racconta una città spogliata della retorica e dai luoghi comuni. Una narrazione diversa, che non si accontenta del riflessi delle lucine dell’Albero della Vita, ma, come dice Stefano Rolando, ama anche il “grigio su grigio” milanese ed è disposto a lottare per una città migliore, per tutti. Un libro dedicato soprattutto - non lo nascondiamo - a chi fa ancora oggi una “vita agra”. In sintonia con le parole della senatrice a vita Liliana Segre: “Milano è un’eccellenza che però va di pari passo con i vuoti di indifferenza che avvolgono quartieri fantasma e periferie”.
In sintesi, se Milano siamo noi, come dice Massimo Guastini nel suo brillante pezzo, ecco che ne siamo responsabili.