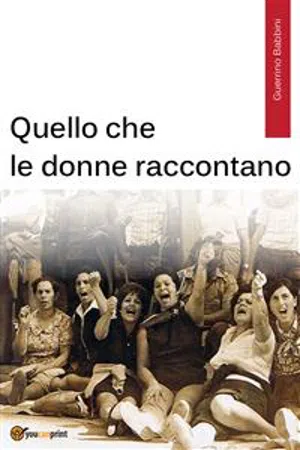![]()
Noemi
Via Olivetti a Leinì è a ferro di cavallo. Inizia e termina nella trafficata via Torino. Racchiude nel suo cerchio diverse case in un’atmosfera tranquilla, odorosa di tigli. La caratteristica di questa via è di essere tutta nell’ansa di una grande fabbrica, la ex Revelli, specializzata in carpenteria di precisione per pezzi di grandi dimensioni, come le ogive di aerei. Ora inattiva, destinata a divenire l’ennesimo supermercato.
Suono il campanello di Noemi, in un decoroso condominio.
Noemi non risponde. Eppure dovrebbe esserci. Devo portarle il programma di LiberaFesta al parco Ruffini di Torino.
Risuono. Si affaccia da un balcone al primo piano il suo vicino: «Noemi è qui, si fa misurare la pressione da mia moglie. Ti apro subito. Sali».
Noemi: Vuoi il caffè?
Le porgo il programma.
Noemi: Cum ela che non si chiama piu’ festainrosso?
Guerrino: Vogliono farci morire democristiani”
Noemi: E no! Mi devi portare anche alla festa dell’Unità, quando c’è Fassino, che gli voglio far vedere l’attestato che ha firmato nel 1984 al mio Berto, come anziano comunista iscritto dal ’45. A gal dig mi.
Guerrino: Io sono impegnato tutte le sere alla griglia per la festainrosso.
Noemi: Mi faccio portare da mio figlio Robledo, voglio vedere la faccia che farà Fassino.
Guerrino: Quando vieni al parco Ruffini? Mettiti d’accordo con Piera. Io non vi posso portare perché devo fermarmi fino a mezzanotte e oltre. Il lavoro nei giorni feriali finisce alle 23, dopo faccio promozione del mio libro. Non venite venerdì, sabato e domenica, nonostante il partito sia in crisi c’è sempre tanta gente, che quasi non ce la facciamo. Lunedì ho incontrato don Ciotti. Era appena arrivato da Palermo, dove aveva partecipato alla commemorazione del generale Dalla Chiesa. Ero fuori dal ristorante della griglia, dopo aver grigliato una sessantina di quarti di porco, avevo ancora il grembiule, mi ha salutato con affetto. Forse non aveva ancora mangiato quel giorno, oppure saluta così tutti. Ha fatto un dibattito su laicità e religioni con Maria Bonafede, moderatora della Tavola Valdese. Venerdì scorso c’è stato un dibattito sulla Tav. La direzione della festa aveva invitato Antonio Ferrentino, Marilde Provera, Giuseppe Joannas, sindaco di Bussoleno, ed anche Mario Virano, promotore di tutte le palle mediatiche sulla necessità dell’alta velocità attraverso le Alpi, commissario del governo per le infrastrutture nonché direttore dell’Osservatorio, nel quale verificano le possibilità che ha l’attuale linea Torino Lione e le previsioni degli sviluppi futuri del traffico sul famoso canale 5 e poi dice tutto il contrario di quanto è stato verificato concordemente. I toni erano accesi. I Valsusini non accettano di spendere tutti questi soldi, di rovinare la loro valle e le loro case, per portare il latte da Kiev a Lisbona più velocemente. E’ un progetto assurdo in questi tempi. Può essere solo funzionale alle tangenti.
Noemi: Mi piacerebbe venire a sentire, però non domani. Ho comprato al supermercato due sacchetti di riso, era vecchio e pieno di camole. Ho visto che c’era l’indirizzo del produttore, gli ho telefonato e gli ho detto che ho fatto la mondina e che di riso me ne intendo. Vengono a cambiarmelo domani.
Guerrino: A proposito, quand’è che mi racconti bene di quando facevi la mondina?
Noemi: Quando vuoi, ma bisogna raccontare tutto per capire quante ne ho passate.
Guerrino: Vengo domattina.
Noemi: Va bene. Vuoi il caffè? Lo faccio buono.
Guerrino: No. Devo andare subito a fare la spesa. Piera ha poca autonomia a camminare. L’hanno messa in lista anche per l’operazione all’anca destra.
Noemi: Fa bene a farsi operare, anch’io ho dovuto fare le protesi a tutte due le anche.
Il racconto di Noemi
Noemi: Sono nata a Pegognaga, piccolo paese agricolo della pianura mantovana, nel gennaio del 1928. A Pegognaga c’erano anche famiglie benestanti, proprietarie di case padronali e terreni fertili, lavorati dai braccianti e dai contadini che dovevano consegnare al padrone anche più della metà del raccolto. Io sono nata in una famiglia povera. Dieci figli, tra maschi e femmine. Mi è difficile ricordare l’ordine delle nascite. Ero la penultima. Mio padre, Ruggero, per il troppo lavoro faticava a ricordare il nome dei figli, tanto che all’anagrafe registrò mia sorella, l’ultima, con il mio nome: Cesarina. Così io sono sempre stata chiamata Noemi. Faceva il bracciante. Faceva due giornate ogni 24 ore. Tagliava erba, zappava, seminava, mieteva per diversi padroni e nei tempi in cui non c’era il lavoro dei campi faceva il paratore, con carro e cavallo trasportava merci da un paese all’altro. Era il lavoro dei mesi invernali: infatti lo ricordo avvolto nel suo tabarro.
Anche mia madre, tra un figlio e l’altro, faceva giornate nei campi perché le esigenze della famiglia erano tante. Quando mia madre lavorava nei campi i figli più piccoli erano accuditi dalle figlie più grandi. Toccarono a me ancora piccola, le faccende di casa, compresa la cottura della polenta. Per arrivare al paiolo dovevo salire su uno sgabello e quando la polenta era pronta, chiamavo una vicina che me la rovesciava sul tavolo. Salvo il periodo della mietitura, la mamma a mezzogiorno tornava a casa o alla mensa di Mussolini per le puerpere, dove mangiava solo il cibo che non poteva mettere nelle tasche per portarlo a noi. Per le tante maternità otteneva dal dottore la ricetta per la farina lattea. Con questa, e la polenta, ci facevamo le cene.
Tra i tanti lavori di mio padre ci fu anche il lavoro in una cooperativa di produzione del vino, di cui mio padre era un buon consumatore. Il presidente di questa cooperativa, che veniva da Carpi, chiese a mio padre di mandare una figlia da sua moglie, sfollata durante la guerra sul lago Maggiore. Andai io. A Milano fummo fermati dalle camicie nere. Il signor G., presidente della cooperativa, consegnando i documenti disse: «SS compagnia della morte». Lo salutarono con deferenza e si riprese il viaggio. Io cercavo di non far vedere la mia paura.
In quella famiglia mi trovai bene, lui non c’era mai e la signora mi voleva bene come ad una figlia. Non mi mancava niente, il cibo era abbondante. Mi affezionai al bambino, anche perché era poliomielitico, poverino. Poco dopo il mio arrivo si trasferirono a Luino in una villa meravigliosa, che si chiamava Villa Battaglia.
La mia casa
La casa che la mia famiglia affittava a Pegognaga aveva due camere da letto al piano di sopra, al piano terra la cucina, un altro locale e la scala. In questo locale c’era un letto per i fratelli più grandi.
Noi più piccoli dormivano quattro in un letto, due di testa e due ai piedi. I letti erano assi su due cavalletti. I materassi erano di foglie di pannocchie di granturco, che si appiattivano ogni notte e bisognava cambiarle ogni anno.
In cucina c’era la stufa per cucinare e riscaldare nei giorni invernali, un grande tavolo con sedie di legno. Completavano l’arredamento la credenza bassa e il tuler, dal quale si estraeva il tagliere per impastare il pane e la pasta. Questo mobile ci era stato regalato, ma la farina per utilizzarlo era poca.
I piatti si lavavano in un mastello. Un mastello più grande serviva per lavarci noi.
L’acqua andavamo a prenderla con i secchi alla fontana a pompa, poco lontano da casa.
Ero molto legata ai miei fratelli e sorelle, soprattutto alla sorella Berta che diverrà madre di 18 figli. Nei giochi con gli altri bambini del paese ci divertivamo, anche se eravamo poveri.
In inverno andavamo tutti, anche gli adulti, nella stalla della famiglia Nigrelli. Gli uomini giocavano a carte, le donne filavano e facevano maglie o calze di lana. Questa famiglia aveva due figli e una figlia. Il capo famiglia veniva arrestato tutte le volte che Mussolini passava a Milano o nelle vicinanze. Non era bello vederlo portar via dai carabinieri come una bestia.
A scuola feci solo la seconda elementare perché dovevo lavorare in casa, le mie sorelle erano già a servizio. L’istruzione era ritenuta un lusso per i poveri e inutile per le donne. In chiesa andavo con regolarità.
Ricordo le funzioni religiose e due preti, uno anziano e uno giovane, attivi nell’aiutare i poveri, ma ci giudicavano ignoranti. Frequentavo la messa ogni mattina presto, con lo scialle e gli zoccoli di legno tipo ciabatte che, d’inverno, non difendevano i piedi dai geloni. Andavo nella vicina chiesa di San Lorenzo, dedicata ai Caduti di tutte le guerre.
Mi allontanai dalla chiesa verso i tredici anni. Io ero povera e ignorante. I preti erano ricchi e stavano con i ricchi. Li vedevo fare il loro lavoro come un mestiere. Io continuavo a credere che Dio era dalla parte dei poveri. Chi aveva ammazzato Gesù Cristo erano i ricchi e i potenti di allora, perché Gesù Cristo voleva l’uguaglianza. Non mi sembrava giusto che i preti costruissero delle chiese ricche e lasciassero i poveri nella miseria. Ora sono convinta che Gesù Cristo non avrebbe abitato in Vaticano.
A otto anni andavo con mia sorella Berta a chiedere l’elemosina. Spingevamo una carriola per trasportare la farina di polenta che ricevevamo, mentre il pane e qualche uovo erano riposti in due sporte appese ai manici della carriola. Quanto freddo in inverno!
Mio padre partiva presto al mattino e tornava tardi la sera. Nella paga del suo lavoro c’era sovente il mangiare, altrimenti era una bocca in più, con cui a casa dividere il cibo scarso.
Tra i lavori fatti nell’infanzia ricordo la tanta acqua pompata per la moglie dell’orefice di Pegognaga. Il paese ha falde di acqua ricche di ferro e il bucato restava giallastro. L’orefice del paese aveva trovato nel suo giardino una vena di acqua chiara. Io con la pompa riempivo tanti mastelli e la signora mi pagava con una mela e un pezzo di pane.
Il padre dell’orefice forniva i pezzi di ricambio per le macchine trebbiatrici e il filo di ferro per legare le balle di paglia. Il filo doveva essere tagliato su misura e bisognava fargli un occhiello. Quanti occhielli ho fatto! Quando facevo questo lavoro mi invitavano alla loro tavola, che era ben fornita.
Feci per qualche mese la baby sitter ad una bambina, figlia di un professore delle scuole professionali. Mia madre, però, notò che la mia schiena si incurvava e mi portò dal professor Soldi, del Rizzoli, che aveva uno studio a Gonzaga. Il professore disse a mia madre: «Se lei ha una pianta piccola e la carica di un sacco bagnato, la pianta si piega. Lo stesso è per sua figlia portare i bambini».
Mi prescrisse un busto con stecche di alluminio e la schiena si raddrizzò. Ero più alta della mia età e magra come un chiodo. Avevo sempre fame.
A 11 anni andai a servizio dalla famiglia di un avvocato fascista, che ebbe un figlio ucciso dai partigiani. Lasciai questo lavoro dopo tre o quattro mesi perché non mi davano da mangiare. Per sfamarmi dovevo rubare il cibo al cane, che veniva sfamato con gli avanzi, prima di me.
Mia madre ci accompagnava nelle famiglie presso le quali prendevano servizio e stabiliva questi accordi: le figlie dovevano essere libere 40 giorni all’anno per andare a lavorare nelle risaie, mai uscire di sera e la paga passava lei a ritirarla a fine mese.
Aspettavo che mia sorella Claudia, che già aveva ereditato il posto di lavoro da Berta presso la famiglia Rangoni, si sposasse, così io avrei ereditato quel posto a mia volta. Il posto a servizio presso la famiglia Rangoni era molto ambito, perché erano brave persone e ci facevano anche il corredo per il matrimonio, infatti io e altre due sorelle ci siamo sposate con l’aiuto di questa famiglia. Claudia non si sposò subito, ma passò al servizio del figlio dei Rangoni, oculista, che abitava a Mantova e io, terza sorella, ebbi questo lavoro.
La famiglia Rangoni era titolare di una concessionaria Fiat. La signora Rangoni era stata camiciaia e al mio corredo fece delle asole molto belle. Quelle che avevo fatto io non erano perfette, e lei non voleva che il mio bucato steso fosse criticato.
Il marito aveva fatto fortuna prima come meccanico di biciclette e poi come venditore di macchine. Loro erano di buoni sentimenti, ma anche noi eravamo brave a lavorare e nel comportamento. Si presero cura anche della mia salute. Per uno spavento ebbi una preoccupante infezione a una ghiandola linfatica del collo, e dovetti essere operata. Lo spavento era conseguenza del mitragliamento di un ricognitore degli alleati, un piccolo aereo che chiamavamo Pippo.
I Rangoni avevano sovente ospiti importanti a tavola e io, nel mio bel grembiulino nero con il pizzo bianco, servivo e facevo bella figura. Mentre mi allontanavo dalla sala sentivo i commenti di ammirazione degli ospiti e i Rangoni dicevano di me: «Brava e onesta ragazza, grande lavoratrice, ma tanto comunista».
La domenica era il mio giorno di libertà, e con la bicicletta mi facevo 21 chilometri da Mantova a Pegognaga e ritornavo in servizio il lunedì mattina.
Anche quando tornavo a trovarli da sposata, mi ingozzavano di cibo e mi davano cibo da portare a casa, e sempre qualche vestito...